Materiali di lavoro per un corso di commento alla Ricerche Filosofiche di Wittgenstein tenuto nell'anno 1975. I testi numerati da I a VI si possono ritirare riuniti nell'unico file PDF intitolato "Commenti a Wittgenstein".
Gli sghibirizzi grafici inseriti nel testo sono dell'autore
Data di immissione in questo archivio: dicembre 2002
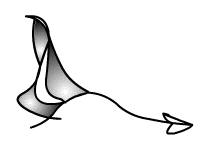
 Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
I.
Gli enigmi della denominazione
(Ric. Fil., oss. 1-35)
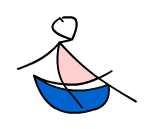
I.1 - Come abbiamo appreso il linguaggio
Il passo di Agostino con cui si aprono le Ricerche Filosofiche deve essere considerato in tutte le sue più piccole sfumature - ognuna può essere importante ed accennare ad un problema
Agostino descrive in breve in che modo si impara a parlare. Egli pone le cose in stile autobiografico: quando ero un bambino e non sapevo ancora parlare, ho fatto così e così - e così facendo ho imparato a parlare. Ma chi può realmente essere in grado di fare un simile racconto? Il ricordo non arriva sino a laggiù. Possiamo soltanto cercare di immaginare come stiano le cose in proposito. Anche nella filosofia è molto importante saper immaginare.
Ecco che cosa ne pensa il nostro santo. Il bambino non sa parlare. Tuttavia osserva gli adulti, e questi parlano. Ma per il bambino ciò significa soltanto che essi proferiscono dei suoni - e mentre lo fanno, fanno anche strane gesticolazioni: «muovono il corpo verso qualcosa»: corpus ad aliquid movebant. La vox - la parola come semplice suono, è accompagnata da certi gesti che accennano a qualcosa. Questa connessione deve essere o almeno diventare a poco a poco evidente (aperiebatur), affinché il significato della parola possa essere appreso. Così deve sussistere «un linguaggio naturale di ogni gente», debbono esserci parole «naturali» che non sono affatto parole ma gesti, attraverso i quali, per chi guarda le cose dall’esterno, e quindi anzitutto per il bambino che si trova ancora al di fuori del linguaggio possa apparire la connessione tra il suono che nomina e la cosa nominata. I gesti sono ad esempio movimenti delle mani, ma anche espressioni del volto, cenni degli occhi - tutto ciò con cui si esprimono le «affezioni dell’animo» - e quindi eventualmente anche l’intenzione designativa del nome rispetto alla cosa. Le parole ricorrono spesso in contesti differenti fino a quando il rapporto designativo viene appreso ed io stesso - bambino - imparo con questi segni a comunicare le «mie volontà».
Non è forse una descrizione convincente? In fin dei conti, noi possiamo spesso farci capire facendo uso solo di gesti. Può essere anche che per la comprensione effettiva di un’espressione verbale talvolta sia addirittura indispensabile l’appoggio di un gesto. D’altra parte è chiaro che la connessione tra la parola nel suo aspetto puramente fonico e l’oggetto designato può essere trasmessa al bambino solo nella misura in cui egli può osservare un comportamento complessivo nel quale diventa trasparente l’intenzione designativa della parola, il suo significato.
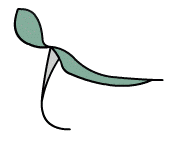
I.2 - Spunti per una critica
Sembra dunque ragionevole che il linguaggio lo si apprenda proprio così. Non è forse la stessa cosa per una lingua straniera? Forse. Oppure proprio di qui cominciano i dubbi? Le somiglianze, certo, ci sono. Ma vi è anche una profonda differenza. Quando apprendiamo una lingua straniera non solo sappiamo già molte cose sul linguaggio, ma siamo soprattutto installati dentro di esso. E si dovrebbe ritenere che sia già una cosa straordinaria il fatto che chi non sa parlare comprenda che l’altro parla, o addirittura che gli parla.
Pensiamo alla situazione nella quale veniamo a trovarci quando ci rechiamo in un paese la cui lingua ci è ignota. Allora, se qualcuno ci rivolge la parola, siamo subito consapevoli del fatto che egli intende comunicarci qualcosa. Che ne è ora del bambino quando un adulto gli parla? Io penso (immagino) che egli non comprenda che l’altro gli parla esattamente nello stesso modo in cui lo comprende il visitatore di un paese la cui lingua gli sia ignota. Infatti non vi è nel caso del bambino - immagino che non vi sia! - quel penoso senso di imbarazzo che tutti proviamo quando non comprendiamo le parole che ci vengono rivolte. Il bambino non se ne sta di fronte alla mamma con il pensiero «chissà che cosa mi dice»: egli comprende e non comprende, soprattutto non sa nemmeno di non comprendere, e questo cambia interamente le cose. In realtà il bambino è interamente immerso in un rapporto comunicativo - gesti, movimenti, suoni - e questo è molto singolare per il fatto che dobbiamo anche dire che egli è comunque fuori dal linguaggio a cui accede a poco a poco.
Esaminiamo ora più attentamente la spiegazione di Agostino. Si tratta di una effettiva illustrazione di un processo di apprendimento, o non piuttosto della proiezione in termini di una spiegazione sull’apprendimento del linguaggio di una determinata immagine della natura del linguaggio stesso?
La prima osservazione di Wittgenstein è in effetti questa: Agostino propone una «teoria» che riguarda il linguaggio stesso. In breve essa è la seguente: vi sono le parole e gli oggetti che esse denominano - le parole dunque sono in primo luogo nomi. Le parole entrano secondo regole nelle proposizioni più varie (variis sententiis locis suis posita). Il significato della parola è l’oggetto a cui la parola si riferisce. La parola, con il suo significato, sta al posto dell’oggetto. L’oggetto lo possiamo indicare con un dito - e per questo il significato della parola può essere appreso.
La critica di Wittgenstein contro questa teoria è forse tutta contenuta in questo semplicissimo commento:« Di una differenza di tipi di parole Agostino non parla». La descrizione proposta si attaglia infatti abbastanza bene alle parole che sono appunto nomi di cose additabili - tavole sedie armadi, Paolo Pietro Giovanni. Chi pensa che la natura del linguaggio possa essere descritta così ha probabilmente in mente esempi di questo genere. Eppure tutti sappiamo che vi sono parole che non hanno un significato nello stesso modo in cui lo hanno i nomi in genere e i nomi propri in particolare. Un verbo, ad esempio, qualche volta (ma non sempre) può essere mostrato con un gesto - ad esempio, il verbo «camminare» camminando. Ma già una simile indicazione gestuale ha un carattere interamente diverso dalla designazione nel senso in cui se ne parlava poco fa. Ci sono termini che indicano relazioni, ed anche le relazioni non sono indicabili nello stesso modo. Non posso mostrare a dito il fatto che una cosa si trova alla sinistra di un’altra. Vi sono parole che significano numeri ed entità astratte in genere. Oppure stati interiori, come fantasie, ricordi, desideri, emozioni. Per non dire di parole come «ma», «eppure», «benché» ecc.
Naturalmente si può benissimo supporre che chi sostiene un’immagine del linguaggio come fatta essenzialmente di nomi non ignori queste differenze. Si tratta piuttosto del fatto che, accingendosi ad elaborare una teoria del significato, egli pensa che sia opportuno puntare l’attenzione su quell’aspetto del problema in cui la relazione di significato sembra presentarsi nel modo più chiaro e vistoso, orientandosi subito verso il nome ed il rapporto di designazione. Si riconosce anche fin dall’inizio che vi sono delle difficoltà, ma si pensa che in seguito, cominciando di qui, le cose si accomoderanno.
Chiediamoci ancora: è poi giusto, per giustificare una simile presa di posizione, appellarsi alla prima infanzia? Attiriamo in proposito l’attenzione proprio sulle parole che manifestano stati interiori che sembrano entrare subito in urto con quella teoria. In essa il linguaggio viene implicitamente proposto come qualcosa che sta di fronte all’esteriorità del mondo, come se il suo compito primario fosse quella di fissare questa esteriorità e di fornire di essa una descrizione. Come se si trattasse anzitutto di prendere atto di ciò che sta a noi di fronte. Ma - ci chiediamo noi, e forse se lo è chiesto anche Wittgenstein - si è mai visto un bimbo prendere atto di alcunché? Il prendere atto di qualcosa non appartiene all’infanzia, e tanto meno alla primissima, a quella nella quale si entra con espressivi balbettii dentro il linguaggio. E’ molto probabile che si segua tutt’altra via - che sia importante l’atmosfera emotiva del gesto del suono della voce, della concreta situazione relazionale in cui si verifica il rapporto comunicativo, rapporto che è da subito strettamente intersoggettivo, vorremmo quasi dire: da interno a interno, essendo il «mondo» nient’altro che un momento di pura mediazione.
Tuttavia, se vogliamo seguire letteralmente il sentiero critico tracciato da Wittgenstein dobbiamo piuttosto insistere su considerazioni di ordine metodico. Altrove egli dice: «Una delle cause principali delle malattia filosofica - una dieta unilaterale: nutriamo il nostro pensiero di un solo tipo di esempi» (oss. 593). In questa osservazione si prende dunque posizione per una concezione della filosofia che fa di essa una riflessione libera, fluida, una elaborazione intellettuale nella quale assume una particolare importanza il riferimento ad esempi, che assolvono di volta in volta funzioni diverse, che talora introducono un problema o lo rendono visibile oppure indicano la via per una possibile soluzione. Se dovessimo indicare quale sia il metodo di Wittgenstein potremmo rispondere: ve ne è più di uno, ma uno particolarmente importante è il metodo degli esempi. Ma vi è anche il rischio che la situazione esemplificativa che ha attirato la nostra attenzione tenda anche ad assorbirla interamente, e quindi ci impedisca di scorgere altre vie possibili, altri problemi, altre soluzioni. L’esempio, che stimola il pensiero, può anche bloccarlo, irrigidirlo. Da questa presa di posizione deriva uno degli aspetti più caratteristici del modo di operare di Wittgenstein che consiste in un continuo spostamento dell’esempio. Il metodo degli esempi è anche un metodo di continua variazione di essi.
Tutto ciò lo si risente nella frase: «Di una differenza di tipi di parole Agostino non parla».
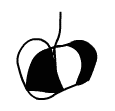
I. 3 Dal fruttivendolo
Gli accenni critici prendono sviluppo in un modo singolare. Si racconta una piccola storia, una piccola vicenda. Ecco un altro tratto caratteristiche dello stile filosofico di Wittgenstein. In tutte le Ricerche noi non troveremo mai un ragionamento bene organizzato, una discussione a distesa che presenti ordinatamente una determinata opinione con i suoi pro e contro. Ci imbattiamo invece di continuo in modi diversi di stimolare l’attenzione e la riflessione del lettore, che deve perciò sviluppare questi stimoli operando un ampliamento ed un approfondimento per conto proprio dei suggerimenti che gli vengono proposti. «Lascia al lettore ciò di cui è capace anche lui» - ammonisce una volta Wittgenstein (Pensieri diversi, p. 142). Questi stimoli possono avvenire anche attraverso spunti narrativi; oppure assumere l’andamento di scene teatrali minime. Talvolta si tratta di accenni di favole o di pure fantasie. La piccola vicenda di cui ora si narra rimanda invece ad situazione banalmente quotidiana. Si tratta di Tizio che va a comperare cinque mele da un fruttivendolo per ordine di Caio.
Ma in che modo curioso questa vicenda viene rappresentata ! Tutto il succo della storia sta effettivamente nella singolarità e nella stranezza della rappresentazione. Infatti non si dice soltanto che Tizio per ordine di Caio si è recato dal fruttivendolo ed ha acquistato cinque mele rosse. Si dice invece che Caio consegna a Tizio un biglietto con sopra scritto «cinque mele rosse» (scena prima); che Tizio si reca dal fruttivendolo e gli consegna il biglietto (scena seconda).
Occorre poi immaginare - e qui la faccenda diventa effettivamente un po’ strana - che il negozio del fruttivendolo non sia affatto come quelli che conosciamo, ma simile invece ad un ufficio tutto pieno di cassetti contrassegnati da etichette, con sopra scritto, «mele», pere", ecc.
La terza scena è interamente occupata dai comportamenti del fruttivendolo il quale, afferrato il biglietto, comincia con l’aprire il cassetto con sopra l’etichetta «mele». Tra le attrezzature di questo singolare negozio di frutta vi è anche una grande tabella, simile a quella impiegata nei negozi di vernici. Il fruttivendolo dunque utilizza un campionario di colori - accanto ad ogni strisciolina colorata vi è, anche in questo caso, un’ etichetta dove sta scritto rosso, verde, marrone, ecc. Egli cerca allora la parola «rosso» e guarda la strisciolina colorata che gli sta accanto. Guarda ancora nel cassetto e dice ad alta voce «1, 2, 3, 4, 5» ed ogni volta tira fuori dal cassetto una mela di colore corrispondente a quello del campione.
In realtà difficilmente si potrebbe riassumere tutto ciò dicendo che una comunicazione è stata scritta su un biglietto e trasmessa al fruttivendolo che, avendola compresa, si comporta di conseguenza. In effetti Wittgenstein evita una simile terminologia, non parla di comunicazione, di significati messi per iscritto e compresi nella lettura. E riesce a realizzare questa esclusione operando una sorta di straniamento della situazione quotidiana: come se tutto fosse compiuto da una macchina complessa, di cui ognuno degli attori e delle cose impiegate rappresenta un congegno. E’ strano che nessuno dei commentatori di Wittgenstein, abbia pensato, che io sappia, ad un moderno calcolatore. Eppure tutto avviene come in un «dialogo» tra automi - che dialogo non è affatto, ma che funziona esattamente come se lo fosse. Noi siamo in grado di dare istruzioni ad un calcolatore, ed il calcolatore è in grado di eseguirle correttamente, ma in ogni caso non le comprende (Come puoi esserne così certo? - mi si potrebbe chiedere...).
Si può anche immaginare di disporsi verso quella situazione nella forma di spettatori non partecipi: come se noi stessi fossimo degli extraterrestri giunti da un altro pianeta che, appena sbarcati dalla nostra navicella spaziale, osserviamo di nascosto il modo di comportarsi di questi esseri semoventi del pianeta terra. Vediamo dunque che Caio «scrive», Tizio porta il biglietto al fruttivendolo che lo «legge», apre e chiude i cassetti, consulta campionari di colori, ecc., ma «scrivere», «leggere» hanno per il visitatore extraterrestre il senso di puri movimenti, come aprire un cassetto che ha sopra lo stesso disegno che compare nel foglietto o estrarre da esso una mela, così anche il senso di puri suoni le parole «1, 2,...» recitate dal fruttivendolo nell’apertura del cassetto.
Sarei incline ad annoverare tra i metodi di Wittgenstein anche un simile effetto di straniamento: si guarda alla situazione inibendosi ogni legame che in qualche modo ci renda in via di principio compartecipi ad essa. Ecco un esempio riguardante il riso: «Due ridono insieme per una battuta di spirito. Uno ha usato certe parole abbastanza inconsuete e ora scoppiano entrambi in una sorta di belato. Tutto ciò potrebbe apparire molto stravagante a chi non sia di queste parti, mentre per noi è del tutto ragionevole». Con un rimando autobiografico: «Ho osservato questa scena poco fa in un autobus e ho potuto immedesimarmi in uno che non vi fosse abituato. La cosa mi è parsa allora del tutto irrazionale, come le reazione di un animale a noi sconosciuto» (Pensieri diversi, p. 142).
Questo effetto di straniamento serve soprattutto per mettere in evidenza un problema là dove non se ne vedrebbe alcuno. Se consideriamo l’azione di compravendita secondo questa descrizione ci rendiamo subito conto che non possiamo affatto concludere dal comportamento del fruttivendolo che egli ha compreso il significato della parola «mela»: infatti egli non fa altro che operare un confronto visivo tra un segno con un altro segno. Ma lo stesso vale per la parola «rosso»: anche in questo caso egli mette a confronto due segni grafici, confrontando poi il colore mostrato dal campionario con i colori che egli vede quando guarda le mele del suo cassetto. Il fruttivendolo poi conta veramente? Tutto ciò che sappiamo è appunto ciò che udiamo: il fruttivendolo che emette alcuni suoni accompagnati dal gesto di estrarre dal cassetto ogni volta una mela.
Mentre partecipando all’intera scena è per noi ovvio che ciò che avviene sia una comunicazione autentica che richiede in particolare la mediazione di processi mentali come il comprendere o il contare, non appena la poniamo a distanza mettendo in opera un effetto di estraneazione, appare chiaro, e nello stesso tempo un poco inquietante, che tutto potrebbe funzionare esattamente nello stesso modo, che il problema della comprensione e del significato potrebbe anche non essere posto. I protagonisti della storia potrebbero essere automi, oppure ci potremmo trovare in presenza di un unico automa nel quale all’inizio fosse immesso qualcosa di simile ad una scheda con dei segni sopra, e poi tutto va da sé - alla fine: ecco cinque mele rosse!
E subito affiora un complesso di interrogativi rispondere ai quali non è più affatto ovvio. Che cosa significa leggere un messaggio, comprenderne il senso, in che cosa consiste propriamente il significato di una parola e in che cosa il rapporto comunicativo?
In una storia narrata così, le parole intervengono come parti di un’azione complessiva, che potrebbe anche essere considerata come un meccanismo. Sembra allora che il problema del significato non si ponga neppure. Ma si suggerisce anche che il problema del significato deve essere posto proprio come un momento interno che funziona dentro una situazione complessiva che genera azioni e reazioni. Tuttavia non possiamo ancora trarre una conclusione. Le forbici del barbiere sono ancora in aria: «Delle proposizioni che qui trascrivo solo una ogni tanto fa un passo avanti: le altre sono come lo scatto delle forbici che il barbiere deve tenere in movimento per dare un taglio al momento giusto» (Pensieri diversi, p. 123).
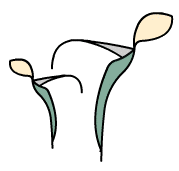
I.4 Il linguaggio delle quattro parole
Una nuova riuscita sforbiciata ci porta ad un’altra piccola storia - il cui attacco mette in questione l’eccessiva semplicità della concezione di Agostino, il fatto che essa è troppo primitiva ed inadeguata alla complessità del nostro linguaggio. Se è così possiamo immaginarci un linguaggio più primitivo del nostro, un linguaggio semplicissimo «per il quale valga la descrizione dataci da Agostino». Manco a dirlo, il linguaggio primitivo immaginato non si attaglia affatto letteralmente alla teoria di Agostino ma ha lo scopo esplicito di confonderla.
Si tratta del «linguaggio delle quattro parole» - mattone, pilastro, lastra, trave. Vi sono anche due attori, il muratore e il suo aiutante. E quando il muratore dice: «lastra», il suo aiutante gli porge una lastra, quando dice «mattone», gli porge un mattone, e così per il resto.
Anche in questo caso siamo di fronte ad una situazione quotidiana, in cui vi sono due persone che fanno qualcosa, e che facendo qualcosa si parlano. Le parole sono poi anche qui parti di un’azione complessiva e agiscono a loro volta all’interno di essa. L’effetto di straniamento viene ora ottenuto traducendo l’azione quotidiana in un’improbabile finzione, secondo la quale potremmo considerare il linguaggio delle quattro parole come un linguaggio completo, come se le quattro parole rappresentassero tutto il vocabolario di un linguaggio, ovvero, come si esprime Wittgenstein, «tutto il linguaggio di una tribù». Si affaccia qui un altro dei metodi di Wittgenstein, che si trova peraltro in una certa connessione con l’effetto di straniamento. Spesso ricorrono esempi puramente immaginari relativi agli usi e costumi di popolazioni lontane - in una sorta di esercizio di un’«antropologia» immaginaria. La figura del primitivo, che si muove in un contesto ambientale interamente diverso dal nostro e che ha usanze e credenze totalmente diverse, rappresenta per Wittgenstein un punto di riferimento significativo proprio a fini critici ed argomentativi. Di fronte ad una popolazione che non appartiene alla nostra cultura ci troviamo in un rapporto di reciproca estraneità, siamo gli uni rispetto agli altri degli extraterrestri.
Sull’azione a cui ora stiamo assistendo si possono compiere le più curiose congetture. In questo linguaggio semplificato, che è peraltro completo, ci sono solo nomi ed a quanto sembra essi designano appunto cose. Tutto ciò si attaglia alla descrizione di Agostino? Il primo punto da mettere in rilievo è che la parola è così strettamente legata all’azione che può essere difficile discriminarla da essa. Quando il muratore dice «lastra», questa espressione ci appare appunto soltanto come un suono che ha, come possiamo vedere, un determinato effetto. A quanto ne sappiamo può essere che queste azioni vengano accompagnate per consuetudine da vocalizzi come questi, e che il vocalizzo non significhi affatto una sorta di sostituto della cosa, di etichetta apposta su di essa. Il suo impiego comporta semplicemente questa conseguenza. In che senso allora potremmo parlare di nomi così come ne parla Agostino? In questo nuovo esempio, lo spunto teorico di Agostino viene dunque ampiamente problematizzato.
Ma è ormai tempo di avvertire che la citazione di Agostino serve certamente da spunto esemplare, ma è anche del tutto occasionale. Non bisogna lasciarsi distogliere da questo riferimento classico al punto da non vedere che ciò che Wittgenstein ha di mira, all’inizio delle sue Ricerche, è in realtà l’atteggiamento teorico che egli stesso aveva messo in opera nel Tractatus. Che l’essenziale del linguaggio siano proprio i nomi, questa è una delle tesi fondamentali della prima opera di Wittgenstein. In essa si sostiene che la proposizione - astrattamente considerata - va intesa come concatenazione di nomi, cioè di segni che designano oggetti. Le motivazioni particolari addotte da Wittgenstein a questo proposito sono ora irrilevanti; mentre è interessante notare l’atteggiamento di principio che sta alla base di quella decisione teorica. Porre l’accento sul rapporto di denominazione significa infatti richiamare l’attenzione sul rapporto tra linguaggio e mondo come un rapporto statico e speculare. Il linguaggio descrive il mondo. In quella prospettiva la soggettività che impiega il linguaggio come un linguaggio sempre integrato nelle funzioni della vita stessa deve restare ai margini. La polemica avviata da Wittgenstein ha dunque di mira la posizione che egli stesso aveva una volta sostenuto, così come ogni atteggiamento intellettuale che sia puntato prevalentemente nella stessa direzione. Cosicché assume particolare interesse il fatto che il problema del linguaggio e del significato venga proposto in maniera «drammatica»: ci troviamo subito infatti di fronte ad azioni, e dunque anche ad obbiettivi pratici che debbono essere conseguiti: ad esempio, se vi è un muratore e il suo aiutante, e se una lastra o una trave deve essere sollevata e spostata da un luogo ad un altro luogo certamente qualcosa deve essere costruito. È nel contesto di queste azioni e dei loro scopi che si impiegano anche parole.
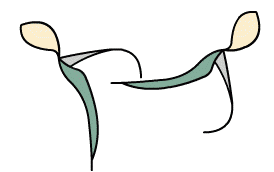
I.5 - Insegnamenti e giochi
La citazione di Agostino - sullo sfondo di una revisione delle idee del Tractatus - attira l’attenzione di Wittgenstein anche per il fatto che si appella alla situazione dell’infanzia, indipendentemente dalla giustezza o erroneità della concezione del linguaggio che viene poi suggerita. Nel Tractatus, non solo è dominante una concezione del rapporto linguaggio-mondo come un rapporto speculare, ma è di conseguenza esclusa o posta ai margini ogni possibilità di mutamento o di movimento. Il linguaggio non «diviene» - esso appare come già istituito, quindi come un sistema compiuto e definito. Diventa allora una questione marginale, che può forse interessare la psicologia del linguaggio, il fatto che esso sia appreso. Ora invece abbiamo cominciato a fare uso della nostra capacità di immaginare linguaggi, ed in particolare linguaggi primitivi, linguaggi cioè estremamente semplici, che possono essere considerati per questa loro semplicità come anteriori ai linguaggi evoluti. Tra questi linguaggi primitivi vi sono certamente anche quelle forme primitive del linguaggio impiegato dal bambino «quando impara a parlare» (oss. 5). Riconsiderando le cose da questa prospettiva ci sembra ora che le piccole storie che abbiamo narrato in precedenza possano essere intese come giochi infantili: come se ci fossero venute in mente guardando giocare i bambini.
Pensiamo a come potremmo insegnare ad impiegare la parola rosso ad un bambino molto piccolo, o la parola mattone o lastra; o anche a contare fino a cinque. Inventeremmo forse un gioco del tipo di quello del fruttivendolo o del muratore giocandolo insieme con lui. Forse, proprio perché nella prima infanzia la forma del gioco è dominante, il linguaggio si fa strada in questa forma. Giocando, il bambino si addestra al linguaggio.
Wittgenstein suggerisce allora di considerare la situazione esplicita di questo addestramento, quindi un gioco un po’ speciale, che ha ancora due attori, il maestro e il bambino, e che lo scopo sia quello di insegnare ad impiegare le parole.
Immaginiamo dunque di avere a che fare con il bambino che non sa ancora parlare, che, come dice Wittgenstein, non può ancora chiedere il nome degli oggetti. In che modo può allora avvenire il passaggio all’apprensione della parola e del significato? L’indicazione di Agostino era questa: il maestro «indica al bambino determinati oggetti, dirige la sua attenzione su di essi e pronuncia al tempo stesso una parola; ad esempio, pronuncia la parola ’lastra’ e intanto gli mostra un oggetto di questa forma» (oss. 6). Qui il gioco intende far funzionare la parola come un nome, e vi è un addestramento particolare per raggiungere questo scopo. Wittgenstein non nega affatto che questo sia un gioco possibile, ma ciò che ribadisce è che si tratta di una delle tante possibilità di far funzionare il linguaggio, uno dei tanti modi possibili di impiegare le parole. Non dobbiamo dunque dire che lo scopo della parola sia quello di designare oggetti, ma possiamo anche affermare che questo può essere uno dei suoi scopi. Ed il maestro può cercare di ottenere proprio questo tipo di associazione della parola alla cosa, cosicché essa possa essere considerata come una etichetta di essa, un suo rappresentante sul piano del suono o del segno scritto - egli insegna la presenza di questo rapporto mostrandolo. Ma come può mostrarlo? Subito si pensa ad una mano con il dito indice puntato. Invece egli farà ricorso a tutto un insieme di azioni differenti e convergenti nello scopo: punterà il dito sulla cosa, certo, ma forse farà anche in modo di far agire l’allievo, di fargli fare qualcosa, farà azioni per provocare reazioni, e di volta in volta muoverà la testa in senso approvativo o disapprovativo, e la mimica del volto annuncerà soddisfazione o insoddisfazione; varierà i contesti del gioco in modo opportuno, per far sì che il rapporto parola/cosa venga isolato indipendentemente dalla specificità del contesto, e così via. Questo insieme di azioni e di comportamenti è ciò che Wittgenstein è propriamente non una spiegazione del significato, ma un addestramento (Abrichtung) che si può caratterizzare come un «insegnamento ostensivo delle parole» (hinweisendes Lehren der Wörter).
In certo senso il gioco dell’insegnamento ostensivo differisce per un nonnulla da quello del muratore, anzi, possiamo semplicemente assumere già in rapporto a quell’esempio che ci fingiamo muratori per insegnare all’aiutante - il bambino - un contesto di impiego di quelle quattro parole. In base ad esso d’altra parte non è detto che le quattro parole vengano apprese come etichette appiccicate alle cose, come dei puri nomi.
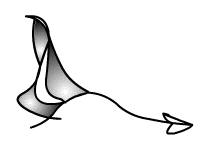
I.6 - L'insegnamento ostensivo
Ridurre l’insegnamento ostensivo dei nomi all’atto semplice del segnare a dito pone peraltro diversi problemi. Il bambino, come abbiamo detto, «non può ancora chiedere il nome degli oggetti». Il bambino dunque non solo ignora il nome di questa o quella cosa, ma non ne sa nulla nemmeno dello stesso rapporto denominativo. Se egli potesse formulare la domanda «Come si chiama questo o quest’altro?», evidentemente si troverebbe già dentro il linguaggio, per lui si sarebbe già costituito il rapporto di denominazione, cosicché anche l’indice puntato insieme alla parola avrebbe la portata di un gesto equivalente a quel rapporto e potrebbe essere compreso. All’inizio, non si tratta soltanto di mostrare il significato di una parola, ma anche che le parole hanno un significato.
Il segnare a dito è allora tutt’altro che un gesto chiaro e distinto. Puntiamo il dito sulla cosa ed emettiamo un suono: ma che cosa mai può capire il bambino? Deve forse ridere o piangere? Il dito puntato non significa nulla se non so che i nomi sono dita puntate.
L’insegnamento ostensivo non è dunque soltanto un indicare a dito come se la parola fosse «definita» mostrando la cosa. Io credo che Wittgenstein parli di «insegnamento ostensivo» contrapponendo questa espressione alla cosiddetta «definizione ostensiva», credo anzi che vi sia una sottintesa e vivace polemica contro questa associazione terminologica tra «definire» e «mostrare».
Cerchiamo di comprenderne le ragioni. Quando non conosciamo il significato di una parola, ne cerchiamo appunto la definizione in un vocabolario. Naturalmente in esso noi troviamo sempre dei sinonimi o dei giri di frase che hanno all’incirca lo stesso significato di quella parola. Se qualche espressione compresa nella definizione non ci è nota nel suo significato, allora procederemo esattamente nello stesso modo, ricercandone la definizione. Questa semplice considerazione ci fa concludere che dal vocabolario soltanto non potremmo apprendere il significato di nessuna parola: il linguaggio non è in grado di istituire da se stesso il proprio rapporto con il mondo. E’ dunque necessario riconoscere che vi è un livello extralinguistico che è di fondamentale importanza affinché il senso penetri nel linguaggio - e tutto ciò potrebbe essere inteso (si lascia giudicare a chi legge se a torto od a ragione) come una sorta di limite e nello stesso tempo come una circostanza abbastanza malaugurata. Lo intenderebbe certamente così coloro che tendono a mitizzare il riferimento al linguaggio come se ogni considerazione filosofica proposta in termini linguistici possedesse per questo stesso fatto una sorta di surplus di chiarezza e di perfezione. Assumendo un punto di vista che vede con sospetto il fatto stesso che si parli di un piano extralinguistico e che farà dunque ogni possibile sforzo per ricondurre ogni riflessione filosofica ad una riflessione su fatti linguistici, si comprende subito come possa essere ritenuta malaugurata la circostanza che l’intero apparato definitorio debba sostenersi su parole che sono state introdotte senza definizione alcuna.
Ed in che modo allora? In modo grossolanamente intuitivo, con vaghe gesticolazioni - addirittura!
Ora, a me sembra che l’espressione di «definizione ostensiva» che viene normalmente impiegata da logici e filosofi del linguaggio per indicare il gesto che mostra la cosa designata dalla parola cerchi di lenire questo apparente scacco. La parola definizione rimanda infatti ad un livello strettamente intralinguistico, e proprio per questo essa è in certo modo tranquillizzante per chi nutre simili inquietudini. Attraverso di essa si cerca di mitigare l’imbarazzo di quel vago gesticolare, la cui importanza e la cui presenza deve essere in ogni caso riconosciuta: senza quel vago gesticolare - se questo «mostrare» non vi potrebbe essere alcun «dire». Se riteniamo questa circostanza un poco malaugurata, l’espressione «definizione ostensiva» - con il contrasto interno che essa contiene - fa le corna al malaugurio. Pur sempre di definizione si tratta - benché consista in un «mostrare a dito». L’espressione di «insegnamento ostensivo», in cui il mostrare si riferisce a qualunque pratica sia messa in opera per far apprendere contestualmente il senso è certamente più aderente alle cose e più ricca di pensiero.

I.7 - Giochi linguistici
Tutti gli esempi, tutte le discussioni continuano a riproporre il linguaggio, le parole, in contesti di esperienza e di azione. Nelle scene del fruttivendolo e del muratore si rappresentava un agire con le parole. Ed un agire con le parole è certo anche il rapporto del maestro con lo scolaro. Inoltre tutti questi esempi possono anche essere intesi come giochi, assomigliano a giochi; e tutti questi giochi assomigliano al linguaggio stesso. «Li chiamerò ’giochi linguistici’ e talvolta parlerò di un linguaggio primitivo come di un gioco linguistico. E si potrebbe chiamare gioco linguistico anche il processo del nominare i pezzi, e quello consistente nella ripetizione, da parte dello scolaro, delle parole suggerita dall’insegnante. Pensa a taluni usi delle parole nel gioco del giro-giro-tondo. Inoltre chiamerò ’gioco linguistico’ anche tutto l’insieme costituito dal linguaggio e dalle attività di cui è intessuto». Questo è quanto si dice nell’oss. 7, nella quale viene introdotto il concetto fondamentale delle Ricerche Filosofiche, il concetto di «gioco linguistico». Il modo in cui esso viene introdotto è tuttavia sommesso, senza troppe spiegazioni, senza enfasi. I nostri «drammi» minimi - e in tedesco, la lingua in cui Wittgenstein scrive, dramma (rappresentazione teatrale) si dice anche Spiel - cominciano a suggerire che cosa dobbiamo intendere con «gioco linguistico» (Sprachspiel), ma certo dovremo attendere ancora prima di saper trarre di qui un vero profitto.
Intanto non perdiamo in ogni caso di vista la storia interna del problema. Nella prospettiva del Tractatus , nella quale si intendeva soprattutto mettere in evidenza una struttura logica profonda del linguaggio aderente alla stessa essenza del mondo, a Wittgenstein interessava soprattutto assicurare un vincolo tra linguaggio e realtà e nello stesso tempo il fatto che il linguaggio è una costruzione a partire da regole definite e concluse. Il linguaggio è anzitutto calcolo. Le letture logiciste del Tractatus non si avvidero che in esso era fortemente attiva una istanza formalistica - che forse non era sfuggita a Russell nel suo giudizio quasi sprezzante sulla filosofia della matematica del Tractatus. Proprio all’interno del formalismo matematico si impone l’analogia con il gioco, come del resto si era imposta nella riflessione linguistica e filosofica (De Saussure, Husserl).
Ma quale gioco? Questa precisazione è assolutamente necessaria. Si trattava regolarmente del gioco degli scacchi. Nell’oss. 3 si dice: «È come se qualcuno spiegasse: ‘il gioco consiste nel muovere cose su una superficie secondo certe regole...’ e noi gli rispondessimo: sembra che tu pensi ai giochi fatti sulla scacchiera: ma questi non sono tutti i giochi. Puoi rendere corretta la tua spiegazione restringendola espressamente a questi giochi».
In effetti, se ci atteniamo allo spirito di una concezione formalistica il gioco degli scacchi ci interessa per almeno tre aspetti che ci consentono di illustrare analogicamente la nozione di calcolo:
1. vi è anzitutto quella che potremmo chiamare la chiusura del gioco. Il gioco basta a se stesso - come Wittgenstein diceva della logica in genere - cioè non ha bisogno di nessun riferimento ad una realtà esterna ad esso. In questo senso lo spazio del gioco è uno spazio rigorosamente chiuso, non ha alcuna relazione con lo spazio che sta intorno: nulla ha a che vedere la superficie della scacchiera con la superficie del tavolino su cui essa poggia. Non vi è nessuna strada che conduce dall’una all’altra. Il pezzo del gioco è tale solo all’interno di questo spazio, sul tavolino è una cosa come ogni altra.
2. Negli scacchi i pezzi sono figure materiali, fatte di legno, di avorio o di altri materiali che nel loro nome o nella loro fattura rimandano a personaggi o a cose reali. Ma per quanto questo nome o questa fattura abbiano importanza in rapporto al piacere ed al fascino del gioco, essi sono del tutto indifferenti ai fini della sua realizzazione. I pezzi non solo si muovono secondo regole, ma sono anche niente altro che simboli di queste regole. La risoluzione del pezzo nella regola è un altro elemento che può essere considerato interessante all’interno di questo contesto.
3. Se i pezzi non sono altro che simboli delle regole, i giocatori non sono a loro volta che strumenti di esse. Nel gioco degli scacchi si affaccia dunque l’idea della deduzione formalmente intesa, del calcolo nella sua accezione generale: vi è infatti una disposizione iniziale dei pezzi della scacchiera ed ogni altra posizione è acquisita per applicazione iterata di regole ben definite. Il fatto che queste regole siano convenzionali è assai meno importante del fatto che chiunque voglia giocare a scacchi è tenuto ad applicarle.
Consideriamo ora l’idea del linguaggio alla luce di questa immagine. Il linguaggio è formato di parole - ma ciò che importa non sono le parole in se stesse, nella loro materia grafica o fonica, ma regole dalla cui applicazione sorgono le proposizioni: le parole sono dunque simili ai pezzi del gioco, le proposizioni alle configurazioni raggiunte nel gioco attraverso l’applicazione iterata delle regole. E come non abbiamo bisogno di stabilire delle corrispondenze tra pezzi e configurazioni e qualcosa che sta al di fuori del gioco stesso, così è possibile una considerazione puramente formale (sintattica) del linguaggio, nella quale vengono messi da parte i riferimenti di senso delle formazioni linguistiche.
È notevole, a mio avviso, il fatto che il mutamento radicale della concezione di Wittgenstein sia guidato dalla stessa immagine, dallo stesso riferimento illustrativo al gioco. Cogliere con chiarezza la componente formalistica all’interno del Tractatus è importante anche ai fini di rendere conto degli sviluppi successivi del pensiero di Wittgenstein. Questo si sviluppa infatti proprio in una costante riflessione intorno al formalismo, che si esercita in una grande varietà di forme sull’esempio del gioco.
Si comincia a prendere per buona questa analogia - il linguaggio-calcolo e il gioco degli scacchi - e ad elaborarla, per poi estenderla ed ampliarla. Non si tratta più soltanto del gioco degli scacchi, ma di questo gioco tra gli altri giochi possibili, dei giochi in genere. Nella filosofia possiamo proporre un’immagine in due modi molto diversi: da un lato a scopi illustrativi, per dare immediatezza ed evidenza intuitiva ad un’argomentazione o ad un concetto astratto, dunque come ausilio alle nostre spiegazioni o come un rafforzamento. Ma possiamo anche approfittare dell’immagine per «pensare attraverso di essa», facendo un impiego non più solo illustrativo rispetto ad un problema, ma produttivo ai fini della sua impostazione, della evidenziazione delle sue sfaccettature e degli sviluppi che possiamo trarre di qui. Decidiamo allora di lasciarci guidare dall’immagine, di lasciar fare ad essa, inseguendola poi con i nostri pensieri nei percorsi che essa propone. Ecco dunque un altro dei metodi di Wittgenstein, non esplicitamente teorizzati, ma certamente praticati a fondo: questo lasciar fare all’immagine, per ripensare ai problemi alla luce delle evoluzioni che essa compie.
In certo senso, l’autocritica di Wittgenstein rispetto al Tractatus comincia proprio quando, a partire dal tendenziale formalismo di quell’opera, l’immagine del gioco affiora ed egli decide di lasciarla fare.
Cominciamo a ragionare sull’immagine, ed attraverso di essa. Abbiamo detto or ora che le regole del gioco degli scacchi sono vincolanti. Ma questo vincolo è forse una necessità immanente alla cosa stessa, come se esistesse una natura profonda del gioco degli scacchi e le regole del gioco circoscrivessero una essenza immutabile? Le cose non stanno così. Il gioco degli scacchi non ha affatto un’essenza. Il vincolo delle regole rimanda ad un accordo tacito dei soggetti del gioco, e non ad una pretesa oggettività del gioco stesso. Quando il formalismo diventa esplicito e cosciente, quando comincia a funzionare l’analogia produttiva con il gioco, allora ogni tensione essenzialistica si sfalda, così come si sgretola il richiamo alla struttura della realtà come struttura assoluta. In particolare viene a cadere la funzione assolta dalla questione della contraddizione. Ora, essa viene ribaltata dal piano estremamente serio dei ragionamenti sulla possibile contradditorietà dell’aritmetica ovvero sulla necessità di provare la sua non contraddittorietà, a quello del gioco.
Per secoli e secoli si è sempre giocato a scacchi senza che mai nessuno abbia mai sollevato il problema di provare se le regole degli scacchi siano in sé intrinsecamente coerenti, senza preoccuparsi del fatto che prima o poi, inopinatamente ci potremmo trovare di fronte, giocando a scacchi, ad una situazione contraddittoria. Dovremmo forse ritenere un simile atteggiamento sconsiderato o imprudente? Suona strana la domanda stessa. Oppure ci siamo da tempo immemorabile comportati così perché si trattava soltanto di un gioco? Certamente no, perché anche in rapporto all’aritmetica, solo in tempi molto recenti il problema di una prova della sua coerenza intrinseca è diventato importante. Ma importante da che punto di vista? Non è forse vero che anche nel caso del gioco aritmetico per secoli e secoli non ci si è preoccupati affatto della sua possibile contraddittorietà, senza che ciò impedisse il successo e il costante sviluppo di quella disciplina?
L’analogia con il gioco produce lo smontaggio del problema della non contraddittorietà e la sua riconsiderazione da altri punti di vista che non sia quello di ottenere garanzie e fondazioni assolute.
Ci dobbiamo chiedere: che cosa potrebbe voler dire imbattersi in una contraddizione nel gioco degli scacchi? Oppure: come ci comporteremmo se ci imbattessimo in una contraddizione nel gioco degli scacchi? Ma poi anche: perché sempre e monotonamente il gioco degli scacchi? Non vi sono forse molti altri giochi assai diversi da questo e che possono non meno di questo insegnarci molte cose intorno al linguaggio? Perché nutrirsi di questo unico tipo di esempi?
L’immagine del gioco, liberamente sviluppata, apre nuove possibilità. Essa non ci consente soltanto di proporre e nello stesso tempo di smitizzare il linguaggio come calcolo, ma di delimitare un simile modo di considerare il linguaggio come una possibilità tra altre. L’immagine del gioco può anche richiamare la nostra attenzione sull’integrazione del linguaggio in un contesto di azioni. La concezione sintattica viene in certo modo ancora mantenuta, ma con la differenza che ora nella sintassi intervengono in un unico inviluppo gli attori del dramma e le cose su cui agiscono. Il concetto di sintassi deborda dal piano linguistico a quello extralinguistico, o meglio: i limiti che separano l’un piano dall’altro diventano indefiniti, e il momento del senso si fa nuovamente avanti come parte del contesto complessivo.
Muovendo da un presupposto formalistico e in certo modo con le sue stesse armi, ovvero seguendo gli sviluppi interni dell’immagine del gioco, perveniamo ad una prospettiva interamente diversa e per certi versi opposta. In una concezione formalistica l’aspetto propriamente sintattico-grammaticale deve subito essere chiaramente distinto dall’aspetto semantico. Anzitutto vi sono i segni, i pezzi del gioco, che non significano nulla al di fuori del gioco stesso, che hanno solo un significato-di-gioco, un significato che si risolve nella regola. Ad essi possiamo apporre una semantica, istituendoli come segni di qualcosa d’altro, come nomi.
Nella nuova concezione il linguaggio appare invece fin dall’inizio invischiato con la realtà, e la realtà stessa è qualcosa di interamente diverso da un aggregato di oggetti a cui vanno ad annodarsi le corde del significato. Proprio per questo occorre prestare attenzione all’espressione «gioco linguistico» evitando un fraintendimento: essa non deve essere intesa come se l’aggettivo «linguistico» delimitasse il tipo di gioco. Non si intende un gioco fatto di parole: al contrario con quella espressione si vuole in primo luogo caratterizzare un punto di vista nel quale le parole stesse sono integrate in un’azione più ampia. Il filo rosso che giunge sino al fondo delle Ricerche Filosofiche e che comincia a snodarsi fin dalle primissime osservazioni è l’idea che «immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita» (oss. 19).
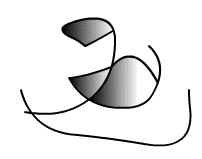
I.8 L'eterogeneità dei modi del senso
Per non perdere il bandolo della matassa che Wittgenstein va ora sbrogliando ora imbrogliando, è certamente opportuno tentare di operare dei raggruppamenti delle osservazioni, cercando di individuare delle cadenze, dei respiri, dei punti di pausa e di sospensione. Una cesura può essere certamente posta alla settima osservazione proprio perché essa introduce il termine di «gioco linguistico».
Un nuovo raggruppamento potrebbe raccogliere insieme dalla proposizione ottava alla proposizione diciottesima. A suo modo si tratta di un gruppo unitario che riprende i temi ed anche gli esempi delle osservazioni precedenti. Il tema principale è ancora quello del rapporto di designazione, intorno al quale cominciano tuttavia a gravitare altri temi che ne estendono la portata.
Non vi è ormai più bisogno di ripetere che affrontando il problema della designazione Wittgenstein mira ad una critica della teoria di un rapporto semplice tra il nome e la cosa, in base al quale il nome è come un cartellino appiccicato all’oggetto denominato (oss. 15). Si tratta ora di fare un passo oltre, cominciando con l’avanzare gli spunti per un’elaborazione positiva.
Così l’esempio del linguaggio del muratore e del suo aiutante che - come abbiamo notato - può anche essere un gioco e ha direttamente a che vedere con la tematica dell’apprendimento - viene ora ripreso con alcuni arricchimenti: si introducono i numerali in forma di lettere alfabetiche, alcune parole importanti nella comunicazione come «là» e «questo», così come quei «campioni di colore» che già avevamo visto svolgere una funzione nel gioco del fruttivendolo.
Evidentemente in questi arricchimenti si tratta di mostrare la varietà e la differenza, l’ «eterogeneità» dei modi del senso (oss. 10). Tutte le parole in questione hanno un senso, ma non nello stesso modo. Questa eterogeneità viene nascosta dal fatto che possiamo dire che i numerali designano numeri, «lastra» e «mattone» designano queste cose, «qui» designa il luogo che occupa colui che parla, e così via. La possibilità di impiegare lo stesso verbo implica certamente qualche affinità, ma occorre rendersi conto sino a che punto queste affinità possano essere spinte.
Nell’analogia con la cassetta degli utensili (oss. 11), si fa notare che in essa si possono trovare un martello, una tenaglia, un metro, colla, viti e chiodi. Tutte queste cose si dicono strumenti, ad esse si può dare questo nome comune. Ma molto differenti sono i loro impieghi.
I vari comandi che si trovano nella cabina di una locomotiva (oss. 12) hanno un aspetto molto simile, sono fatti all’incirca nello stesso modo, e «ciò è comprensibile, dato che tutti debbono essere afferrati con la mano». Ma ogni maniglia ha effetti diversi, e la locomotiva si muove nel gioco di tutte queste diverse funzioni.
Talvolta possiamo prestare attenzione alle somiglianze ed operare assimilazioni. Wittgenstein non dice mai che non si debba fare questo. Ma l’accento cade prevalentemente sul rischio che si corre nel compiere queste assimilazioni quando esse coprono nette differenze nel modo di impiego: «assimilando in tal modo l’una all’altra le descrizioni degli usi della parola non si rendono per nulla simili questi usi» (oss. 10). «Ma con questa assimilazione dell’espressione si sarebbe guadagnato qualcosa?» (oss. 14).
Anzi, non solo non si guadagna nulla, ma si rischia di rimetterci: di introdurre la confusione, di far sorgere problemi male impostati e malamente risolti. Affiora così il problema dell’«analisi del linguaggio» come metodo della riflessione filosofica: l’impiego delle parole non ci sta davanti in modo evidente. E «specialmente non, quando facciamo filosofia!». Di qui consegue certamente che la chiarificazione intorno ai modi di impiego delle parole fa parte dei metodi della filosofia. Essa non è «il» metodo della filosofia, l’unico metodo autentico - idea fin dall’inizio attribuita a Wittgenstein e che ha «fatto scuola». Si tratta invece di un’idea che a mio avviso, gli è profondamente estranea. In Wittgenstein vi è una pluralità di metodi - lo abbiamo già più volte ribadito. E del resto anche l’«analisi del linguaggio» si situa qui ben oltre il piano di una questione puramente metodologica, per mettere in causa importanti aspetti di contenuto.
A questo proposito si possono raccogliere alcuni spunti cominciando dal problema dei numerali (oss. 9 e 10). Sullo sfondo vi è la questione di una illustrazione del concetto di numero e di una teoria del numero che per quanto non sembri occupare in quest’opera uno spazio significativo, continua tuttavia ad essere presente. L’esempio dei numerali non è soltanto una possibile illustrazione della varietà dei modi della designazione genericamente intesa, ma esso intende anche dire: se vuoi elaborare una giustificazione filosofica del numero non devi lasciarti guidare da considerazioni di filosofi che operano false assimilazioni concettuali: seguendo questa via si potrebbe essere tentati di considerare i numeri come entità a sé stanti, come oggettività in sé, come mattoni eterei. Devi invece pensare all’insegnamento ostensivo del numero, al modo in cui l’impiago delle parole di numero viene mostrato ai bambini e da essi viene appreso. È certo infatti che anche qui, come nel caso dell’introduzione primitiva delle parole, si tratta anzitutto di mostrare qualcosa. Ma nemmeno in questo caso si tratta di un semplice mostrare indicativo, di un «segnare a dito». L’indicazione può valere - forse! - per i numerali più piccoli, che potrebbero essere presentati come nomi di «gruppi di cose che possono essere afferrati con lo sguardo» (oss. 9). Ma ben presto l’apprendimento dovrà legare il numero alla successione - ad una successione recitata durante una determinata azione compiuta su cose.
Se diciamo che i numerali designano numeri, allora sembra abbastanza inevitabile che i numeri siano concepiti come entità che ci stanno di fronte esattamente come una lastra o un mattone. In questo caso il parlare di designazione suscita incertezze perché potremmo avere dubbi sul fatto che sia giusto concepire i numeri in questo modo; e del resto non vorremmo nemmeno essere costretti ad assumere che i numeri debbano essere concepiti così per il solo fatto che ci esprimiamo in questo modo.
Pensando ad un possibile «insegnamento ostensivo» è comunque certo che non potremmo mostrare i numeri come oggetto di riferimento dei numerali. Non sapremmo infatti come dovremmo gesticolare. Eppure non vi è dubbio che anzitutto l’insegnamento dovrà essere ostensivo. Si mostrano i numerali e si mostra il loro uso. Si potrebbe proporre ad un bambino il gioco del fruttivendolo, invertendo di tanto in tanto le parti. In questo modo si insegna a fare qualcosa con i numerali e quanto alla designazione, ci disinteressiamo del tutto della questione. Si insegna dunque a compiere una certa azione, a dire, insieme ad essa certe parole, uno, due, ecc. E questo è tutto. L’indicare una cosa è un’azione come il sollevarla o lo spostarla; ma vi è evidentemente una differenza. Indicando una cosa non facciamo proprio nulla con essa. Sembra difficile mostrare il significato di un numerale senza manipolare cose, senza un fare in senso proprio.
L’insegnamento ostensivo procede in un modo se deve insegnare il significato della parola «lastra», in un altro se deve insegnare il significato della parola «cinque». Così se diciamo che l’una e l’altra parola hanno un significato, dovremmo subito notare che non lo hanno nello stesso modo. Nulla ci impedisce peraltro di affermare che «cinque» designa un numero e «lastra» una lastra. Possiamo essere consapevoli che il rapporto designativo ha una molteplicità di aspetti differenti - benché si corra il rischio di false assimilazioni. La generalità del rapporto di designazione deve essere ricondotta alle particolarità dei modi di impiego, e ciò evidentemente fa tutt’uno con lo spostare l’ottica del discorso dal linguaggio ai giochi linguistici, entro i quali diventa realmente visibile il modo di funzionare delle parole.
Il riferimento all’insegnamento ostensivo ed all’apprendimento infantile della successione numerica ha, a mio avviso, anche una diversa inclinazione: non si tratta solo di attirare l’attenzione sui modi di impiego, ma anche di suggerire che, ai fini di una chiarificazione filosofica del concetto di numero, più che ad elaborate costruzioni logiche dovremmo regredire ad una dimensione nella quale dell’aritmetica e della logica non sappiamo ancora nulla. Ed il «modo e la maniera» in cui si costituisce la parola numerica deve offrirci chiarimenti importanti sulla natura del concetto corrispondente. A me sembra di cogliere in questo la possibilità di un punto di contatto ricco di senso con la tematica fenomenologica relativa ad una chiarificazione dei concetti che «regredisce» al piano «antepredicativo».

I.9 Proposizioni abbreviate e parole allungate
Oggetto di problematizzazione sono anche le distinzioni grammaticali correnti (oss. 19-25). Si pensi alla distinzione tra proposizione dichiarativa e proposizione imperativa. O addirittura tra proposizioni e parole. In quest’ultimo caso si potrebbe dire: la parola è una parte della proposizione e la proposizione è un complesso di parole. A questa distinzione si accenna già nella citazione di Agostino: in essa si parla infatti di «verba in variis sententiis locis suis posita»: il verbum è ciò che occorre nella sententia, e precisamente è disposta in essa nel luogo appropriato.
Tutto chiaro, a quanto sembra. Eppure nel gioco linguistico del muratore ci si può chiedere «‘Lastra!’ è una parola o una proposizione?».
Supponiamo che qualcuno risponda: una parola, certamente - non vi è dubbio su questo punto.
Netta, e suggestiva, l’annotazione di Wittgenstein: se è così allora deve trattarsi di una parola che ha un senso completamente diverso da quello che questa stessa parola ha nel nostro linguaggio perché in quel gioco linguistico essa è un grido. È importante rammentare sempre che il linguaggio delle quattro parole è stato assunto come un linguaggio completo - e ciò significa non solo che esso non possiede altre espressioni, ma anche che non è da intendere come se fosse una piccola parte del nostro linguaggio. Perciò nel testo si parla non a caso di un grido, e non di un ordine: all’interno di quel linguaggio infatti ci sono solo parole gridate e non - mentre non vi sono proposizioni imperative e dichiarative. Naturalmente se, presupponendo il nostro linguaggio, facciamo valere una simile distinzione, allora potrebbe sembrarci più giusto parlare di «Lastra!» come di una proposizione imperativa abbreviata. Ci si potrebbe tuttavia ancora chiedere che cosa sia propriamente quella espressione restando rigorosamente all’interno di quel linguaggio. Ma anche facendo riferimento al nostro linguaggio, che «Lastra!» sia una espressione abbreviativa della proposizione imperativa «Portami una lastra!» per Wittgenstein non è affatto evidente. «Ma perché non dovrei dire, viceversa, che la proposizione ’Portami una lastra!’ è un prolungamento della proposizione ’Lastra!’». Un rovesciamento del problema che ci coglie di sorpresa. Eppure muterebbero di molto le cose se adottassimo quest’altro punto di vista?
Si potrebbe ancora protestare: chi dice «Lastra!» intende in ogni caso che gli si porti una lastra. E Wittgenstein di rincalzo: che cosa significa intendere in questo caso? Diciamo forse dentro di noi la proposizione più lunga? Certamente no. In realtà intendiamo che mi si porti una lastra appunto con il grido «Lastra!» e per intendere ciò non vi è bisogno della proposizione «Portami una lastra» e nemmeno di assumere che quel grido sia una sua abbreviazione. Gridando «Lastra!» voglio che mi si porti una lastra, ma questo volere «non consiste nel pensare, in una forma qualsiasi, una proposizione diversa da quella che tu dici», e tu dici appunto niente altro che «Lastra!».
La messa in questione della distinzione tra proposizione dichiarativa e imperativa potrebbe anche presentarsi in questa forma: che cosa contraddistingue una proposizione (vogliamo considerarla tale) come «cinque lastre» per informare qualcuno che qui ci sono cinque lastre oppure quando la usiamo per farci portare cinque lastre? Nella scrittura in questo secondo caso metteremmo un punto esclamativo, nel parlato probabilmente alzeremmo il tono della voce. L’unica differenza sembra consistere dunque in un modo diverso di emettere gli stessi suoni.
Domande analoghe si potrebbero avanzare in rapporto alla distinzione tra proposizione dichiarative e interrogative. Del resto già nell’uso quotidiano ci sono ben note forme come: 1. «Non è meraviglioso il tempo oggi?». Domanda o dichiarazione? 2. «Vorresti far questo?» - Domanda, ma può assumere forma di ordine. 3. «Lo farai»: potrebbe ben essere un modo di ordinare a qualcuno di fare qualcosa - una sorta di futuro imperativo (oss. 21). Tuttavia sarebbe erroneo che qui si voglia solo mettere in evidenza l’elasticità e la plasticità espressiva del discorso corrente. Vi sono anche esempi del tutto fittizi, come quando si ipotizza un linguaggio in cui ogni asserzione è formulata nella forma di una domanda seguita da un «si» o da un «no» («Piove? Si», «Piove? No») (oss. 22), il cui unico interesse, a quanto sembra sta proprio nell’allontanare l’idea che una simile riflessione riguardi usi consueti e comuni. A maggior ragione è il caso di chiedersi: a che scopo un simile rimescolamento delle carte?
Intanto non vi è dubbio che qui Wittgenstein miri anzitutto a confonderci. Ciò che sembra si voglia mettere in dubbio è che il linguaggio abbia una struttura in qualche modo ben determinata. Di fronte alla chiara distinzione tra parola e proposizione, facciamo di tutto per renderla ambigua e controversa. E nell’argomentare non si rifugge dall’assumere posizioni estreme. Si fa avanti anche il sospetto di un’operazione puramente scettica. Ricorrendo ai mezzi più vari - non escluse argomentazioni che volentieri cercheremmo di respingere come puri sofismi - sembra si persegua lo scopo puramente negativo di introdurre la confusione dove c’era prima nella nostra testa una passabile chiarezza. Se qualcuno sostiene di sapere distinguere tra cosa come interrogazioni, ordini, accertamenti, constatazioni - gli si propone subito un esempio «critico» tratto dal discorso corrente o anche liberamente inventato e che richiede improbabili contesti.
Qualcuno ora grida «Aiuto!» (cfr. oss. 24), mentre sta annegando nel fiume. Ed il filosofo seduto meditabondo sulla riva passa in rassegna le varie possibilità. Si tratta forse anzitutto di un’esclamazione. Quella parola la scriveremmo infatti con il punto esclamativo. Tuttavia non negheremmo certo che in quel grido sia contenuto qualcosa di simile ad una domanda o ad una implorazione. Occorrerà allora senz’altro introdurre un nuovo tipo di proposizione «implorativa»? O forse dovremmo annoverare questa parola-proposizione tra gli ordini, dal momento che sentiamo che ci viene detto in modo impellente di fare qualcosa? Infine non c’è dubbio che si fornisce anche una semplice informazione: «Io sto annegando».
Di fronte al problema della distinzione tra le forme grammaticali che è naturalmente anzitutto un problema di una differenziazione concettuale, sembra che si voglia alzare scetticamente le spalle: fai come vuoi. Nel gioco del muratore puoi dire che «Lastra!» è una proposizione oppure che è una parola. Puoi addirittura dire che è l’una e l’altra cosa insieme. Oppure che è una proposizione abbreviata, ma puoi anche dire che la proposizione «Portami una lastra» è una parola allungata. Ed infine può anche darsi che un simile problema non sorga nemmeno, che nessun si sogni di fare simili domande.
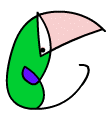
I. 10 Introspezione
Questo andirivieni che sembra descrivere un andamento scettico si ritrova qui, come ovunque nelle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein. Ma io credo si tratti di uno scetticismo orientato dall’intenzione di portare chiarezza là dove la chiarezza è solo apparente. Il compito preliminare dunque è dunque quello di dissolvere questa apparenza.
A questo proposito occorre anche non lasciarsi fuorviare dal fatto che spesso ciò che si suggerisce nel corso dell’argomentazione è proprio ciò che si intende confutare. Talora si mimano infatti modi di rendere conto delle distinzioni contro cui in realtà Wittgenstein intende polemizzare. Ciò vale in particolare per le spiegazioni introspettive - che sono proposte come temi per una critica che qui comincia con l’affiorare e che attraversa tutte le Ricerche Filosofiche.
Potremmo dire in generale che ci troviamo di fronte ad un problema affrontato «mediante l’introspezione» ogni volta che esso venga proposto secondo la formula seguente: «Che cosa avviene dentro di te (dentro la tua testa) quando...(percepisci, ricordi, leggi, pronunci una proposizione, una certa parola, ecc.)». Si tratta di una caratterizzazione troppo semplice, certamente - ma essa coglie il punto essenziale che interessa le nostre considerazioni. Così la problematizzazione della distinzione tra proposizione dichiarativa ed imperativa indica in negativo che di essa non si può rendere conto attraverso considerazioni psicologizzanti. Non arriveremo da nessuna parte se ci chiediamo «che cosa avviene dentro di noi quando diamo un ordine» e nemmeno se - richiamando l’attenzione sul fatto che la differenza di tono nella voce è indispensabile in molti casi a contraddistinguere l’ordine della constatazione - proponessimo poi di istituire quella differenza proprio sul tono della voce. Così i dubbi intorno alla nozione di proposizione ellittica, servono soprattutto a chiarire che l’espressione «lastra!» è ellittica «non perché essa ometta qualcosa che intendiamo quando la pronunciamo, ma perché è abbreviata rispetto ad un determinato modello della nostra grammatica» (oss. 20).
Attraverso i dubbi si fanno avanti dei chiarimenti. La differenza tra uso descrittivo e l’uso imperativo di «cinque lastre» non sta nel tono della voce, ma nella funzione che la stessa espressione assume in giochi linguistici diversi. Qui è un ordine, là una constatazione (oss. 21).
Una domanda può essere posta nella forma di una constatazione. Ma ciò non può far sì che i giochi linguistici differenti siano stati sovrapposti gli uni agli altri in modo da renderli indistinguibili.
I percorsi argomentativi puntano altrove rispetto a ciò che poteva sembrare all’inizio. Ora cominciamo con il renderci conto che si mira proprio all’istituzione di differenze. La stessa adozione del punto di vista dei giochi linguistici può essere utilizzata come un metodo per mostrare differenze.
Certo, l’intera tematica deve mantenere una profonda mobilità. Ci sono molti tipi di proposizioni (oss. 23). Quanti? Diciamo che sono veramente molti, e per il resto non vogliamo impegnarci. Questo, perché il linguaggio è qualcosa che di continuo si muove. L’accento che cade sulla differenza deve anche cadere sulla mobilità, su una sorta di incompletezza di principio: «E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. (Un’immagine approssimativa potrebbero darcela i mutamenti della matematica)». A quella piccola postilla in parentesi occorre dare molta importanza. La stessa osservazione potrebbe cominciare così: Quanti tipi di numeri ci sono? Molti. E molti forse restano ancora da inventare.

I.11 Nomi e concetti
L’attribuire nomi alle cose potrebbe esser assimilato all’attaccare alla cosa un cartellino su cui è disegnato un contrassegno. «Spesso, mentre filosofiamo, si rivela utile dire a noi stessi: denominare una cosa è come attaccare ad un oggetto un cartellino che reca il suo nome» (oss. 15). Questa immagine sembra suggerire che i nomi da insegnare per primi siano quei nomi che chiamiamo normalmente nomi propri, perché questi sono in effetti concepibili come contrassegni individuali, che spettano alla cosa contrassegnata e solo a quella. I nomi comuni potrebbero venire insegnati «in un secondo tempo» sulla base di qualche caratteristica comune degli individui già denominati con nomi propri. In questa forma comincia ad affacciarsi una discussione intorno a ciò che nella filosofia si chiamano concetti.
Questo inizio tuttavia non deve essere inteso come se già avessimo trovato una strada da imboccare a capofitto: si tratta invece di mettere alla prova questa teoria dei due tempi - prima i nomi propri, poi i nomi comuni, ovvero: prima gli individui, poi i concetti.
Supponiamo dunque di imbatterci per la prima volta in un cane - la prima esperienza senza un passato, di cui talvolta parlano i filosofi empiristi. Sembra naturale ritenere che essa debba essere intesa come l’esperienza di qualcosa assolutamente individuale. Non abbiamo mai visto nulla del genere, e così non possiamo denominarlo con un nome comune, dal momento che non si è ancora formato per noi un concetto sotto cui ricondurre quello strano individuo. Gli attribuiamo allora un nome proprio che contrassegna proprio lui e lui soltanto.
In una breve novella di Kafka compare come protagonista una sorta di strano rocchetto, un essere che non sapremmo dire se animato o inanimato, che per alcuni aspetti ha il carattere di una macchinetta, ma sembra anche muoversi di volontà propria, e forse sa addirittura dire qualche parola. I concetti sotto cui potrebbe essere sussunto non sono concordanti. Lo chiamiamo Odradek, e questo sembra essere un nome proprio. Se incontrassimo altri individui simili a questo, cioè se incontrassimo altre cose che hanno qualche caratteristica comune con questa, potrò rappresentare il concetto sotto cui Odradek sarà sussunto.
Un’immagine del linguaggio che attira l’attenzione anzitutto sulla priorità dei nomi propri suggerirebbe una teoria del concetto orientata in questa direzione. Ma non potrebbe darsi invece che nell’esperienza ipotizzata come «primitiva» di un cane non fossimo colpiti anzitutto da una tipicità (ad es. quello che fa bau bau) e che già da subito il cane venga inteso come individuo all’interno di un genere di cui esso stesso ha suscitato il pensiero?
Conviene dunque rimettere nuovamente a fuoco la problematica della denominazione. Come abbiamo visto, in rapporto a certi giochi linguistici essa potrebbe non essere nemmeno proposta. Ad esempio, il chiedere «come si chiama questo» non è un’azione inclusa nel gioco del muratore o del fruttivendolo. Inversamente, potremmo immaginare un gioco linguistico particolare nel quale quella domanda abbia una parte. Possiamo pensare ad un gioco di società che potrebbe consistere nell’inventare un nuovo nome per gli oggetti (oss. 27). Anche in questo caso le prime mosse mirano alla dissoluzione del problema. La questione della denominazione potrebbe essere tanto poco importante e tanto particolare quanto lo è un gioco di società. L’apprendere il linguaggio consiste nel denominare oggetti? Certamente no. E tanto meno la denominazione rappresenta una condizione per poter parlare delle cose.
E per rendere controverso il problema della denominazione si sollevano dubbi sull’effettività della distinzione tra nomi propri e nomi comuni. Ma si tratta in realtà di manovre per una messa a fuoco.
Così si ammette senz’altro che possa essere insegnato ostensivamente non solo il nome di una persona - che è l’esempio più ovvio di «definizione ostensiva» - ma anche di un colore, di una sostanza, di un numero, ecc. (oss. 28). Certo, con qualche complicazione: l’insegnamento ostensivo deve essere interpretato, il gesto inteso nel modo giusto.
"Questo si chiama ’due’" - diciamo indicando due noci. Questo è un modo perfettamente possibile di «definizione ostensiva» del numero due (oss. 28). Ma l’allievo potrebbe intendere «due» in vari modi: ad esempio come il nome proprio delle noci; oppure come il nome di un numerale, come se le due noci fossero un equivalente della cifra «2» tracciata su un foglio di carta. Così se dico «Questo si chiama seppia» puntando il dito verso Caio potrebbe non essere chiaro se intendo «seppia» come nome proprio di Caio oppure se voglio dare un nome al colore della sua giacca.
Le distanze rispetto alla concezione delineata all’inizio si mostrano sempre più nette. Si prospetta anche la possibilità che la determinazione concettuale debba in qualche modo precedere la sua possibile specificazione (oss. 29). Si osserva così che è una considerazione alquanto astratta del linguaggio pensare che anzitutto si istituisca il rapporto denominativo e poi la grammatica del nome, e cioè il modo in cui viene usato.
Attaccando un cartellino alla cosa «ci si prepara all’uso della parola. Ma a che cosa ci si prepara?» (oss. 26). La portata di questo interrogativo va chiaramente compresa. Con i nomi noi facciamo qualcosa; mentre la denominazione non dice che cosa dobbiamo fare con un certo nome: «mostrando a qualcuno il pezzo che rappresenta il re nel gioco degli scacchi e dicendogli "Questo è il re» non si spiega l’uso di questo pezzo..." (oss. 31). Una cosa è indicare come si chiama un pezzo degli scacchi a qualcuno che non sa nulla sul gioco degli scacchi. Un’altra è intendere il pezzo di legno già come pezzo di quel gioco ed allora la stessa indicazione ha un senso interamente diverso. Nel primo caso ci troviamo di fronte alla denominazione come un gioco linguistico fine a se stesso e chiuso in se stesso, proprio come nel caso del gioco di società che abbiamo inventato poco fa. Nel secondo caso invece la denominazione è un gioco linguistico entro un gioco linguistico più ampio nel quale sono già presenti i modi di impiego della parola nuovamente introdotta.
Di qui l’affermazione, di cui si avverte ora tutta l’importanza, secondo cui «chiede sensatamene il nome solo colui che sa già fare qualcosa con esso» (oss. 31). Si vuole così sottolineare che un qualche apparato concettuale (e quindi linguistico) deve essere presupposto nel momento in cui introduco un nome. La funzione denominativa si trova già dentro questo apparato. «La definizione ostensiva spiega l’uso - il significato - della parola quando sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere, in generale, nel linguaggio» (oss. 30). Ed ancora: «Per essere in grado di chiedere il nome di una cosa si deve già sapere (o saper fare) qualcosa» (oss. 30).
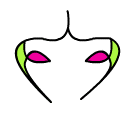
I.12 Nomi e concetti
Anche parole che non sono nomi propri possono essere apprese ostensivamente. Lo abbiamo già detto. Ad esempio, la parola «azzurro».
Abbiamo anche notato che non basta puntare il dito su una cosa azzurra e pronunciare questa parola. L’indicazione ostensiva deve essere interpretata, e ciò significa che deve essere colta l’intenzione che fa corpo con il gesto dell’indicazione. Il gesto indicativo non è qualcosa di simile ad una freccia che istituisce una sorta di raccordo tra una cosa (il segno) ed un’altra (ciò che il segno designa), per quanto l’immagine della freccia possa sembrare a tutta prima appropriata. Infatti la «cosa» che il segno designa può essere un tavolo o una sedia, ma anche una loro proprietà: la forma del tavolo o il suo colore. Questo si chiama circolo, dico intendendo la forma circolare del tavolo - e la segno a dito. Oppure: questo si chiama azzurro, intendendo il suo colore - e lo segno a dito. Ma il cenno dell’indicare segnando a dito va sempre in direzione del tavolo - in qual modo potrei nel gesto intendere ora la forma ora il colore?
Sarebbe erroneo tuttavia ritenere che in osservazioni come queste si tenda a mettere in risalto le possibili equivocità dell’insegnamento ostensivo. Di queste possiamo benissimo venire a capo in un modo qualunque. Le equivocità interessano in quanto attraverso di esse intravediamo dei problemi. Il problema è qui anzitutto che nell’indicare ostensivo è intrecciato un atto dell’intendere, e nello stesso tempo che questo atto non può essere risolto - come si sarebbe subito tentati di fare - in elementi psicologici che accompagnino l’indicazione. La critica che è stata già avviata di spiegazioni introspettive comincia a ricevere qui qualche sviluppo.
In particolare va notato che il problema dell’intendere, pur essendo introdotto nel quadro della problematica dell’insegnamento ostensivo, è tuttavia indipendente da esso e del resto - credo di poter aggiungere - da una considerazione tutta interna al problema del linguaggio. Ora guardo la forma del circolare del tavolo o il suo colore - in questo atto del percepire vi è già un intendere. Che cosa guardi? Il colore del tavolo - è la risposta. Questa risposta tuttavia non si presenta filosoficamente troppo ovvia. Intanto non è possibile che ciò che vedo sia soltanto il colore. Potremmo dire: io vedo il tavolo nel suo insieme, e le cose che gli stanno intorno, ma ciò che guardo è quel colore. E preciso: ciò a cui presto attenzione. Ma allora il problema semplicemente si sposta. Dobbiamo rendere conto di ciò che significa questo «prestare attenzione», e forse saremmo tentati di procedere proprio in una direzione psicologizzante. Se vogliamo sapere che ne è di questo «prestare attenzione» dobbiamo forse stabilire che cosa avviene centro di noi quando abbiamo questa esperienza vissuta del guardare il colore, ovvero del prestare attenzione a questo piuttosto che a quello. Esperienza vissuta traduce Erlebnis e compare per la prima volta nell’oss. 34 nelle Ricerche Filosofiche: lo stretto legame con la problematica dell’introspezione mostra che il termine viene impiegato in un’accezione totalmente diversa da quella in cui essa compare per lo più nella fenomenologia di Husserl. In essa infatti Erlebnis è l’esperienza vissuta in quanto è in via di principio analizzabile come atto intenzionale. Le implicazioni di ordine propriamente psicologico vengono messe da parte. Ma a parte questa differenza nell’impiego del termine, anche Wittgenstein è interessato a separare l’analisi filosofica dall’analisi introspettiva: cosicché il problema dell’intendere nel suo complesso viene affrontato secondo uno stile prettamente fenomenologico.
Gli spunti introspettivi hanno dunque carattere polemico. Che cosa significa prestare attenzione alla forma e non al colore? Per rispondere a questa domanda potremmo pensare di auto-osservarci per vedere che cosa accade mentre facciamo questo. Ognuna potrà dire la sua, a questo proposito. Può essere che avvertiamo una sorta di movimento degli occhi che accennano a seguire il contorno della cosa; oppure qualcuno potrebbe parlare di una sorta di curiosa spinta interione, una tentazione a seguire il contorno con un dito; ma per altri la tentazione sarà forse quella di socchiudere gli occhi in un modo del tutto particolare... Ciascuno per proprio conto potrà trovare qualche sensazione interna caratteristica che interviene quando intende la forma piuttosto che il colore, o inversamente. Questa molteplicità che rischia di confondere l’intero problema è tuttavia una conseguenza di una interpretazione psicologizzante del «prestare attenzione» proposto come un tentativo di illustrazione dell’ «intendere». La risposta autentica alla richiesta di «guardare dentro di noi per accertare che cosa accade quando...» sta nel rifiuto di considerare la questione da questo lato: oltre al fatto che intendo la forma e non il colore, non accade null’altro. O meglio ancora: qualunque cosa accada oltre all’intendere, è del tutto indifferente - e possiamo usare l’espressione del «prestare attenzione» al più come sinonimo dell’«intendere», e non come una riconduzione dell’intendere ad un contenuto psicologico identificabile introspettivamente.
Che cosa accade quanto intendo il re degli scacchi non più come un pezzo di legno, ma come un pezzo di gioco? Non accade nulla al di là del fatto che ora lo intendo così (oss. 35).
Questa posizione si fa valere nella problematica del significato, ma si apre ad una prospettiva molto più ampia. Alla fine della oss. 35 in parentesi si suggeriscono parole come riconoscere, desiderare, ricordarsi...
Si intravedono infatti subito analogie problematiche. Che dire, ad esempio, del desiderio? Se ci poniamo sulla via di un’analisi introspettiva, dovremo interrogare Pietro o Paolo su che cosa accade all’uno o all’altro ogni volta che desidera qualcosa. Pietro ad esempio, se guarda dentro se stesso, avverte una misteriosa sensazione che egli descrive dicendo che si tratta qualcosa di simile ad un sospiro inespresso. Si esprime proprio così: «Mi sembra che la mia anima sospiri». Tutto questo lo abbiamo saputo da lui. Paolo, più concreto, sostiene invece di avvertire un senso di mancanza, di vuoto, che è assai simile alla fame. Chi si sentirebbe di contraddirli? Essi sono gli unici testimoni di se stessi. Quanto a noi potremmo a nostra volta proporre altre sensazioni e altre descrizioni.
Ma il desiderio non è l’anima sospirante di Pietro e nemmeno la fame di Paolo.
Wittgenstein coglie in modo assai netto l’irriducibilità degli atti intenzionali a sensazioni soggettive accessorie - ed è questo appunto il tratto comune con un modo di pensare fenomenologico. La pars destruens tuttavia prevale nettamente sulla pars construens. La critica «antipsicologistica» non si traduce in una proposta di analisi sistematica ed a tutto campo della varietà dei modi di intendere e della loro struttura.
