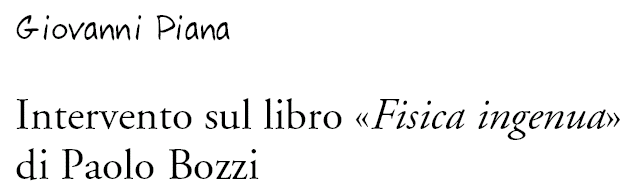Intervento all'incontro-dibattito con Stefano Jacomuzzi, Corrado Mangione e Giovanni Piana, alla presenza dell'autore, in occasione della pubblicazione del libro Fisica ingenua di Paolo Bozzi. Casa della Cultura, Milano, 21 novembre 1990. Il testo di riferimento è: Paolo Bozzi, Fisica ingenua. Oscillazioni, piani inclinati e altre storie: studi di psicologia della percezione, Garzanti, Milano, 1990. Di qui è tratta la figura di copertina che illustra lo schema del meccanismo utilizzato per variare il periodo di oscillazione dei pendoli impiegato da Paolo Bozzi nei suoi esperimenti sulla percezione del moto pendolare. - Pubblico gli appunti di questo intervento come omaggio all'amico fraterno scomparso nel novembre del 2003.
![]() Intervento sul libro 'Fisica ingenua' di Paolo Bozzi (458.33 kB)
Intervento sul libro 'Fisica ingenua' di Paolo Bozzi (458.33 kB)
Questo testo è ora stato pubblicato nei "Frammenti epistemologici". E' stato citato ad esempio qui (Paola Giacoboni)
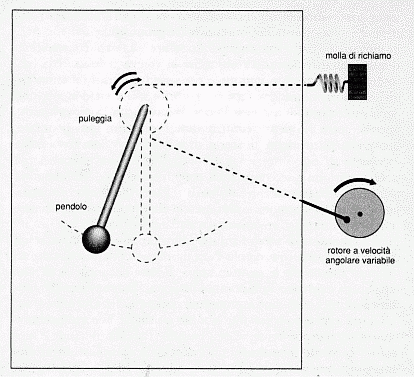
1990
In questo mio intervento sulla Fisica ingenua di Paolo Bozzi, vorrei subito proporre qualche elemento di riflessione e di discussione, facendo riferimento ad alcuni pochi temi, evitando la tentazione di immergermi nell'effettiva ricchezza di problemi a cui l'autore ci introduce. Questa ricchezza, questa capacità di stabilire con sorprendente facilità nessi tra terreni apparentemente lontani tra loro è certamente uno dei motivi del grande fascino di questo libro - ed essa è strettamente legata alla sua forma letteraria. Su di ciò voglio dire soltanto questo: in realtà io ho sempre avuto una certa nostalgia per le ordinate distinzione tra i generi e per le forme, per così dire, classiche: per il grande trattato con le sue materie ben suddivise, e dunque anche, nel mio specifico campo di lavoro, per il sistema filosofico con l'S maiuscola che esige una forma espositiva certamente piuttosto severa e fortemente strutturata. Di conseguenza ho sempre nutrito un vago sospetto nei confronti dell'elemento diaristico e autobiografico, quando esso viene mescolato con le questioni della scienza e della filosofia che mi sembrano appartenere agli altri, piuttosto che all'autore. Ma voglio ora proprio dire che questo libro, che mescola l'elemento autobiografico e narrativo alla discussione scientifica ed al dibattito teorico, è un'opera straordinaria, un'opera eccezionale, e fa realmente piacere usare ogni tanto con convinzione aggettivi come questi, che spesso vengono evitati dai recensori solo in nome di un falso pudore. La scelta letteraria compiuta da Bozzi raggiunge un risultato così perfetto e mostra una tale necessità interna da far venire meno qualunque perplessità di principio.
Mi sembra giusto cominciare a parlare di un tema che rappresenta una sorta di filo conduttore interno della storia che qui viene narrata: si tratta del tema dell'esperimento, dell'attività dello sperimentare. In proposito non intendo riferirmi soltanto ai numerosi esperimenti che vengono descritti e discussi con grande chiarezza e che dànno corpo alla tematica centrale del libro, ma anche a tutte quelle annotazioni disseminate nel testo che, da diversi punti di vista, dànno la massima pregnanza e vivezza all'idea stessa dello sperimentare. L'esperimento, che può apparire come una sorta di marchingegno interno ad un marchingegno più ampio, un apparato dentro il più ampio apparato della scienza, si presenta invece in primo luogo e in generale come un vero e proprio modo di stabilire un contatto con la realtà, un modo di saggiarla, di metterla alla prova, anche quando sperimentare significa soltanto e semplicemente osservare, guardare. Paolo Bozzi riesce a trasmetterci in pochi tratti la natura complessa di questo sguardo - come quando parla dell'occhio «che non si stanca di seguire la sconcertante traccia di un movimento stroboscopico nel buio tra i due estremi della sua traiettoria rettilinea e intanto il pensiero legato ad esso giocherella futilmente con la domanda 'Cosa diavolo potrei fare per incurvare quella traiettoria?'»; uno sguardo dunque che è tutto meno che una pura ricezione passiva del reale, ma che contiene riflessioni fulminee, domande e pensieri: uno sguardo che fruga il reale come quello del botanico, che nel testo è una figura del ricordo che tende ad assumere una sorta di profonda esemplarità; ma che è anche, questo sguardo, «materializzazione di una curiosità ammirata» nella quale è presente la «gioia immediata di vedere e di comprendere», di cui parla Einstein facendo riferimento a Mach (cfr. p. 158).
Nello sperimentare c'è invenzione e immaginazione, c'è il progettare e il costruire, c'è meraviglia e passione; c'è soprattutto la tensione osservativa attraverso la quale dobbiamo talvolta accorgerci di ciò che abbiamo sempre veduto e di cui non ci siamo mai accorti; in esso non ci sono scopi, o meglio non ci sono utilità immediate e immediatamente a portata di mano - un tema questo che affiora più di una volta in contrapposizione a quell'altra tensione, di tutt'altro genere «che si guarda intorno con attenzione per scovare tra le pieghe dell'attualità contingente qualche opportunità gratificante o qualche leva per agire sulle cose o sugli altri» (ivi).
Inteso in questo modo lo sperimentare può avere origini lontane ed apparentemente anche al di fuori della scienza e dei suoi compiti. Per ricercare le sue radici possiamo addirittura risalire al gioco infantile, o più precisamente a quei giochi in cui si mettono alla prova gli stessi nessi del reale in una sorta di libera variazione operata sul reale stesso, in cui si vuol vedere che cosa accade se invece di questo rapporto ci fosse quest'altro: i giochi infantili con le parole, illustrati nel capitolo quarto del libro intitolato «Nomi e cose», rappresentano un bellissimo esempio, ma non il solo. Anche il pittore, ad esempio, quando si accinge a riempire la sua tela, mette qualcosa alla prova, fosse anche soltanto questo o quell'accostamento cromatico; e così il musicista nel suo comporre con i suoni si pone il problema di che cosa accade quando... quando quei determinati suoni risuonano in una successione oppure simultaneamente, quando sono distribuiti secondo certi intervalli temporali, piuttosto che secondo altri.
Io credo che lo sperimentare possa assumere un simile significato per ragioni che chiamano in causa sia il tema centrale del volume, sia il metodo con cui esso viene affrontato.
Sia per l'uno come per l'altro, cioè sia per la nozione di fisica ingenua che per quella di fenomenologia sperimentale, il filosofo viene chiamato in causa, o almeno si sente chiamato in causa, ed io credo per buone ragioni; così come viene messo in questione l'intero problema del rapporto tra filosofia e psicologia, e più determinatamente tra filosofia fenomenologica e psicologia fenomenologica, ovvero, come si potrebbe anche dire, tra fenomenologia pura e fenomenologia empirica. In Paolo Bozzi vi è ovunque una grande consapevolezza di queste implicazioni filosofiche, ed essa appare in primo piano laddove ci parla di Hume o di Cartesio, e soprattutto di Aristotele e di Galileo, con una vivacità, una chiarezza ed una penetrazione che ci fa comprendere di più di molti commenti specialistici.
Già il titolo del libro dà il destro ad una discussione: Fisica ingenua. In rapporto ad esso vorrei proporre qualche elemento di perplessità confortato del resto dall'impressione che l'autore stesso lo accetti in certo senso in forza di una consuetudine ormai consolidata che forse non vale la pena di mettere in questione. Eppure vi è qualcosa in questo titolo di non aderente alla natura del problema, qualcosa di riduttivo e forse persino di profondamente equivoco.
L'operazione essenziale compiuta da Bozzi non è infatti quella di mostrare la presenza di opinioni più o meno false nella nostra conoscenza quotidiana delle leggi della meccanica, e tanto meno quella di riconoscere la presenza di pretese sopravvivenze di una cultura anteriore: l'operazione importante e significativa è invece quella di ricondurre queste «opinioni» (che peraltro si possono chiamare così solo impropriamente) a regolarità direttamente colte sul piano percettivo e precisamente sul piano visivo. In altri termini, vi sono concezioni sulla caduta dei gravi, sul movimento pendolare, sulla traiettoria dei proiettili che dipendono strettamente da condizioni che sono in realtà necessarie affinché un determinato risultato percettivo abbia luogo.
In certo senso l'idea di una fisica ingenua - cioè l'idea di concezioni effettive, di opinioni vere e proprie, di un'inclinazione del modo di pensare - è un'idea secondaria, nel senso che queste concezioni ed opinioni possono essere considerate come una sorta di eco, di riflesso di situazioni visive concrete: è possibile addirittura assumere che le risposte fornite dagli osservatori, ad esempio, sulla traiettoria della caduta dei gravi, sia realizzata semplicemente attraverso la visualizzazione della situazione percettiva corrispondente. Ciò viene spiegato da Bozzi già nel primo capitolo del volume.
Non è certo possibile qui nemmeno accennare al rilievo che questo modo di porre il problema ha non solo dal punto di vista percettologico, ma anche dal punto di vista della problematica epistemologica ed in particolare dei rapporti tra scienza ed esperienza. Fino a pochi anni fa questi rapporti sembravano liquidati da ovvietà sul sapere prescientifico come luogo di opinioni prive di fondamento, di conoscenze cosiddette intuitive intese come rozze approssimazioni legate ad una nozione di buon senso peraltro mai chiarita, così come era moneta corrente l'idea che la «concezione del mondo» - il nostro modo di vedere il mondo, nel senso letterale ed elementare del termine - sarebbe pronto a modificarsi ad ogni mutamento dei quadri categoriali di conoscenza della realtà.
La novità nella posizione del problema non sta per nulla nell'idea di un'altra fisica - quindi di un'altra «teoria» anche intendendo questo termine nella sua forma più debole come «insieme di opinioni» - ma sta nella scoperta di alcuni interessanti problemi di fenomenologia della percezione. La ragione per cui mi sembra che il titolo di fisica ingenua possa essere equivoco sta nel fatto che fa pensare invece ad una sorta di fisica parallela. Mentre se si riconsidera secondo l'angolatura proposta dall'autore ad esempio la problematica aristotelica del movimento, la tesi che emerge da questa discussione è soprattutto quella di una particolare prossimità di quella problematica alla dimensione dell'esperienza del movimento.
Considerando le cose da questo punto di vista, assumono subito rilievo due grandi problemi che la dizione di fisica ingenua tende a mettere in ombra: da un lato il problema di un mondo dell'esperienza che ha le sue forme e i suoi nessi strutturali, quel mondo costruito su quelle percezioni che sono, dice Bozzi, «l'unica realtà tangibile che inequivocabilmente ci sia data» (p. 153) - un mondo all'interno del quale si forma, secondo regole in realtà sufficientemente determinate, un intero complesso di concettualizzazioni primarie o, se vogliamo di prime concettualizzazioni; dall'altro il problema dello sviluppo che conduce da queste concettualizzazioni primarie a concettualizzazioni di grado superiore, e necessariamente di nuovi metodi di formazione dei concetti che tendono a prendere sempre più le distanze dall'immediatezza dell'esperienza e infine a tagliare il nodo con essa.
A me sembra che si debba dare la massima evidenza all'ampiezza dello spazio teorico che fa da sfondo a questo problema della «fisica ingenua». Per questo desidero attirare l'attenzione sul capitolo terzo nel quale si mostra che il tema della percezione del movimento non è ritagliato all'interno di una sorta di duplicazione ingenua della fisica o della scienza della natura in genere, come se, oltre ed accanto ad una meccanica ingenua ci dovessimo aspettare lo sviluppo di un'ottica ingenua, di una chimica ingenua o di un'astronomia ingenua come possibili discipline psicologiche - ma è ritagliato invece all'interno del tema generale dell'espressività dei dati esperiti. Questo capitolo intitolato Qualità terziarie ha una particolare importanza per comprendere l'impianto teorico del volume. Detto in breve, ciò che Bozzi sostiene è non solo che possiamo parlare fondatamente di una maggiore o minore naturalezza di un moto pendolare, espressione che non ha alcun senso dal punto di vista fisico, ma anche che la maggiore o minore naturalezza di un moto pendolare è da annoverare tra i tratti espressivi - come quelli che possiamo cogliere nel volto di una persona o nel gesto di una mano.
Proprio la consapevolezza che lo sfondo sia questo mostra la necessità di un raccordo con la fenomenologia filosofica. Dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di uno strutturalismo fenomenologico specificamente rivolto all'elaborazione di una filosofia dell'esperienza, questo raccordo, nel mantenimento di una precisa delimitazione reciproca, è del tutto a portata di mano. Ho l'impressione invece che per Bozzi esso non appaia troppo auspicabile - forse per via di un brutto incontro con una fenomenologia della percezione «troppo filosofica» com'è quella di Merleau-Ponty, o più in generale per il fatto che proprio alcune tematiche fenomenologiche come quella del «mondo della vita» che potrebbero in realtà a buon diritto essere richiamate a proposito delle ricerche di Bozzi sono state spesso sommerse da quelle «ciacole» da cui gli psicologi della percezione soprattutto si guardano e da cui in realtà farebbero bene a guardarsi anche i filosofi.
Comunque ne sia, mi sembra di notare una certa circospezione da parte di Bozzi ad estendere il problema in questa direzione, un certo sospetto nei confronti di chi parla tanto di una visione libera da pregiudizi, di messa in parentesi, di epoché ecc., senza essersi mai posto il problema di una visione effettiva all'interno di una situazione sperimentale sufficientemente determinata. Questo sospetto è più o meno giustificato secondo i casi, secondo i problemi, secondo ciò che vogliamo esattamente sapere. Ci sono domande che non possono trovare una risposta se non attraverso la progettazione di una situazione sperimentale; ve ne sono altre a cui occorre invece aver dato preventivamente una risposta per la stessa impostazione e progettazione di una situazione sperimentale. Per illustrare in due parole la questione, vorrei rammentare il caso esemplare del rapporto tra la celebre argomentazione di Hume sulla causalità e gli esperimenti descritti da Michotte nel suo volume sulla percezione della causalità. In realtà Hume non è mai stato confutato dagli esperimenti di Michotte: e questo per il semplice fatto che egli era già stato confutato dall'affermazione di Michotte proposta nell'introduzione al volume, là dove si dice che noi vediamo «il coltello che taglia il pane», e non un certo movimento del coltello e della mano ed una fessura che si apre in concomitanza con quel movimento. Questa affermazione appartiene alla «fenomenologia pura» - oppure, detto in altro modo, essa non poggia su esperimenti, ma su una riflessione intorno alla «grammatica filosofica» del verbo tagliare. Ed in proposito vanno rammentate le illuminanti osservazioni di Paolo Bozzi sul rapporto tra linguaggio ed esperienza, sintetizzate nella frase secondo cui il linguaggio comune «è il linguaggio tecnico dell'esperienza percettiva» (p. 177 e p. 301): formulazione bellissima che meriterebbe ben altro che una simile rapida menzione.
Concludo con un richiamo al tema dello sperimentare con cui si erano aperte queste mie considerazioni. In precedenza abbiamo parlato della pregnanza che assume l'idea dello sperimentare in Paolo Bozzi, assunta in un'accezione molto ampia e generale. Ma egli ha una propria concezione della sperimentazione più tecnica, più specifica, e che riguarda proprio la sperimentazione nel campo dei fenomeni di movimento e in generale in quello delle «apparenze» fenomenologiche - una concezione che nel volume viene lasciata trasparire più che essere apertamente teorizzata. Gli esperimenti di Bozzi hanno alcune speciali caratteristiche, alcune singolari peculiarità. E talvolta essi non sembrano attenersi strettamente alle regole canoniche o ritenute tali; ed egli si rifiuta - talvolta con pesante ironia, di fare cose che altri riterebbero obbligatorie. Ad esempio, Bozzi si rifiuta di interrogare i Watussi... (p. 301), e non è poco!
«Ma il mio obiettore grida sempre allo scandalo. Un professore di storia dell'arte, a proposito dell'esperimento con i pendoli sopra descritto, mi incitava a ripetere le mie misure coi watussi, i pigmei e i cinesi, onde stabilire qualcosa di buono sui rapporti tra meccanica e percezione. Quanto al linguaggio, per seminare dubbi metodologici, vengono sempre chiamati in causa gli indiani Hopi, che notoriamente vedono il nostro comune mondo di cose e di fatti in modo diverso, poiché parlano - sembra - una lingua particolarmente ostica. Tutte discussioni da lasciar perdere.» (p. 302)
Inoltre, Bozzi, che ha costruito l'esperimento e che sa tutto sui congegni che lo reggono, e che persino ha delle precise attese teoriche sui risultati dell'esperimento (o addirittura delle speranze), non esiterebbe a sedersi bellamente tra gli osservatori ed a partecipare all'esperimento come soggetto sperimentale -«Dubito fortemente - egli dice una volta - di tutti gli esperimenti cui io stesso non abbia assistito» (p. 346). Ed un'altra sua frase, merita in proposito di essere citata: «Un esperimento deve essere una Gestalt, non una raccolta di dati» (p. 311).
Si tratta di una frase molto impegnativa, ricca di senso e di conseguenze che mi piacerebbe che, prima o poi, fosse da Bozzi stesso resa interamente esplicita in tutti i suoi importanti sottintesi - una frase che pone un problema per nulla estraneo alle questioni che ho cercato di sollevare.