Materiali di lavoro per un corso di commento alla Ricerche Filosofiche di Wittgenstein tenuto nell'anno 1975. I testi numerati da I a VI si possono ritirare riuniti nell'unico file PDF intitolato "Commenti a Wittgenstein"
Data di immissione in questo archivio: dicembre 2002
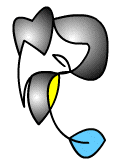
 Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
Giovanni Piana,Commenti a Wittgenstein (pp. 131, Kb. 950)
IV.
Comportamenti
(Ric. Fil., oss. 243-308)

IV.1 - Comportamentismo e coscienzialismo
È spesso difficile fissare con chiarezza le tesi positive che Wittgenstein intende sostenere distinguendole dalle tesi che intende invece respingere. La stessa struttura dialogica del discorso, nella quale gli interlocutori non sono a loro volta chiaramente identificati, contribuisce a complicare le cose. Ciò vale in particolare per un gruppo di osservazioni (oss. 243-268) che vengono solitamente ricordate sotto l’etichettatura alquanto infelice di «problema del linguaggio privato e del linguaggio pubblico»: infelice, perché fa pensare fin dall’inizio che esista veramente il problema di un linguaggio privato, distogliendo l’attenzione sul fatto che questa distinzione è in realtà una delle tante escogitazioni maieutiche di Wittgenstein. In questo gruppo di osservazioni sembra che venga documentato un atteggiamento «comportamentista» da parte di Wittgenstein in opposizione ad un atteggiamento «coscienzialista». Ma come stanno veramente le cose su questo punto?
L’uso comune dell’opposizione di termini «comportamento» e «coscienza» suggerisce l’essenziale della differenza di principio: con comportamento potremmo intendere un complesso di fatti osservabili nel senso in cui sono osservabili tavoli e sedie. I fatti di coscienza e i processi mentali in genere sembrano situarsi su tutt’altro piano. È l’ «esperienza interna» che ci informa su desideri, sensazioni, ricordi, pensieri...
Nell’analisi psicologica potremmo seguire due vie:
1. potremmo procedere dai fatti di coscienza ai comportamenti - assumendo così i comportamenti in quanto azioni che hanno nei fatti di coscienza la loro motivazione;
2. oppure operare una vera e propria dissoluzione dei fatti di coscienza in certi comportamenti tipici. In questo modo a espressioni come «fatto mentale», «processo psichico», «spirituale», ecc. riceverebbero l’intero loro senso da fatti osservabili.
Ora è innegabile che in numerose osservazioni di Wittgenstein si presenti un’inclinazione comportamentistica. Questa inclinazione del resto non ci coglie di sorpresa. Fin dall’inizio con i nostri primi esempi di giochi linguistici ci trovavamo alla presenza di descrizioni compiute «dall’esterno» in cui non era affatto importante che cosa passasse per la mente degli attori, ma erano importanti soprattutto le azioni di cui noi eravamo spettatori. In questa stessa direzione spingono anche le numerose critiche contro ogni tentativo di approccio introspettivo. Una volta Wittgenstein imputa a se stesso addirittura di essere un cripto-comportamentista (oss. 307).
Eppure, non appena si entra nel vivo del problema si ha subito la sensazione che parlando di un’inclinazione comportamentistica nel dibattito sviluppato da Wittgenstein si dice ben poco.
Fin dalle prime battute delle Ricerche Filosofiche, era stato messo in questione il rapporto di denominazione come modello del rapporto tra linguaggio e mondo. Difficoltà particolari, e persino veri e propri paradossi, sorgono se adottiamo questo modello per quelle particolari «cose» che sono le sensazioni.
Che cosa intendiamo con sensazione (Empfindung)? Esemplificativamente potremmo pensare alla puntura di un ago, ad una sensazione dolorosa in genere. Che vi siano qui delle peculiarità lo vediamo subito considerando il problema dell’insegnamento ostensivo. Immaginiamo dunque una situazione in cui il bambino non sa affatto manifestare verbalmente una sensazione dolorosa e noi dobbiamo insegnarglielo, dobbiamo dunque insegnargli ad assegnare ad essa un «nome» (oss. 244).
Le cose potrebbero andare così: il bambino grida, e questo è un certo modo di comportarsi, un comportamento di dolore «e gli adulti gli parlano e gli insegnano esclamazioni e, più tardi, proposizioni». Ad esempio: «Ho mal di denti». Vi è dunque una estrinsecazione, un’espressione immediata del dolore ed una sua eventuale verbalizzazione successiva che sta al posto della prima, ma che è nello stesso tempo qualcosa di diverso da un grido.
In questo rapporto intersoggettivo, il parlare di estrinsecazione del dolore (ed in genere di ogni stato d’animo) sembra implicare una sorta di «interpretazione», di «congettura» da parte dell’osservatore. Dato un certo comportamento, ipotizziamo che quel comportamento sia appunto espressione di uno stato d’animo ed insegniamo a denominarlo. Non diciamo che questa sia una descrizione senz’altro appropriata della situazione, ed in particolare lo siano espressioni come «ipotesi» o «congettura». Ma l’uso di questi termini sembra inizialmente utile per richiamare l’attenzione su questo punto: in linea generale non possiamo essere certi che, dato un certo comportamento di dolore, nell’altro vi sia un’effettiva esperienza di dolore. La certezza può esserci soltanto se siamo noi stessi a provare dolore. Si tratta dunque di una certezza «solipsistica».
Le sensazioni sono «private» (oss. 246) - ma questo aggettivo ha un senso filosoficamente forzato rispetto all’uso comune. Nella vita corrente spesso parliamo di «vita privata», faccende «private», ma forse non ci verrebbe mai in mente di dire che l’avere mal di denti sia cosa privata. In che cosa consiste questa forzatura filosofica? Quali sono i problemi che essa intende trasmettere?
In primo luogo, come abbiamo detto or ora, solo io posso sapere veramente se provo dolore. Gli altri possono saperlo soltanto attraverso il mio comportamento e congetturare da esso che provo dolore.
Questo non è che l’inizio. Il nodo si comincia ad ingarbugliare non appena ci impuntiamo sulla parola «sapere». Il mio comportamento è per altri una fonte informazione, di un sapere. E qual è allora per me la fonte di informazione?
«Non si può dire che gli altri apprendono la mia sensazione soltanto attraverso il mio comportamento - perché di me non si può dire che lo apprendo» (oss. 246).
Ciò che qui sembra fuori posto è quel soltanto - come se agli altri fosse sottratto qualcosa, quasi che fossero costretti ad una informazione indiretta - al contrario di quanto accade per me. Forse c’è qualcosa che non va proprio in questa contrapposizione: da un lato il comportamento, dall’altro una fonte più diretta a cui solo io stesso posso attingere. Il fatto che io non possa vivere il dolore dell’altro è fuori questione: ma ciò può avere un senso banale oppure pretendere di raggiungere una verità particolarmente profonda. Le osservazioni di Wittgenstein - non vi è certo di che meravigliarsi in proposito - tendono ad uno smontaggio del problema, a liberarlo dai fumi da cui esso può essere avvolto.
Qualcuno dice, pretendendo di conferire particolare pregnanza alla cosa: «Le sensazioni sono private». E la risposta potrebbe essere: ciò dice quanto dice che «il solitario si gioca da soli» (oss. 248). Con un simile truismo puoi costruire ben poco.
Inoltre benché possano sorgere dei dubbi sul dolore altrui, il dubbio di principio - che nella presentazione iniziale del problema può essere suggerito dall’affermazione secondo cui la sensazione altrui sarebbe in ogni caso frutto di una congettura - sembra piuttosto un tipico dubbio argomentativo. Qualunque sia l’espressione di uno stato d’animo in genere e in qualunque contesto, su di essa dovrebbe allora pesare il dubbio che si possa trattare di una simulazione. Contro di ciò: «siamo forse troppo precipitosi nell’assumere che il sorriso del lattante non sia una simulazione?» (oss. 249). ; «Perché un cane non può simulare dolore? È troppo onesto?» (oss. 250). Ecco due casi in cui una presunta differenza di livello tra certezza fondata sull’esperienza interna e certezza fondata sull’esperienza esterna sembra ridursi ad un’astratta argomentazione filosofica.
Ritorniamo dunque un poco sui nostri passi. Abbiamo detto che affermare che un altro non può provare esattamente il mal di denti che io provo potrebbe essere considerata una semplice ovvietà. Se però si vuol dare a questa frase un’enfasi che essa non ha, ecco che provochiamo il nostro interlocutore rovesciando il problema: Come fai ad essere certo che un altro non prova il tuo stesso dolore?
Avremmo bisogno di una sorta di criterio di identità. Se uno sostenesse che prova lo stesso dolore che provo io come faremmo a confutarlo? (oss. 253) Se si obbiettasse che la questione non è empirica, ma logica, allora tutto si ridurrebbe nuovamente ad affermare che un solitario si gioca da soli. Il problema, se era importante, va in fumo. Chi si dà un pugno sul petto dicendo enfaticamente «Ma un altro non può avere questo dolore», non dice nulla che meriti un particolare apprezzamento.
Talvolta anche i gesti immaginati da Wittgenstein, in questa sua filosofia teatralizzata, hanno una singolare importanza. Il gesto del picchiarsi sul petto, mentre si dice una cosa simile, chiarisce che ciò che viene messo in questione è la difesa filosofica di una interiorità che mai e poi mai potrà essere raggiunta dallo sguardo profanatore degli altri, quasi che se ciò accadesse qualcosa di indicibilmente prezioso si dissolverebbe. L’io stesso, l’io che vive i suoi stati d’animo, i sentimenti propri dell’io - tutto ciò deve essere riposto in un luogo inaccessibile. L’ostinato riferimento al mal di denti - vagamente sgradevole per il suo carattere così banalmente quotidiano - fa naturalmente parte di questa opera di smontaggio.
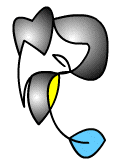
IV.2 Dare un nome ad una sensazione
Tutta la questione può essere riproposta avendo di mira il linguaggio come riferimento principale.
Se diciamo che le sensazione sono «private» e interpretiamo questa affermazione in modo distorto, potremmo pensare che si possa costruire un linguaggio che esprima queste sensazioni proprio in ciò che esse hanno di privato e che sia comprensibile dunque in via di principio solo a colui che prova le sensazioni. Naturalmente questa caratteristica deve derivare dall’assoluta particolarità degli oggetti significati (le sensazioni): la possibilità di un linguaggio privato nel senso di un codice personale, comprensibile solo a me, è ovviamente fuori questione e non riguarda il nostro problema.
Wittgenstein si dispone così nell’atteggiamento di chi intende produrre un simile linguaggio, cavando di qui conseguenze assurde a non finire.
Si tratta di designare le sensazioni con parole (oss. 256). Ma come facciamo? Si è visto che di fronte ad una manifestazione esterna di dolore di un bambino, l’adulto insegna ad associare ad essa una espressione che significa una sensazione. Si potrebbe allora pensare che anche in questo caso potremmo fare nello stesso modo, ricorrendo a manifestazioni esterne delle nostre sensazioni. Dovrei dunque dispormi di fronte ad uno specchio? Supponiamo di fare in questo modo, ma allora il linguaggio non sarà privato nel senso qui inteso perché sarebbe in via di principio comunicabile.La sensazione A sarebbe indicata facendo riferimento alla manifestazione esterna A’. Pertanto potrei comunicare il senso di una parola ad un altro facendo riferimento a quella manifestazione esterna.
Supponiamo invece di tagliar fuori il problema delle manifestazioni esterne. Vi sono soltanto le mie sensazioni, i miei stati d’animo: ed allora sembra ovvio che il progetto di una realizzazione di un linguaggio privato consisterà nell’associare ad una sensazione un certo nome. Ciò sembra facile da fare. Ed invece si tratta anzitutto di una situazione profondamente incomprensibile. A chi potrebbe venire in mente di dare un nome ad una certa sensazione se non vi è nessuna intenzione comunicativa, come va ammesso in linea di principio? (oss. 257). Supponiamo comunque che io tenga un diario nel quale una volta contrassegnata una certa sensazione venga effettuata un’accurata registrazione del suo ricomparire. Ora io ho una certa peculiare sensazione e la chiamo S. Questa connessione tra il segno e la sensazione deve certamente essere impressa nella mia mente. Si tratta di una regola. Ed io debbo scrivere S ogni volta che compare quella sensazione. La regola potrà a sua volta essere applicata correttamente o scorrettamente. Ma qui sta il problema: «...nel nostro caso non ho alcun criterio della correttezza» (oss. 258).
Una ulteriore difficoltà sta poi nel fatto stesso di parlare, come stiamo facendo, di un simile linguaggio. Fin qui ci siamo espressi proprio nel linguaggio che tutti comprendiamo, cosicché la frase «S sia il segno di una sensazione» può per noi avere un senso. Ma quale senso può avere per chi si trova al di fuori di ogni linguaggio comunicativo e progetta di costruire un linguaggio «privato» (oss. 261)?
«Quando si dice ‘ho dato un nome ad una sensazione’ si dimentica che molte cose debbono già essere pronte nel linguaggio perché il puro denominare abbia un senso» (oss. 257). «Sensazione è una parola del linguaggio comune a noi tutti, non di un linguaggio che soltanto io posso comprendere».
Si accumulano così paradossi su paradossi. Conclusivamente: l’idea di un linguaggio privato ci pone in una situazione tanto strana e paradossale quanto sarebbe quella di parlare di un regalo che la mano destra fa alla mano sinistra. «La mia mano destra può mettere denaro nella mano sinistra. La mia mano destra può scrivere un atto di donazione e la sinistra una ricevuta» (oss. 269). Ma quale senso ha tutta questa cerimonia? Non in ogni caso quella di un regalo.

IV.3 - Gestualità corporea, espressività e processi spirituali
Che la parola «sensazione» sia una parola del linguaggio comune segnala che la stessa «grammatica» di ciò che è privato viene appresa in un contesto comunicativo - all’interno di un dialogo. Proprio nel caso estremo in cui sembra che si debba essere ricondotti solo a noi stessi, la «privatezza» della sensazione può essere riconosciuta solo nel presupposto di una dimensione «pubblica» già costituita. Pensiamo al modo in cui un bambino potrebbe imparare a dire: «Ho sognato questo e quest’altro». Forse egli si sveglia all’improvviso, e tenta di narrare qualcosa al genitore, e questi lo tranquillizza dicendo: «È soltanto un sogno!». Importante non è qui solo la parola sogno - che verrà associata a ciò che può accadere quando si dorme, ma il «soltanto» che può significare un sacco di cose - ad es. che si tratta di eventi irrilevanti, che non hanno nulla a che vedere con gli eventi del giorno, ed anche, a poco a poco che il contenuto del suo sogno è soltanto suo. Impara cioè, attraverso gli altri, che il sogno è un «solitario».
Questo è l’atteggiamento che in generale tende a far valere Wittgenstein. Ma esso emerge all’interno di un dibattito piuttosto controverso.
Nell’oss. 281 l’interlocutore di Wittgenstein dice: finalmente ho capito. A tuo avviso il dolore esiste soltanto in quanto comportamento di dolore (Schmerzbenehmen). E ciò viene detto con un sottinteso critico che potrebbe essere formulato in questo modo: il risultato delle tue tesi è che non esiste dolore senza «comportamento di dolore» - intendendo con ciò togliere di mezzo la distinzione tra il dolore in quanto sensazione e la sua manifestazione. Ma allora - qui comincia la critica - come potrai parlare di comportamenti di dolore? Sembra infatti ovvio che un comportamento come tale, osservato dall’esterno, non è che un complesso di gesti, anzi, meglio, di movimenti. Per parlare in rapporto ad essi di comportamento di dolore è necessario attribuire ad essi una capacità espressiva. Questa espressività attribuita presuppone che tu stesso sappia che cosa sia il dolore e che in certo modo la proietti nell’altro in presenza di questo o quel movimento. Se supponiamo che colui che osserva non sappia nulla del dolore - a partire dalla propria esperienza interna - come potrebbe «interpretare» i movimenti dell’altro come un comportamento di dolore. Proiezione e interpretazione fanno tutt’uno. In generale - continua la critica - un atteggiamento comportamentistico è erroneo perché, effettuando le descrizioni degli atti osservati, gli stati d’animo sono in realtà presupposti. Se teniamo conto solo di ciò che risulta esternamente osservabile, ci appariranno sempre soltanto dei movimenti rigorosamente neutri dal punto di vista espressivo. In una descrizione comportamentistica, ad esempio, non potremmo dire che un bambino tende la mano verso un oggetto, perché in questo tendere-la-mano-verso vi è già qualcosa di più di quanto possa essere consentito dai principi comportamentistici dell’osservatore. Al movimento si aggiunge un che di «spirituale», nella descrizione traluce qualcosa come una vita interiore. Un punto di vista comportamentistico finirebbe con l’implicare una totale soppressione di una «spiritualità» comunque intesa, proponendo una psicologia senza «anima», che eventualmente si attiene a modelli «fisicalistici». Ma allora ne va di mezzo non soltanto l’anima o lo spirito, ma anche una nozione praticabile di comportamento.
A tutta prima la risposta di Wittgenstein a questa critica ed ai suoi motivi polemici può sembrare ambigua. Egli anzitutto sposta l’asse del problema: non si tratta di operare una identificazione tra stato d’animo e comportamento, ma soprattutto cercare di rendere esplicito un presupposto di fondamentale importanza: «Soltanto dell’uomo vivente (lebender Mensch) e di ciò che gli somiglia si può dire che abbia sensazioni» (oss. 281). Oltre che ambigua, questa risposta suona anche sibillina. Essa viene ribadita così: «Solo di ciò che si comporta come un uomo si può dire che ha dolori» (oss. 283). Di comportamento dunque si tratta - ma vi è questa aggiunta singolare: il riferimento all’uomo vivente, all’essere umano. Inoltre la questione non è se questo o quello abbia una sensazione, ma in rapporto a che cosa e in quali circostanze si possa dire questo.
In realtà dietro queste formulazioni si va affermando ancora l’importanza della relazione intersoggettiva. Il problema dell’espressività esiste realmente, ma non deve essere posto a partire dalla vita soggettiva isolata, nella quale io apprendo tutto a partire da me stesso e proietto poi ciò che ho appreso sugli altri. Parlando dell’essere umano faccio riferimento in generale ad una comunanza d’essere che il linguaggio stesso anzitutto attesta. Tuttavia qui non si parla solo dell’uomo vivente, ma anche di «ciò che gli somiglia». Cosicché l’ambito di applicazione si amplia smisuratamente. «Nelle favole anche la pentola può vedere e sentire. (Certo, ma può anche parlare)» (oss. 282). Ciò che è chiuso in parentesi è la cosa più importante: alla base dell’«attribuzione» (se vogliamo esprimerci in questo modo) di sensazioni, di atti del vedere e del sentire, vi è qualcosa di simile ad una trasposizione analogica, e ciò che ci consente di dire che la pentola vede e sente è un’analogia nascosta, quell’aspetto per la quale essa può essere assimilata all’essere umano, cioè il suo borbottio. Il «parlare» della pentola non viene dopo la possibilità del vedere e sentire (come sembra suggerire subdolamente il testo), ma prima di essa perché essa in certo modo consegue proprio dal borbottio dell’acqua che bolle in pentola - ed è a partire da questo borbottio che l’immaginazione può iniziare il suo corso. In altri casi invece questa trasposizione incontra forti resistenze. Proviamo in generale difficoltà ad attribuire sensazioni alle pietre. «Guarda una pietra e immagina che abbia sensazioni!» (oss. 284). Potremmo forse simulare di metterci nei panni di una pietra per dare una qualche concretezza ad una simile fantasia, ma ciò richiederebbe un enorme sforzo, che forse non raggiungerebbe in ogni caso lo scopo. «E ora osserva una mosca che si dimena convulsamente, e subito la difficoltà è svanita: qui il dolore sembra far presa...» (ivi).
Considerazioni come queste prevalgono su qualunque tesi proiettiva che concepisca le cose in questo modo: prima ho un’esperienza vissuta solitaria, poi la proietto in un altro uomo o nella pentola che parla, nel pezzo di legno che è destinato a diventare Pinocchio. In realtà «ciò che proiettiamo» non sono sentimenti interni, ma contesti e comportamenti immediatamente sociali: ciò che fa di un pezzo di legno qualcosa che esprime sentimenti è il fatto che esso ride per il solletico che gli fa la lima di Geppetto, osservazione meno ovvia di quanto possa sembra a tutta prima. Se la lima può far solletico, allora il legno può mettersi a ridere. La lima è poi in ogni caso nelle mani di Geppetto. La metafora che sta al fondo della fantasia si intreccia con il rapporto sociale.
Un bellissimo esempio di come l’immaginazione possa incontrare ostacoli nelle proprie «proiezioni» è il «commiserare bambole». Si possono commiserare bambole. Che cosa vi è di più semplice di ciò? Si immagina che siano ammalate e le si compiange. Ma la fantasia di Wittgenstein è tanto fervida da immaginare un gioco in cui il commiserare bambole diventa difficile, forse impossibile. «Immaginiamo il caso in cui soltanto delle cose inanimate la gente dice che provano dolore; commiseri soltanto le bambole» (oss. 282). È possibile immaginare questo? Certo lo è, se lo facciamo. Ma questa risposta sarebbe alquanto superficiale. Il commiserare si apprende in un gioco linguistico tra esseri umani e la situazione indicata è tale per cui gli uomini non si commiserano anzitutto tra loro. Che cosa significherà «commiserare» in questo gioco linguistico? Non lo sappiamo. La trasposizione fantastica urta contro la grammatica della parola, e questa grammatica ci riconduce al mondo umano.
Wittgenstein sembra così rendere chiaramente conto dell’obiezione anticomportamentistica che abbiamo riferito in precedenza. In realtà la fa in larga parte propria. La nozione di comportamento deve essere istituita avendo di mira i contesti umani, e ciò pone fin dall’inizio il problema dell’espressività. Nel comportamento che cerchiamo di descrivere l’espressività fa parte della descrizione.
«Pensa al riconoscimento dell’espressione di un volto. Oppure alla descrizione di un volto - che non consiste nel dare le misure di un volto!» (oss. 287).
Osservazioni di questo genere non sono certo orientate nel senso di un comportamentismo ingenuo, e non vi è dubbio che in Wittgenstein vi sia una polemica diretta contro di esso. E tuttavia il problema di una possibile relazione con una posizione comportamentistica si ripropone. «Allora sei un cripto-behaviourista. In fondo non dici che all’infuori del comportamento umano tutto è finzione?» (oss. 307).
Il fatto è che mentre l’obiezione anticomportamentistica si convertiva poi in una aperta presa di posizione a favore di una concezione «coscienzialistica», Wittgenstein non concede nessuno spazio ad una simile direzione di sviluppo. La differenza tra anima e corpo, tra soggettività e corporeità (espressiva), e quindi una possibile enfasi sull’interiorità dell’io tende a venire meno.
«In che senso non è la mia mano a sentire dolore, ma sono io che sento dolore nella mia mano?» (oss. 286) Oppure: «Come avviene che io sia pieno di compassione per quest’uomo?» (e non ad esempio per il suo corpo) (oss. 287). «Non si rivolgono parole di conforto alla mano, ma al sofferente; a lui si guarda negli occhi» (oss. 286). Per ammettere tutto ciò non abbiamo bisogno di ammettere la soggettività a titolo di una particolare entità che sta altrove rispetto ai suoi comportamenti.
Se i comportamenti vengono intesi così, allora ci bastano i comportamenti. Cosicché si può sviluppare insieme ad una critica del comportamentismo - che certo non intendeva i comportamenti in questo senso - mantenendo una critica «anti-interioristica» che può raggiungere anche punti estremi. Soprattutto va criticata secondo Wittgenstein l’idea secondo cui vi sarebbe qualcosa di «strettamente intimo, di "esclusivamente mio» che precederebbe il rapporto intersoggettivo.
Il misterioso «coleottero» dell’oss. 293 può valere come una immagine della vita interiore.
Socialmente parlando, una vita interiore c’è. Tenendo conto del contesto sociale ognuno ha il suo coleottero. Ma se prescindiamo da questo contesto, esso si dissolve. Se immaginassimo di aprire da noi stessi la scatola che lo contiene, essa potrebbe rivelarsi vuota. Noi abbiamo un nome comune per designare l’animaletto, e questo nome svolge una funzione ben determinata. Ma continuerebbe a svolgere questa funzione anche se a quel nome non corrispondesse nulla (Questo è tra l’altro anche un altro argomento contro il modello di teoria del significato che poggia sulla coppia «designazione-oggetto»).
Si comprende dunque che possa ripresentarsi l’obiezione di annientare la vita spirituale:
«Tuttavia ritorni sempre al risultato che la sensazione in se stessa non è nulla» (oss. 304).
«Ma non puoi negare che quando ad esempio si ricorda abbia luogo un processo interno» (oss. 305).
«Allora sei un criptobehiaviorista» (oss. 307).
Queste obiezioni vengono respinte, ma il punto di vista del «coleottero» viene ribadito.
«Diamo forse l’impressione di negare qualcosa? (oss. 305).
Questa impressione sorge dal fatto che «ci opponiamo all’immagine del ‘processo interno’» (ivi). Se il ricordo sia un processo interno lo potremmo anche ammettere, ma sosterremo anche che quando dico «adesso ha avuto luogo in me il processo mentale del ricordare» voglio dire niente di più e niente di meno che «ora ricordo». Così può sorgere l’impressione che vengano negati i processi mentali, e questa impressione è del resto giustificata se riteniamo che quella proposizione non sia riducibile a quell’altra (oss. 306). Così come neghiamo in genere che la mia «esperienza vissuta» abbia caratteristiche così peculiari da ritenere che l’esperienza dell’altro possa soltanto essere «inferita» - e dunque sia per principio soggetta a dubbio. Wittgenstein ritrova qui - probabilmente senza esserne consapevole - uno dei capisaldi della teoria fenomenologica dell’esperienza intersoggettiva - che ha una critica simile ai suoi inizi (e che è più robusta nei suoi sviluppi e nei suoi presupposti metodologici).
«Prova un po’ a mettere in dubbio - in un caso reale - l’angoscia di un’altra persona!» (oss. 304). In altri termini vi sono casi in cui l’angoscia dell’altro è evidente, così come del resto sono possibili tutte le altre varietà possibili del dubbio sulla sincerità della sua manifestazione di dolore. Tutto ciò avviene esclusivamente e soltanto sulla base dei comportamenti, e di comportamenti riferiti ad una soggettività che si ha propriamente di mira, anche se questa non ha bisogno di essere concepita come una entità da essi distinta ed afferrabile in se stessa.
«E così sembra che abbiamo negato i processi spirituali. E, naturalmente, non li vogliamo negare» (oss. 308).
