
Ernst Cassirer
![]() La notte dei lampi - Parte II (716.5 kB) (pp. 97)
La notte dei lampi - Parte II (716.5 kB) (pp. 97)

II. L’immaginazione sacra
Saggio su Ernst Cassirer
* La notte dei lampi. Quattro saggi sulla filosofia dell’immaginazione è stato pubblicato dall’Editore Guerini e Associati, Milano, nel 1988
* versione digitale 2000
* Le immagini accanto ai titoli dei paragrafi derivano da graffiti preistorici
Indice
- Nel considerare il pensiero mitico Cassirer non parla della relazione tra mito e immaginazione
- L’esperienza mitico-religiosa come esperienza vissuta e l’irrealtà delle formazioni mitiche
- Critica di un approccio empirico-psicologico
- Implicazioni positivistiche
- Immaginazione ed errore in Frazer
- La nozione cassireriana di simbolo
- Implicazioni idealistiche
- Attività simbolizzatrice e teoria della coscienza
- La tesi del simbolismo implicito
- Sviluppi ed esempi
- Tematica della causalità
- L’indifferenza verso i nessi causali secondo Lévy-Bruhl
- Il processo dello spirito e la rarefazione dei simboli
- Riflessioni sulla nozione di esperienza mitico-religiosa
- Riapertura del problema
- L’immaginazione come facoltà dell’eterogeneo
- Avviamento della critica alla tesi del simbolismo implicito
- Doppiezza della credenza e coscienza dell’immagine
- La reificazione delle immagini come reificazione incompleta
- Sacro e profano
- L’uniformità indifferente del quotidiano e la pretesa funzione ordinatrice del sacro
- Riconsiderazione della posizione di Lévy-Bruhl
- Digressione bergsoniana
- La profondità dell’immaginazione
- Riconsiderazione della posizione di Frazer alla luce delle osservazioni di Wittgesnstein
- Le pratiche magiche dicono i desideri degli uomini
- Il ripresentarsi del nesso tra immaginazione e mito
 1. Nel considerare il pensiero mitico Cassirer non parla della relazione tra mito e immaginazione.
1. Nel considerare il pensiero mitico Cassirer non parla della relazione tra mito e immaginazione.
È un fatto che, nell’intera trattazione cassireriana del problema del «pensiero mitico», sviluppata nel secondo volume della Filosofia delle forme simboliche, nonostante la grande ricchezza e articolazione del percorso seguito, non ci imbattiamo mai in qualche passo realmente significativo che metta in causa il problema dell’immaginazione.Tra l’immaginazione e il mito vi è certamente una relazione intrinseca - le produzioni mitiche sono anzitutto produzioni dell’immaginazione. Eppure Cassirer non ritiene affatto che questo sia il punto da cui possa prendere le mosse una filosofia della mitologia nel senso da lui teorizzato, e nemmeno che, all’interno di essa, questa relazione debba assolvere un ruolo ben determinato. Che le produzioni mitiche siano anzitutto produzioni dell’immaginazione è una ovvietà su cui non vale nemmeno la pena di soffermarsi.
Si tratta di una presa di posizione così vistosa che certamente ha alla sua base un intero complesso di ragioni che debbono essere comprese a fondo per rendersi conto dei presupposti della posizione filosofica cassireriana e delle sue conseguenze, così come per avviare su di essa una riflessione approfondita.
 2. L’esperienza mitico-religiosa come esperienza vissuta e l’irrealtà delle formazioni mitiche
2. L’esperienza mitico-religiosa come esperienza vissuta e l’irrealtà delle formazioni mitiche
Il primo motivo che orienta Cassirer in questa emarginazione della problematica dell’immaginazione rimanda indubbiamente alla componente fenomenologica della sua impostazione filosofica. Questa componente viene già chiaramente in luce nei riferimenti a Schelling che occupano una parte così importante nella posizione introduttiva del problema. Schelling ha posto con estrema chiarezza - osserva Cassirer - il problema di una considerazione autonoma del mito, e ha potuto formulare il programma autentico di una filosofia della mitologia in quanto ha cessato di considerare il mito nel suo contenuto narrativo puro e semplice, insistendo invece sulla sua efficacia per la coscienza umana, quindi sul rapporto con la soggettività.
«Il vero fenomeno che qui si tratta di intendere - cita Cassirer da Schelling - non è il contenuto rappresentativo del mito come tale, ma il significato che esso possiede per la coscienza umana e il potere che esercita su di essa»[1]. «Significato» vuol dire qui rilevanza; e questa rilevanza può essere colta solo se il mito si presenta alla riflessione filosofica come qualcosa che è concretamente vissuto, solo se si prendono le mosse dall’assunto che vi è una vera e propria esperienza vissuta specificamente mitico-religiosa. Il tema dell’autonomia può essere proposto solo facendolo gravitare su questa idea di esperienza mitica, cioè sull’idea che «la mitologia come storia degli dei si potrà produrre solo nella vita stessa», realizzandosi concretamente «come qualcosa di vissuto e di sperimentato»[2].
L’altro lato del problema, in Schelling, secondo il quale il tema dell’esperienza mitica deve essere integrato in un sistema dell’Assoluto, in modo che il suo sviluppo fenomenologico assuma un senso e una giustificazione ontologica, viene interamente lasciato cadere da Cassirer come un’indebita estensione metafisica che finisce con il porre su un falso terreno un programma che ha una corretta impostazione iniziale.
Tutta la questione deve invece essere posta e risolta nei confini circoscritti dell’esperienza mitico-religiosa: di essa la filosofia non ha il compito di indagare la fondazione, ma di cogliere le tipicità che la caratterizzano nella sua essenza.
In tutto ciò sembra che vi sia già un buon motivo per respingere un modo di approccio alla problematica filosofica del mito che porti l’accento sulle produzioni mitiche come produzioni dell’immaginazione. Infatti, poiché l’immaginazione non sembra essere altro, in primo luogo, che la facoltà di produrre oggettività irreali e fittizie, se prendessimo le mosse di qui l’irrealtà del mito assumerebbe il carattere di un dato di fatto fondamentale ai fini dell’apprestamento della sua filosofia. Invece l’indicazione metodica che porta l’accento sull’esperienza mitico-religiosa come esperienza vissuta procede nella direzione esattamente opposta: ciò che è irrilevante è proprio il carattere fittizio e irreale delle entità mitiche considerate in se stesse. Per la coscienza mitica, esse hanno infatti una forma peculiare di efficacia; sono una vera e propria potenza dello spirito umano (come si esprimeva Schelling); esse hanno dunque una specifica realtà intenzionale.
Il raccordo con la posizione fenomenologica propriamente husserliana sembra a questo punto del tutto chiara, secondo Cassirer. L’idea di un’analisi intenzionale nel senso di Husserl mette in questione non già il modo di essere dell’oggettività in sé, ma la correlazione tra soggetto e oggetto come correlazione in se stessa significativa; in particolare, nella fenomenologia «debbono essere studiate le strutture di campi completamente diversi di oggetti, secondo il loro puro "significato" e senza che si tenga conto della "realtà" dei loro oggetti»[3]. Nell’estensione del metodo fenomenologico al campo del mito, questo punto deve essere messo in rilievo proprio perché le oggettività intese sono qui sempre, considerate in se stesse, oggettività irreali. Ma questa irrealtà viene messa in parentesi dalla riduzione fenomenologica, e si mostra così che essa non appartiene in alcun modo allo statuto di senso del rapporto istituito dall’esperienza mitica.
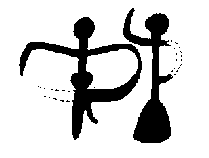 3. Critica di un approccio empirico-psicologico
3. Critica di un approccio empirico-psicologico
Il secondo motivo che agisce nella stessa direzione riguarda invece la componente strutturalistica dell’impostazione filosofica cassireriana. Infatti, il parlare nei confronti della posizione di Cassirer di una sorta di strutturalismo fenomenologico, sarebbe, io credo, abbastanza appropriato. Va solo notato che i termini in questione, che qui sono proposti in connessione, sono invece spesso impiegati per formulare una netta opposizione: all’adesione descrittiva alla superficie delle cose, che caratterizzerebbe l’atteggiamento fenomenologico, si contrappone l’attenzione verso le strutture considerate come costruzioni interpretative messe in opera nel corso di un’analisi logica che va necessariamente oltre l’immediatezza concreta di ciò che appare alla superficie. Si tratta tuttavia di un impiego terminologico che non deve necessariamente essere considerato vincolante.
Una componente strutturalistica è indubbiamente riconoscibile in Cassirer già per il fatto che qui non si fa questione delle particolarità dell’esperienza mitica, delle sue determinatezze concrete, ma appunto delle sue tipicità in quanto modalità peculiare di organizzazione del mondo. Questa componente può essere a sua volta ricollegata allo stile fenomenologico dell’indagine, e in particolare all’idea dell’analisi intenzionale come analisi eidetica. Tuttavia su questo punto è assai più opportuno richiamare la matrice portante dell’intera costruzione della Filosofia delle forme simboliche:la matrice kantiana.
L’intera trattazione della problematica del pensiero mitico è determinata, anche nel dettaglio e nella distribuzione espositiva degli argomenti, dal modello della filosofia kantiana dell’esperienza. Ciò che rende legittimo il parlare di una considerazione rivolta agli aspetti strutturali, precisando il senso di questa espressione in quanto riferita al contesto del discorso cassireriano, è proprio questo consistente rimando alla filosofia kantiana e ai suoi classici luoghi polemici.
Il problema delle condizioni trascendentali dell’esperienza che Kant prospetta in diretta connessione critica con le istanze empiristiche, ha infatti il senso di rivendicare l’esistenza di forme strutturali che operano come principi di articolazione e di organizzazione del mondo. La critica del limite epistemologico della posizione kantiana e la proposta conseguente di un’estensione di questo punto di vista di principio conduce Cassirer a presentare il programma generale di una filosofia delle forme simboliche e, nel suo interno, di una filosofia della mitologia che considera fin dall’inizio il mito come pensiero:cioè come un’attività di messa in forma, come un insieme coerente di strutture sulla cui base vengono istituite le connessioni e i momenti di articolazione. Le numerose critiche rivolte da Cassirer in direzione del punto di vista empiristico rimandano, come in Kant, ad un orientamento che nel considerare la modalità specifica dell’esperienza mitica mira a mettere in evidenza le sue componenti di ordine strutturale, mettendo da parte le componenti di carattere psicologico fattuale.
Lo stesso motivo antipsicologistico, per il quale Cassirer si richiama ancora alla posizione espressa da Husserl nei Prolegomeni alle Ricerche logiche come un inizio che deve essere generalizzato all’intero arco della filosofia della cultura, confluisce in realtà senza residui nel motivo strutturalistico propriamente kantiano che resta ovunque dominante.
Dall’adozione di una simile prospettiva deriva una ulteriore attenuazione della rilevanza del problema dell’immaginazione ai fini della elaborazione di una filosofia della mitologia.
In precedenza abbiamo notato che, assumendo l’immaginazione come facoltà dell’irreale, ne consegue l’accentuazione del carattere fittizio delle entità e delle narrazioni mitiche: le credenze mitico-religiose sono anzitutto credenze erronee, e questa circostanza dovrebbe rappresentare una premessa fondamentale per l’interpretazione delle produzioni dell’esperienza mitica. Ora si aggiunge un nuovo motivo, che riguarda più propriamente l’aspetto metodico: se ci si accinge a mettere in evidenza le modalità in cui si esprime il mito, a titolo di strutture che danno luogo ad una forma coerente della realtà, dovremo allora guardarci dal mettere al centro delle nostre considerazioni la questione dei rapporti tra mito e immaginazione perché ciò farebbe inclinare l’intera tematica in una direzione sostanzialmente psicologistica. L’immaginazione è infatti una facoltà psicologica che ha le proprie leggi e i propri dinamismi psicologici. E non si tratta certamente di negare la legittimità di una problematica specificamente psicologica che abbia come tema le produzioni immaginative del mito, ma di circoscrivere un determinato spazio problematico in modo da rendere evidente che ogni questione relativa alle componenti psicologiche (come del resto storico-sociologiche) dell’esperienza mitica sono da esso escluse. Il compito di una descrizione strutturale dell’esperienza mitica e del mondo che in essa si costituisce è semplicemente un altro compito rispetto ad un’indagine volta all’ambito esplicativo delle cause e delle motivazioni. Il richiamo all’immaginazione tende perciò a confondere i lineamenti del problema o addirittura ad effettuare la sua pura e semplice soppressione. Esso appare caratteristico di un atteggiamento empiristico piuttosto che di una filosofia dello spirito che cerchi di riappropriarsi della tradizione kantiana; e di quella idealistica.
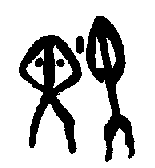 4. Implicazioni positivistiche
4. Implicazioni positivistiche
In effetti ciò che conferisce allo strutturalismo fenomenologico di Cassirer la sua impronta definitiva è proprio l’intenzione di riproporre le grandi istanze della filosofia idealistica, e precisamente hegeliana, in modo da metterle alla prova della concretezza del materiale documentario, così da evitare una filosofia della cultura fondamentalmente aprioristica, tutta fatta di proiezioni di ordini concettuali precostituiti. Dunque: aderenza al materiale, in primo luogo. Moltiplicazione degli esempi, delle citazioni, dei riferimenti testuali. E rinuncia alle più spericolate speculazioni condotte sul filo del pensiero puro. Ma anche, nello stesso tempo, tensione interpretativa che cerca di istituire tra i materiali connessioni significative, che sappia mostrare come essi parlino un unico linguaggio: come in essi si manifesti un ordine concettuale sia sul piano di una esperienza mitica considerata staticamente, sia da un punto di vista che faccia apparire questa esperienza come un momento iniziale e dinamico di uno sviluppo ideale che conduce a partire da essa al mondo della religione, dell’arte, della scienza.
Il pensiero mitico è un processo, e la fenomenologia critica di esso ne mostra, a un tempo, la struttura e il cammino.
Alla luce di questa impronta idealistica hegeliana, che Cassirer riesce a imporre ed a sovrapporre tanto agevolmente - e con nostra grande ammirazione e meraviglia - a motivi kantiani e husserliani, debbono essere riconsiderati tutti gli argomenti antiempiristici e antipsicologistici che assumono allora una connotazione polemica meno astrattamente filosofica e più concretamente orientata verso la cultura dell’epoca. Idealismo contro positivismo.Questo è in effetti il nodo dello scontro.
L’immaginazione come via di approccio alla problematica del mito: un filosofo positivista avrebbe certamente preso le mosse di qui.
 5. Immaginazione ed errore in Frazer
5. Immaginazione ed errore in Frazer
Accennando alle linee più esterne dell’impianto teorico di un’opera antropologica che illustra esemplarmente l’atteggiamento positivistico, quale è Il ramo d’oro di Frazer[4], avremo modo di farci un’idea più chiara delle ragioni cassireriane.
In primo luogo vi è in essa il motivo della connessione tra immaginazione ed errore:in Frazer abbiamo un esempio molto vivo del modo in cui opera nell’interpretazione del pensiero mitico, un punto di vista che tende a porre l’accento sulla falsità delle credenze, sul fatto che esse sono fondate anzitutto su false opinioni.E nello stesso tempo è facile mostrare in che modo un simile punto di vista sia connesso a istanze empiristiche così come a una tendenza psicologizzante che conduce a conseguenze particolarmente rilevanti.
In Frazer, l’immaginazione è naturalmente fin dall’inizio in questione sotto il titolo dell’associazione delle idee.E un percorso evidentemente lineare conduce dal tema dell’associazione delle idee a quello della falsità. Nella dinamica dell’associazione delle idee, determinati contenuti vengono connessi ad altri indipendentemente ed eventualmente contro le connessioni reali. I legami mentali si sovrappongono a quelli effettivi, e la formazione di un’opinione erronea è di ciò una ovvia conseguenza. Del resto anche nell’empirismo classico la tematica dell’associazione delle idee, appena posta, era già orientata in direzione dell’errore, anche se gli intenti erano - per esempio in Hume - accentuatamente filosofici: il richiamo all’associazione delle idee occorreva ogni volta che si doveva esibire l’effettività psicologica dei nessi dell’esperienza e, nello stesso tempo, la loro profonda illusorietà.
 Indipendentemente da queste preoccupazioni di ordine filosofico, anche in Frazer il primitivo ha di fronte a sé un mondo costituito di connessioni illusorie, un mondo appreso attraverso legami puramente mentali, istituiti dall’azione dei meccanismi associativi - quei meccanismi che agiscono, anche se in direzioni diverse, nello stesso modo e secondo le stesse regole nel primitivo come nell’uomo civilizzato. Il vecchio problema della «natura umana», della «essenziale similarità... con cui la mente umana ha elaborato la sua prima e rude filosofia della vita» [5]è anzi il presupposto che ci consente di affrontare il problema della comprensione di usanze che ci appaiono a tutta prima incomprensibili, e spesso anche incomprensibilmente barbare.
Indipendentemente da queste preoccupazioni di ordine filosofico, anche in Frazer il primitivo ha di fronte a sé un mondo costituito di connessioni illusorie, un mondo appreso attraverso legami puramente mentali, istituiti dall’azione dei meccanismi associativi - quei meccanismi che agiscono, anche se in direzioni diverse, nello stesso modo e secondo le stesse regole nel primitivo come nell’uomo civilizzato. Il vecchio problema della «natura umana», della «essenziale similarità... con cui la mente umana ha elaborato la sua prima e rude filosofia della vita» [5]è anzi il presupposto che ci consente di affrontare il problema della comprensione di usanze che ci appaiono a tutta prima incomprensibili, e spesso anche incomprensibilmente barbare.
Come venire a capo del tragico destino del sacerdote - omicida e vittima - che si aggira nel bosco sacro di Nemi? Una regola strana. Una regola barbara. Eppure, deve esserci, dietro questa regola, come dietro le innumerevoli altre che ci appaiono sorprendenti e inintelligibili, un qualche criterio della comprensione. Dobbiamo riuscire, nel lavoro antropologico, a scoprire le opinioni implicite che stanno alla base di quelle usanze; ed operare nello stesso tempo quelle connessioni, quelle relazioni che consentano di cogliere il loro formarsi nelle stesse regole dell’associazione delle idee.
La teoria della magia e il modo in cui la magia viene differenziata dalla religione illustra gli elementi teorici su cui si fonda questo programma interpretativo.
Secondo Frazer, la magia è caratterizzata non tanto dalla concezione di un mondo pervaso da forze spirituali, quanto piuttosto dall’idea di una vera e propria legalità naturale, quindi dall’idea di una concatenazione stabile nel corso degli eventi, entro il quale lo stregone si intromette, aderendo alle leggi che lo regolano. Se consideriamo le pratiche dello stregone, appare subito chiaro che esse sono variazioni delle regole dell’associazione immaginativa proposte dalla tradizione empiristica; e dal momento che quelle pratiche sono credute efficaci, indubbiamente in esse è implicita la teoria secondo la quale la natura stessa sviluppa il suo corso attenendosi alle stesse regole. Per questo alla magia deve essere riconosciuta una sorta di analogia formale con la scienza - in essa vi è l’idea di una legalità naturale;e nelle pratiche magiche qualcosa di simile all’idea della possibilità di un dominio tecnologico della natura. Mentre la differenza di principio con ciò che potremmo chiamare «religione» balza agli occhi con evidenza nella modificazione delle pratiche che rivelano un atteggiamento interamente diverso nei confronti della realtà. Agli artifici dello stregone subentrano i sacrifici del sacerdote: dunque la proiezione di una potenza sovrannaturale e la concezione di una natura priva di una legalità immanente, dal momento che può soggiacere in ogni momento all’arbitrio del puro volere personale.
Ma certamente quanto più Frazer sottolinea che nella magia possiamo scoprire «un germe della moderna nozione di legge naturale»[6], quanto più fa notare che la stessa scrupolosità con cui lo stregone applica le regole magiche rammenta da vicino lo scrupolo con cui dobbiamo attenerci alle leggi naturali per mettere la natura al nostro servizio [7] , tanto più deve essere accentuato il tema della falsità.
La magia non è altro che la «sorella bastarda della scienza»; essa rappresenta «una grande e disastrosa illusione»[8].
In che modo tuttavia una simile illusione ha potuto così largamente affermarsi e persistere tanto a lungo e addirittura sopravvivere fino ai nostri giorni, dove il modo di pensare magico trova ancora un «solido strato di consenso intellettuale tra gli sciocchi, i deboli, gli ignoranti e i superstiziosi che costituiscono disgraziatamente la grande maggioranza del genere umano?»[9].
Proprio nel rispondere a domande come queste l’inclinazione psicologistica del problema diventa particolarmente evidente nelle sue conseguenze insostenibili.
In effetti non basta parlare di pura e semplice falsità, ma anche di falsità grossolana, di una falsità che dovrebbe risultare subito patente. Come mai l’urto delle opinioni con l’esperienza stessa non venne fin dall’inizio avvertito? Alla credenza in falsità grossolane deve certamente corrispondere non solo uno sviluppo culturale molto basso, ma una vera e propria ottusità intellettuale.
Eppure, uomini intelligenti dovevano pur esserci anche tra i selvaggi; e allora «il lettore sarà tentato di domandare: come mai gli uomini intelligenti non scoprirono prima la fallacia della magia? Come mai poterono continuare a tenere care speranze invariabilmente destinate a fallire? Con che animo seguitavano a ripetere venerabili buffonate che non conducevano a nulla e a borbottare delle solenni tiritere che rimanevano senza effetto?»[10].
A questo proposito bisogna osservare - risponde Frazer - che l’errore «era tutt’altro che facile da scoprire», l’«insuccesso tutt’altro che ovvio», perché spesso l’evento desiderato «seguiva realmente l’esecuzione del rito destinato a causano». «Una cerimonia diretta a far soffiare il vento o a far cadere la pioggia o a causare la morte di un nemico sarà sempre seguita presto o tardi da quell’avvenimento che pretende di provocare»[11]. Vi erano certamente, anche presso i primitivi, dei «filosofi radicali» che forse si azzardavano a esercitare la scepsi nei confronti della magia, ma essi potevano essere facilmente tacitati. Ecco come argomenterebbe di fronte a questi dubbi il selvaggio «pratico», poco avvezzo alle dispute teoriche: «Ci può essere una cosa più evidente.., del fatto che quando io accendo la mia candela da due soldi sulla terra, il sole accende il suo gran fuoco in cielo? Mi piacerebbe sapere se non è vero che quando mi sono messo il mio vestito verde di primavera gli alberi non fanno lo stesso. Questi sono fatti chiari per tutti, e sopra questi io mi baso»[12].
Insieme all’ottusità vi è dunque anche la possibilità di un circolo vizioso al quale non è troppo ovvio sottrarsi. Chi si sottrae a esso, e anzi sa trarne profitto, è proprio lo stregone. Per quanto all’inizio lo stregone possa essere «sinceramente convinto di possedere quei meravigliosi poteri» che gli attribuiscono i suoi «ottusi fratelli»[13], tuttavia egli può confermare queste sue virtù solo se, resosi conto della falsità e della inefficacia della magia, sa approfittare accortamente di essa, realizzando la carriera a cui è predestinato. Lo stregone assume sempre più importanza non solo per i singoli, ma per il gruppo sociale e può infine aspirare ad assumere «l’autorità di capo e di re»[14].
In tutto ciò non solo diventano dominanti nozioni puramente psicologiche come l’ottusità e l’intelligenza, la furberia e l’ambizione, ma attraverso queste nozioni si tenta addirittura di rendere conto del passaggio dalla presunta «democrazia primitiva» al regime «monarchico». Lo scaltro briccone, l’intelligente impostore diventa infine l’autocrate del gruppo sociale -questo è il punto terminale della «carriera del mago» - imprimendo una radicale modificazione alle forme di esistenza della tribù.
Possiamo qui stendere un velo sul fatto che approfittando del passaggio dal selvaggio democratico guidato dai suoi vecchi pacifici e tradizionalisti allo stregone astuto e ambizioso che instaura la monarchia, Frazer prenda lo slancio per un elogio della monarchia in genere come fautrice in se stessa di progresso, del cinismo politico, nonché delle tendenze espansionistiche e imperialistiche che sono proprie di un regime autocratico[15]. Tutto ciò può essere particolarmente significativo sotto altri riguardi. Ciò che ci interessa invece notare è l’esemplificazione della portata di un punto di vista che pone al centro del problema teorico della magia la sua falsità, seguendo la via di una trattazione che ci pone senz’altro di fronte all’origine immaginativa delle formazioni mitico-magiche e che dà a questo centro uno sviluppo in se stesso del tutto coerente.
Non meno coerente è l’inflessione ironica che punteggia la stessa espressione letteraria. Se lo sguardo della beccaccia, con il suo occhio d’oro, ha la virtù di curare i malati di itterizia, il venditore di beccacce farà bene a portarle al mercato accuratamente ricoperte affinché un malato di itterizia, passando di lì per caso, non venga curato gratis[16]. Quanto alla medicina magica, «uno dei suoi grandi meriti è che essa permette di eseguire la cura sulla persona del medico invece che su quella della vittima, la quale evita così ogni noia e inconveniente, mentre vede il suo medico che si contorce e spasima davanti a lui»[17].
Una ironia che non ha certamente lo scopo di avvilire l’argomento, ma che trae tutta la sua serietà dalla polemica contro le sopravvivenze superstiziose, contro i pregiudizi dei bigotti che frenano in ogni tempo lo sviluppo delle sane argomentazioni e il progresso del costume.
 6. La nozione cassireriana di simbolo
6. La nozione cassireriana di simbolo
L’esempio di una caratteristica impostazione del problema a partire da un atteggiamento positivistico sembra dare particolare consistenza alle ragioni di Cassirer per mettere totalmente ai margini della problematica filosofica del mito il tema della connessione del mito con l’immaginazione. Per quanto questa connessione possa essere ovvia, essa può essere alla fine fuorviante perché sembra costringerci fin dall’inizio a proiettare sul mito il punto di vista dell’errore, facendo inclinare tutta la trattazione secondo una piega psicologistica con conseguenze più o meno manifestamente inaccettabili.
Dobbiamo per questo disporci senz’altro nell’alternativa proposta da Cassirer tra idealismo e positivismo? In realtà, prima di prendere una decisione converrà cercare di dare un resoconto del modo di approccio di Cassirer al problema particolare del mito. Questo problema è particolare perché esso si presenta in Cassirer nel più ampio quadro di una filosofia delle forme simboliche, che traccia gli elementi di filosofia generale la cui applicazione viene sperimentata e messa alla prova sul terreno della problematica del mito. Si tratta dunque di un rapporto molto stretto che difficilmente può essere scisso: concordare intorno al modo in cui Cassirer imposta la questione del pensiero mitico significa concordare anche sui presupposti filosofici generali, e inversamente dubbi sollevati su questa impostazione sarebbero anche dubbi sull’atteggiamento filosofico complessivo. Uno dei modi per venire a capo della discussione senza perdersi all’interno della sua intrinseca complessità è probabilmente quello di puntare fin dall’inizio l’attenzione sulla nozione di simbolo qui in qui in questione, la cui teorizzazione è tanto essenziale all’impostazione di principio quanto lo è alle sue specificazioni particolari.
Si è talvolta notato che la nozione di simbolo in Cassirer non può essere agevolmente impiegata per via della sua ampiezza che sconfina con l’aperta genericità. Un’osservazione come questa tuttavia non è corretta, dal momento che ciò che andrebbe rilevato in primo luogo non è tanto la difficoltà di rintracciare nel testo di Cassirer una precisa definizione quanto piuttosto che quella nozione è sempre intesa come rappresentativa dell’intera posizione filosofica esposta; ed è proprio da questa circostanza che deriva l’ampiezza d’uso del termine che appare così esso stesso ricco di significato e di problemi. Non è possibile, in altri termini, parlare della nozione di simbolo in Cassirer senza implicare il suo idealismo e la forma specifica che esso assume in questo autore.
Da questo punto di vista è già indicativo che questa nozione sia introdotta anzitutto in connessione con la problematica della teoria della conoscenza.
Per quanto l’impresa di Cassirer nel suo complesso sia caratterizzata dal tentativo di superare una concezione della filosofia strettamente legata ai problemi epistemologici, tuttavia è importante mettere in rilievo il fatto che questi problemi mantengono una posizione in qualche modo privilegiata.
Le considerazioni iniziali intorno alla nozione di simbolo si muovono sullo sfondo della questione del realismo - una questione proposta secondo un’angolatura caratteristicamente epistemologica e in modo tale da implicare, con opportuni adattamenti argomentativi, l’empirismo fenomenistico e in ultima analisi l’abito mentale di tipo positivistico.
Nella sua Storia della filosofia [18] Cassirer spiega con particolare chiarezza in che modo Ernst Mach possa essere considerato il teorizzatore di una posizione fenomenistico-empiristica e come gli elementi di carattere generale che si possono trarre dai Principi della meccanica di Heinrich Hertz possano essergli contrapposti.
Secondo Mach, «la verità che il fisico deve descrivere consiste unicamente in una somma di semplici dati sensibili, in suoni, colori, odori, gusti»[19]. Mach compie dunque una sorta di messa fuori gioco della portata ontologica delle nozioni fisiche che non sono direttamente riportabili a qualità sensoriali. Il fatto che nella conoscenza fisica della realtà vengano introdotte nozioni astratte fa sorgere l’idea di una realtà vera che sta al di sotto dei dati fenomenici come una sorta di impalcatura che li sostiene.
Esse vengono intese come se si trattasse di nozioni che rinviano a entità, mentre la loro natura vera e propria sta nel loro carattere di costruzioni teoriche. La critica di questa portata ontologica non conduce naturalmente alla loro soppressione, ma alla tesi secondo cui queste costruzioni sono veri e propri artifici, strumenti ausiliari, per rendere possibile il dominio, mediante il ricorso alla formulazione di una legge, della molteplicità dei casi particolari che si presentano nella realtà fenomenica. Alla critica della portata ontologica delle costruzioni astratte della fisica fa dunque seguito in Mach un determinato carattere della costruzione teorica e della nozione di legge che ne segue[20].
La legge non fa altro che riassumere «la conoscenza che la percezione ci offre in una maniera immediata»: e la teoria stessa assume il carattere di una semplice «riproduzione dei fatti stessi» [21]in modo tale che essa è, in linea di principio anche se certamente non in linea di fatto, del tutto eliminabile[22]. Con tutto ciò viene riproposto un ideale di conoscenza che misconosce una partecipazione autentica delle operazioni conoscitive nella determinazione del risultato conoscitivo, separando nettamente la costruzione teorica come puro mezzo o artificio del conoscere dai fatti che sono, nella loro singolarità, il suo obiettivo.
Contro la posizione di Mach, assume particolare rilievo, secondo Cassirer, la posizione di Hertz: «Con lui comincia una nuova fase anche nei metodi della fisica»[23]. Questa modificazione non consiste certamente in un ritorno all’attribuzione di una portata ontologica secondo un punto di vista ingenuo già criticato da Mach. Anche in Hertz assume un particolare rilievo il momento della costruzione teorica, l’accentuazione posta sulla astrattezza delle nozioni scientifiche. Ma questa accentuazione ha ora un senso interamente diverso - e mentre in Mach era possibile ipotizzare, sia pure in via astratta, l’eliminabilità del momento teorico, ciò non accade in Hertz. Per Hertz infatti non è in generale proponibile il problema della commisurazione della teorizzazione alla vera realtà delle cose - si tratti di un livello soggiacente allo strato empirico fenomenico o di questo stesso strato. Ed è proprio per mostrare questa improponibilità che interviene in Hertz la nozione di immagine secondo quella sfumatura di senso che interessa in particolare Cassirer.
Una teoria fisica non è altro, per Hertz, che una nostra rappresentazione della realtà, un’immagine di essa. Ma per dare di essa una valutazione non abbiamo bisogno di postulare che essa rispecchi dati di fatto a cui debba essere commisurata. Una teoria consta di leggi e queste debbono essenzialmente assolvere lo scopo di consentirci di effettuare previsioni. Ma questo scopo si può dire assolto nel momento in cui da una certa immagine possiamo trarre il verificarsi di eventi essi stessi dati in immagine. Il fatto che questi eventi si verifichino conferma soltanto che tra la sequenza di immagini e la sequenza dei fatti ci deve essere una qualche connessione. Ma non dice nulla sulla pretesa presenza nell’immagine dell’essenza della cosa. Una teoria si presenta dunque essenzialmente come un modo di ricomporre i fenomeni da un punto di vista unitario. Si richiedono perciò particolari requisiti che la teoria deve possedere, ma essi consteranno essenzialmente nella sua coerenza logica interna, nella sua semplicità e nella sua comprensività, oltre che nella capacità di consentire previsioni, mentre non viene affatto in questione un eventuale fondamento nei dati di fatto dei quali la teoria stessa dovrebbe fornire una rappresentazione fedele.
Prescindendo da una discussione sul senso e sulla portata effettiva della posizione di Hertz - una posizione del resto che potrebbe essere richiamata anche da punti di vista molto diversi - risulta comunque chiaro l’aspetto che in essa attira l’interesse di Cassirer.
In un modo o nell’altro, viene qui proposta una nozione di immagine che esclude il carattere di semplice riflesso delle cose, che propone dunque i concetti fondamentali della scienza come simboli.Questa parola ha qui il senso che deriva a essa dall’impostazione teorica che abbiamo or ora esposto. Dei simboli verrà dunque certamente accentuato il carattere strumentale, ma soprattutto la partecipazione dello strumento alla determinazione del risultato conoscitivo. Il valore dei simboli della scienza secondo la prospettiva emergente nella posizione di Hertz «non risiede nel rispecchiamento di una determinata cosa esistente, ma nel risultato che essi forniscono come strumento della conoscenza, nell’unità dei fenomeni che essi stessi producono nel loro senso»[24].
Nello stesso tempo Cassirer mette in risalto che la nozione di legge presente in Hertz supera la concezione di un puro riassunto di casi particolari, così come la necessità di considerare una teoria come un vero e proprio sistema unitario che non ha senso tentare di mettere alla prova pezzo a pezzo; e infine la natura peculiare dell’apparato propriamente concettuale che non appare semplicemente derivato dall’esperienza, ma liberamente prodotto indipendentemente da essa in funzione dell’acquisizione di un punto di vista che dovrà essere messo alla prova dell’esperienza in modo certamente più complesso e meno lineare di quello suggerito dalla «teoria del rispecchiamento».
In breve, in Hertz si affaccia, secondo Cassirer, l’idea che la scienza si muove interamente all’interno di un universo simbolico in un’accezione niente affatto ovvia del termine, che ci conduce direttamente sull’assunto epistemologico di ascendenza kantiana fatto proprio da Cassirer. Secondo questo assunto, la determinazione dell’oggetto del conoscere può avvenire solo attraverso «la mediazione di una peculiare struttura logico concettuale»[25].
In generale non vi sono oggetti da conoscere come oggetti dati che attendono soltanto la «riflessione» finalizzata alla loro conoscenza, ma l’oggetto si offre come oggetto da conoscere in quanto viene proposto all’interno di un determinato punto di vista, quindi all’interno di una prospettiva che non può promanare dall’oggetto stesso, ma che sorge dalla forma del rapporto che si istituisce con esso.
Nell’introdurre la nozione di simbolo, dunque, ci troviamo anzitutto nel bel mezzo di una discussione caratteristicamente epistemologica che implica una presa di posizione antirealistica, in primo luogo in rapporto allo statuto dei concetti teorici impiegati dalla scienza, e in particolare dalla fisica; anche se poi l’obiettivo autentico è quello dell’estensione e della generalizzazione di una simile presa di posizione.
Conoscere non significa rispecchiare, ma piuttosto dare forma ai dati. L’attività conoscitiva, d’altro lato, è solo un singolo genere di attività formatrice, un peculiare tipo di manifestazione della «vita spirituale». E quei caratteri che abbiamo riferito in via del tutto generale alle produzioni conoscitive e che si vuole qui che siano implicati nello stesso impiego della parola «simbolo» andranno attribuiti ad ogni produzione come il mito, l’arte, la religione, che sono anch’esse, non meno della scienza, manifestazioni dello spirito e nello stesso tempo modalità ben definite di costituzione del reale.
Questo modo di impostazione del problema, che riguarda l’ambito delle prese di posizioni di principio, incide naturalmente in modo decisivo sulla direzione problematica verso cui si trova fin dall’inizio orientata la tematica del mito. Se infatti assumiamo una concezione realistica, la nostra attenzione dovrà essere subito attratta dalla distorsione e dalla falsificazione operata dal mito rispetto a una realtà presupposta come già data. Cosicché si imporrà subito un’elaborazione teoretica che non perda mai di vista il rapporto di pura e semplice contrapposizione con la conoscenza in genere. Mentre se le immagini del mito ci appaiono anzitutto come simboli nell’accezione che abbiamo or ora illustrata, ecco che il mito, non meno della scienza, ci appare come il risultato di «un’attività originaria, e non semplicemente riproduttiva», il suo mondo di immagini come un mondo nel quale «non semplicemente si rispecchia un dato empirico», ma come un mondo che il mito produce «secondo un principio autonomo»[26]. E si apre pertanto il problema di indicare i modi specifici secondo i quali si esplica questa particolare attività formatrice così come il problema di portare a chiarezza il «principio autonomo» a partire dal quale il mondo mitico prende forma.
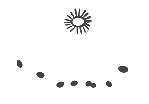 7. Implicazioni idealistiche
7. Implicazioni idealistiche
La stretta integrazione della nozione cassireriana di simbolo all’interno dei presupposti filosofici di Cassirer appare con evidenza anche se consideriamo il problema da altri lati.
Una filosofia idealisticamente orientata, osserva Cassirer, corre il rischio, già in sede di considerazione epistemologica, di condurre ad una frantumazione dell’oggetto stesso del sapere proprio perché questo oggetto non può essere semplicemente presupposto, ma l’apparato concettuale e strumentale interviene nella sua stessa determinazione. Poiché questi apparati sono molteplici, sembra che si debba conseguentemente «accettare la conclusione che ad una diversità dei mezzi debba corrispondere necessariamente anche una diversa disposizione dell’oggetto, un diverso significato dei nessi "oggettivi"»; «l’unità dell’essere... minaccia di dissolversi in una mera molteplicità dell’esistente»[27]. Ed a maggior ragione questo rischio si estende nella generalizzazione di un simile punto di vista alle manifestazioni culturali in genere. Assumendo una concezione realistica, invece, all’oggetto verrebbe riconosciuta in via di principio una identità sostanziale e i diversi punti di vista da cui esso verrebbe considerato sarebbero appunto soltanto luoghi di osservazione rivolti ad una entità in se stessa unitaria.
Di conseguenza il problema dell’unità andrà risolto non dal lato dell’oggetto, ma da quello del soggetto; e può cadere a questo punto un ulteriore richiamo alla plasmazione «simbolica» del reale. Ciò che importa è in Cassirer non tanto la specificità dei simboli e le loro differenze, quanto il fatto che l’attività attraverso cui lo spirito si «obbiettiva» è comunque un’attività di simbolizzazione: cosicché la «funzione spirituale» è sempre in ogni caso formalmente la stessa. Dal punto di vista del problema di una considerazione unitaria, non interessa il contenuto dei simboli, ma quella forma che è comune ai simboli di qualsivoglia contenuto e origine, una forma che va infine illustrata come produttività intrinseca della vita spirituale.
Il riconoscimento della molteplicità di «direzioni della vita spirituale» è fin dall’inizio accompagnato dal problema di indicare il termine medio che le attraversa e unifica, così da pervenire ad una considerazione unitaria «che estenda alla totalità delle forme spirituali i risultati raggiunti dalla critica trascendentale della pura conoscenza»[28]. Questo termine «medio onnicomprensivo nel quale si incontrano tutte le forme spirituali pur così diverse» è il simbolo stesso, la stessa attività di simbolizzazione.
La filosofia delle forme simboliche è perciò anzitutto una filosofia dello spirito e, nello stesso tempo, una versione dell’idealismo filosofico.Poiché questo idealismo assume a proprio concetto rappresentativo la nozione di simbolo, dando così rilievo al tema del linguaggio, esso può presentarsi sotto l’aspetto di una semeiotica filosofica.Il riferimento - in realtà alquanto forzato - alla caratteristica universale di Leibniz ha esattamente questo senso: come Leibniz ricercava sotto questo titolo una lingua generale della conoscenza, così si potrebbe indicare con lo stesso termine il problema di una lingua generale dello spirito[29].
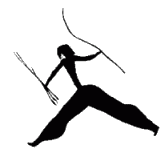 8. Attività simbolizzatrice e teoria della coscienza
8. Attività simbolizzatrice e teoria della coscienza
Posto il problema in questi termini risulta essere un errore ricercare nell’opera cassireriana qualcosa di simile a una definizione di «simbolo» sufficientemente precisa. Questa nozione può essere illustrata solo richiamando i presupposti filosofici di fondo e, inversamente, nell’illustrazione di questi presupposti essa è destinata a ripresentarsi di continuo.
Si consideri, per esempio, il modo in cui si afferma la problematica della totalità che riprende temi kantiani, investendoli dell’aura dell’esasperato organicismo dell’idealismo romantico.
Alla base vi è appunto la nozione kantiana di categoria che assume in Cassirer, accentuatamente, il senso di un rimando a nessi relazionali che non possono essere immanenti ai dati, ma che vengono proiettati in essi da una specifica ed autonoma attività della coscienza. La coscienza è sempre una coscienza che istituisce relazioni. Perciò essa è costitutiva di unità oggettive di varia specie, in corrispondenza con le diverse direzioni dello spirito, con le molteplici modalità della sua realizzazione. Nello stesso tempo la coscienza, nella sua unità soggettiva, ha essa stessa una struttura relazionale: essa ha dunque carattere totalizzante, è una totalizzazione e opera totalizzazioni.
Come formula breve capace di sintetizzare questa «teoria della coscienza» potremmo proporre: ogni contenuto della coscienza è sempre mediazione di un altro contenuto.Cassirer dice propriamente: «Non vi è alcuna cosa nella coscienza senza che in tal modo eo ipso, senza ulteriore mediazione, sia posta un’altra cosa o una serie di altre cose»[30]. Ciò deve essere inteso, evidentemente nel senso che qualunque contenuto di coscienza è senz’altro la mediazione di altri contenuti oppure che ogni contenuto, non appena è dato, è aperto ad altri contenuti e rinvia a essi. In questo modo nella singolarità è sempre presupposta la totalità: «infatti ogni singolo essere della coscienza ha la sua determinatezza proprio soltanto per il fatto che in esso viene nel contempo posto e rappresentato in una forma qualsiasi la totalità della coscienza»[31].
Questo tema, che determina non soltanto l’impostazione generale del problema, ma anche l’atmosfera nella quale l’opera è immersa, viene variamente esemplificato da Cassirer.
In primo luogo vi è la questione del modo di intendere la temporalità della coscienza[32]. Ogni contenuto coscienziale è certamente presente alla coscienza, ma non in ogni caso in un senso che rinvia ad una concezione puntiforme della temporalità. Per quanto il passato della coscienza non ci sia più e il futuro non ci sia ancora, tuttavia «il contenuto che noi indichiamo come "ora" non è altro che il limite eternamente fluente che separa il passato dal futuro. Il singolo istante temporale, in quanto lo si voglia determinare come temporale non può concepirsi come rigida esistenza sostanziale, ma solo come l’oscillante trapasso dal passato al futuro, dal non più al non ancora» [33].
Il presente deve dunque essere inteso come momento di una processualità, cosicché in esso vi è un accenno alle altre dimensioni temporali, quindi alla totalità dello sviluppo stesso. Il rimando ad altro assume qui la forma dell’oltrepassamento verso l’altro, e si apre così la prospettiva di una considerazione dinamica che si salda al problema dell’integrazione e della «totalità autentica».
Per ciò che riguarda il problema dello spazio Cassirer nota che i rapporti spaziali si costituiscono a loro volta in un processo temporale, benché il risultato debba essere l’apprensione di dati coesistenti. Lo spazio percepito è costituito nella processualità della percezione, e dunque esso «si può rappresentare soltanto sulla base delle sintesi successive»[34]. Anche in questo caso è necessario perciò che il dato venga trasceso ed integrato in una totalità. Il processo di costituzione della spazialità «si spezzerebbe per noi in singoli elementi completamente isolati, senza rapporti fra loro, e perciò non permetterebbe in modo alcuno il compendiarsi in un unico risultato, se qui non sussistesse la possibilità generale di comprendere già il tutto nell’elemento, così come l’elemento nel tutto»[35].
In questa direzione viene rammentato il prospettivismo della percezione: la visione della cosa secondo l’angolatura determinata da un punto di vista fa parte della struttura del processo percettivo, ma di essa fa parte necessariamente anche il rimando dal lato colto prospetticamente alla cosa intera. «L’immagine spaziale che noi possediamo di un singolo oggetto empirico, per esempio di una casa, ha luogo solamente per il fatto che noi ampliamo in questo senso una singola visione prospettica relativamente limitata, per il fatto che noi la utilizziamo come punto di partenza e come stimolo per costruire, in base a essa, un tutto molto complesso di relazioni spaziali»[36].
In particolare, implicando nell’ambito di una simile impostazione la questione dell’inerenza delle proprietà a una cosa, inerenza che non può essere spiegata in termini «sommativi», ma che richiede che l’idea della totalità della cosa sia in qualche modo presupposta, Cassirer rafforza con il richiamo al tema della totalità la propria polemica antiempiristica che assume in questo contesto il carattere di un netto rifiuto dell’associazionismo psicologico. Egli fu del resto tra i primi a dare peso filosofico ai risultati della psicologia della forma di cui fa un ampio utilizzo, anche se proprio per questo è probabilmente responsabile del kantismo implicito così spesso troppo sommariamente attribuito a quell’indirizzo psicologico.
Tuttavia a noi preme soprattutto sottolineare che l’insistenza sul carattere totalizzante della coscienza, quel carattere fondamentale «per cui il tutto qui non è raggiunto solo dopo che si è partiti dalle parti, ma ogni singolo atto che pone una parte implica che si ponga il tutto, non secondo il suo contenuto, ma secondo la sua struttura»[37], costituisce un altro modo di riproporre il problema della simbolizzazione, un modo ancora più radicale dal momento che, seguendo questa via si giunge a far coincidere la nozione stessa della coscienza con l’attività della simbolizzazione.
La formula secondo cui ogni contenuto è sempre mediazione di un altro contenuto può certamente essere modificata senza mutamento di senso e resa ancora più concisa, dicendo che la presenza è sempre anche rappresentazione.Attraverso l’impiego di quest’ultimo termine, inteso come «presentazione di un contenuto in un altro e per mezzo di un altro»[38], unitamente all’idea che «solo in questa rappresentazione e mediante essa diventa possibile anche ciò che noi chiamiamo l’essere dato e la presenza del contenuto» [39]diventa evidente la saldatura tra la tematica della totalità e la nozione di simbolo. E non meno evidente appare che la nozione di simbolo è radicata, secondo questa impostazione della questione, nella stessa essenza della coscienza. Là dove si dice che «la rappresentazione... dovette essere riconosciuta come presupposto essenziale per la costruzione della coscienza e come condizione della sua peculiare unità formale»[40], la parola simbolo può certamente essere sostituita a quella di rappresentazione.
La nozione di simbolo non può dunque in Cassirer essere una nozione rigorosamente determinata, e nemmeno essere riservata per così dire ad impieghi particolari. Questo termine indica anzitutto i rapporti rappresentativi in genere, nei quali si possono discernere i termini del rapporto, come accade per le parole del linguaggio e per tutti quelli che Cassirer chiama simboli indiretti[41].Questa accezione viene poi ulteriormente ampliata, in quanto con il termine di simbolo si indica anche qualunque rapporto di rinvio ad altro, quindi tutte le strutture relazionali che reperiamo all’interno dei decorsi percettivi e della vita di esperienza in genere. In essa agisce già una sorta di «simbolica naturale» che rappresenta il fondamento del rapporto simbolico vero e proprio.
Da tutto ciò risulta una significativa accentuazione sui simboli indiretti, quindi sulla simbolica artificiale: infatti il richiamo alla simbolica naturale serve essenzialmente a mostrare che i simboli indiretti sono «fondati nell’essenza stessa della coscienza»[42], ma al tempo stesso solo essi esprimono compiutamente questa essenza proprio perché sono l’espressione della sua spontaneità e della sua libera produttività. Proprio il fatto che vi sono simboli artificiali mostra che la coscienza si può affermare, nella propria simbolicità essenziale, con una radicale autonomia. Nella simbolica naturale (nella percezione per esempio) noi siamo vincolati al dato di fatto sussistente: mentre nei segni simbolici prodotti ad arte «l’esistenza sorge solamente dal significato»; in essi la coscienza «si crea essa stessa determinati contenuti concreti e sensibili come espressione di determinati complessi significativi» [43].
Qui diventa tra l’altro chiara la tensione, tutta idealistica, verso l’ideale del pensiero puro così come la distanza, che le indubbie analogie tra spunti problematici non sono in grado di attenuare, tra una posizione come quella cassireriana e la fenomenologia nel senso di Husserl. L’affinità di contenuto tra le stesse formule generali - la simbolicità della coscienza sembra portare in prossimità della intenzionalità di cui parlava Husserl - viene sommersa dalla tendenza a fissare un sommo principio unificante, tendenza che è tanto caratteristica di un idealista autentico, quanto è lontana dalla passione fenomenologica per le piccole differenze.
 9. La tesi del simbolismo implicito
9. La tesi del simbolismo implicito
Questa tendenza all’unità si fa naturalmente sentire con tutta la sua forza nel modo di approccio al tema del mito. Oggetto di indagine sono qui certamente le forme strutturali dell’esperienza mitica intesa come un vero e proprio modo di costituire la realtà stessa, ma queste forme strutturali sono dominate da un principio fondamentale, da un assunto che riguarda il modo in cui si esplica, nel mito, l’attività simbolizzante che caratterizza la vita dello spirito in generale.
Questo principio potrebbe essere formulato così: nell’esperienza mitica della realtà vi è una radicale indistinzione tra il simbolo e la cosa simbolizzata.Ciò significa: il pensiero mitico è in sé un pensiero simbolico, ma trae la propria specificità proprio dal fatto che in esso non si produce la consapevolezza del simbolismo in quanto simbolismo. Questa tesi si presenta già nella introduzione dell’opera e ricorre ovunque nel suo corso. Cassirer non si stanca di ripetere che per il primitivo il simbolizzante ed il simbolizzato fanno tutt’uno, che qui manca la coscienza di una precisa discriminazione. Le «immagini» che sono presenti nei comportamenti mitici non sono mai coscienti in quanto immagini, ma fanno corpo con la cosa stessa.
Con terminologia di derivazione hegeliana potremmo parlare di questa tesi fondamentale, che dovrà servire come riferimento interpretativo di base per illustrare le peculiarità delle produzioni mitiche come tesi del simbolismo implicito. |81|
Una terminologia hegeliana che, nonostante tutte le differenze, è in realtà opportuna anche in base a considerazioni di contenuto e che riguardano il modo in cui l’analitica fenomenologica della coscienza mitica si dispiega nel corso della sua elaborazione. In effetti, non appena abbiamo enunciato l’assunto fondamentale dell’indistinzione del rapporto simbolico ci troviamo subito orientati in una prospettiva di sviluppo e di processualità ideale che richiama direttamente la nozione hegeliana di fenomenologia. Il parlare di simbolismo implicito rimanda subito alla possibilità di una esplicitazione - l’inconsapevolezza del rapporto ad una graduale presa di coscienza, che dovrà anche necessariamente rappresentare il superamento dialettico di quella fase dell’esperienza culturale dell’umanità che caratterizziamo come esperienza mitica.
Un principio concettuale forma la traccia per l’interpretazione e la comprensione della struttura del pensiero mitico e nello stesso tempo istituisce differenze secondo l’ordine di una genesi ideale.
Ciò riguarda naturalmente in primo luogo l’individuazione di una precisa distinzione tra mito e religione. Il mito di cui parla Cassirer - proprio in quanto è definito dal simbolismo implicito - e molto prossimo a tutto ciò che Frazer avrebbe fatto rientrare sotto il titolo della magia. E in effetti questo riferimento alla magia come la fase più primitiva, ma anche più genuina, del pensiero mitico diventa spesso del tutto manifesta. Benché il pensiero mitico non si riduca per Cassirer all’ambito della magia, tuttavia il nucleo di esso è indubbiamente rappresentato dal rapporto magico; mentre quanto più ci allontaniamo da questo nucleo tanto più ci approssimiamo all’ambito dell’esperienza che dovremmo chiamare, più propriamente, esperienza religiosa.
Ciò che accade in quest’ultima, e che fa parte dell’essenziale novità che essa introduce nelle vicende della vita spirituale è proprio la presa di coscienza del rapporto di rappresentazione simbolica. Non questo o quell’oggetto nella sua singolarità e nella sua esistenza concreta diventa oggetto di venerazione e di culto, ma questa esistenza concreta in quanto rimanda a qualcosa che sta al di là di essa e alla quale essa si limita ad accennare simbolicamente.
Indipendentemente dunque dalle intersezioni che rimandano a «sopravvivenze» o, inversamente, ad anticipazioni che rendono difficile di fatto la discriminazione tra mito e religione, vi è una precisa discriminazione ideale che mette in questione la struttura del rapporto simbolico. Questa discriminazione propone di per se stessa, proprio in quanto riguarda la dialettica tra l’implicito e l’esplicito, un ordinamento processuale secondo il quale la religione si situa sulla linea di sviluppo del mito e il mito è destinato a trapassare ed a superarsi in essa.
L’accenno alla nozione di arte merita di essere rammentato, nonostante la sua brevità, perché conferma e ribadisce l’utilizzo dello schematismo concettuale della tesi del simbolismo implicito. Mentre nel pensiero mitico nessuna raffigurazione della realtà potrà valere come tale dal momento che l’immagine sarà fin dall’inizio investita da valori magici nei quali si presenta la cosa stessa, nella religione la relativa autonomia acquisita nella presa di coscienza della distanza dei termini del rapporto non potrà essere veramente completa: l’immagine non potrà, nemmeno nella religione, valere in se stessa proprio perché è ancora il simbolo di una realtà trascendente. All’esperienza estetica dunque spetta una caratterizzazione autonoma dal momento che in essa l’immagine appare nella sua totale autonomia e indipendenza rispetto alle entità di riferimento che giacciono al di fuori di essa presentandosi come libera estrinsecazione della soggettività del suo produttore[44].
Il prendere le mosse dalla tesi del simbolismo implicito contiene già queste possibili «deduzioni» - così come del resto prospetta l’intera descrizione dell’esperienza mitica secondo le linee di un movimento di progressiva dissoluzione. Nello stesso tempo, il principio che fissa la tipicità del pensiero mitico lo propone non solo come fase di un processo, ma come la fase iniziale del processo stesso della cultura.
All’inizio non vi è e non può che esservi l’esperienza mitica dal momento che la distinzione appare come una evoluzione dell’indistinzione, e la fase dell’indistinzione come una fase concettualmente e storicamente anteriore.
Se poi vogliamo spingere lo sguardo, in qualche modo, prima di questo inizio, allora troviamo l’esperienza concepita come un caotico fluire di pure percezioni sensoriali nella loro singolarità e molteplicità inorganizzata; una nozione di esperienza che ha, naturalmente, il carattere di una mera astrazione, di una nozione limite, che deve comunque essere postulata proprio per portare in primo piano la funzione ordinatrice dell’esperienza mitica.
In tutto ciò si fa sentire il peso del modello della filosofia kantiana dell’esperienza. Anche in essa la nozione del «molteplice dell’esperienza» - espressione che indica niente altro che le impressioni sensoriali della tradizione empiristica - deve essere mantenuta come nozione limite, puramente negativa, per indicare il materiale nel quale le forme a priori introducono un ordine.
Nella trasposizione di questo modello all’esperienza mitica, il flusso dei dati inorganizzati viene richiamato in Cassirer per rendere conto dell’origine dell’esperienza mitica: all’interno di questo flusso accade che questa o quella singola impressione assume un particolare rilievo per la coscienza, un particolare significato che fa tutt’uno con l’impressione stessa e che istituisce, all’interno del flusso, una differenza e con ciò stesso un principio di ordinamento.
Il tema dell’intensificazione delle intuizioni sensibili sintetizza molto bene i vari aspetti della tematica cassireriana e ne indica l’orientamento di fondo.
Il problema del simbolismo implicito è in realtà già presente nella illustrazione del trapasso dalla impressione alla espressione:il dato semplicemente percettivo non solo è investito da un flusso emotivo particolarmente intenso che lo rende ricco di significato, ma viene compenetrato dal significato in modo da esserne indistiguibile. Di fronte alla cosa da cui siamo stati colpiti in quanto ha ricevuto un senso in rapporto ai nostri timori, ai nostri desideri e ai nostri bisogni la reazione non è quella di istituire una rete di relazioni che riporti questo senso in un contesto più ampio liberandolo dal riferimento alla cosa nella sua singolarità, ma al contrario quello di associare sempre più strettamente il significato alla cosa stessa, traducendo questa connessione in un vincolo indissolubile. La cosa è diventata pregnante e in questa sua pregnanza affascina la coscienza. La coscienza mitica è una coscienza affascinata, quindi una coscienza legata alla presenza, nella sua immediatezza, «prigioniera del suo contenuto»[45].
«Il mito si attiene esclusivamente alla presenza del suo oggetto, all’intensità con cui questo in un determinato momento afferra la coscienza e se ne rende padrone»[46]. «E come se là, dove l’uomo sta nel cerchio magico di questa intuizione mitico-religiosa, tutto il resto del mondo fosse sprofondato e sommerso»[47].
E tuttavia nonostante questa concentrazione nella singolarità che preclude in via di principio ogni transizione propriamente concettuale e che conferisce alla coscienza mitica un carattere di passività, attraverso l’investimento mitico dì senso «il mondo della passiva impressione sensibile» è trasceso[48], il primo passo al di là del dato è stato compiuto perché il materiale dell’esperienza è in ogni caso entrato in relazione con l’attività produttiva dello spirito; e la cosa che è emersa dall’indifferenza si appresta a diventare il punto zero delle coordinate del mondo.
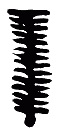 10. Sviluppi ed esempi
10. Sviluppi ed esempi
In forza di tutto ciò il pensiero mitico riceve la sua prima qualificazione come pensiero concreto:esso si trova presso le cose e non prende mai le distanze da esse. Le astrazioni e le idealità in genere restano ad esso sconosciute; e ciò appare come una conseguenza diretta delle tesi del simbolismo implicito, della tendenza cioè, che questa tesi attribuisce al pensiero mitico, a considerare ogni elemento significativo come direttamente incorporato nel materiale che fa da veicolo ad esso. Nel pensiero mitico «manca la categoria dell’idea e di conseguenza ogni volta che incontra un elemento significativo questo, per essere colto, si deve trasformare in qualcosa di oggettivo e assumere il carattere di un essere»[49]. Ciò appare con particolare chiarezza nei comportamenti e nelle azioni. Le cerimonie in genere, per quanto con il tempo possano attenuarsi in puro e semplice spettacolo, non hanno mai «originariamente un significato semplicemente allegorico, imitativo o rappresentativo, ma un significato del tutto reale: sono intrecciate con la realtà dell’agire tanto da formarne un’indispensabile parte costitutiva»[50]. E in che cosa consiste questo intreccio? Consiste per esempio nel fatto che l’atto rituale deve avere efficacia sulla realtà stessa, dagli atti di culto dipende tutto ciò che cresce e prospera. «Il culto è il vero strumento in virtù del quale l’uomo, non tanto dal punto di vista spirituale, quanto dal punto di vista fisico sottomette la natura»[51]. Oppure consiste nella partecipazione alla cerimonia come una partecipazione non già a qualcosa che viene messo in scena qui e ora, ma all’evento mitico che la cerimonia, più che rappresentare, ricrea e pone in essere ancora una volta. Il danzatore che ha messo la maschera del dio «diventa il dio»[52]. «In tutti i riti che si riferiscono alla vegetazione in cui si celebra la morte e la resurrezione del dio si esprime sempre questo fondamentale sentimento di identità, di identificazione reale. Ciò che avviene in questi riti.., non è la semplice rappresentazione di un evento, ma l’evento stesso nel suo compiersi» [53].
Fra i primi e più evidenti esempi che Cassirer rammenta per illustrare la tesi dell’indistinzione, vi sono naturalmente gli impieghi magici del linguaggio, in particolare tutti quegli esempi che mostrano, nei modi più svariati, che per il primitivo il nome proprio di una persona o di un dio racchiude la persona stessa o la sua potenza. E ciò che vale per le immagini verbali, varrà anche per le immagini non verbali in genere. Questa «identificazione reale» sta alla base di tutte le pratiche magiche, incantesimi e fatture, operate sulle immagini. La convinzione di quei popoli primitivi, citata da Frazer e ripresa da Cassirer [54] , che tremavano alla vista dell’arcobaleno perché lo ritenevano una grande rete tesa da un potente stregone per catturare la loro ombra, riassume molto efficacemente questa tematica. Secondo lo spirito della concezione cassireriana dovremmo commentare che qui l’arcobaleno viene considerato secondo le analogie dell’immaginazione, ma l’immagine si solidifica senz’altro nella cosa - la rete - così come l’ombra dell’uomo viene subito condotta a identificazione reale con l’uomo stesso. All’interno della esperienza mitica, concepita a partire dall’assunto dell’indistinzione tra il simbolo e la cosa, l’arcobaleno deve essere vissuto come una rete reale e l’ombra non meno realisticamente come un corpo del corpo, come una sua diretta emanazione fisica - ed è significativa del resto la perplessità che Cassirer manifesta a proposito dell’interpretazione dell’ombra come «anima», che gli appare come un’interpolazione riflessiva fondamentale estranea al pensiero mitico. Tutto qui diventa reale: nel senso dell’oggettività, dell’essere, della sostanzialità. E reale sarà naturalmente anche il timore di fronte ad un pericolo così concreto.
Se poi procediamo oltre nel tentativo di delineare «il carattere della coscienza mitica dell’oggetto» ci troveremo continuamente di fronte a variazioni, articolazioni e ampliamenti problematici che hanno strettamente a che fare con il principio dell’indistinzione.
Vi è anzitutto il rilievo che assume, nell’ambito del mito, l’esperienza onirica: questo rilievo che «le esperienze vissute in sogno hanno per il nascere e il costituirsi dell’esperienza mitica» [55]va compreso tenendo conto del fatto che le immagini oniriche tenderanno per il primitivo ad assumere una consistenza e una solidità che per noi spetta soltanto agli eventi della veglia. Su questo punto Cassirer rimanda alla documentazione riunita da Lévy-Bruhl nel capitolo terzo del suo libro intitolato La mentalità primitiva [56] dal quale risulta indubbiamente che qui non si tratta soltanto di prestare fede al contenuto dei sogni, oppure semplicemente di considerarli come se contenessero ammonimenti o previsioni sugli eventi quotidiani: tutto sembra confermare che il sogno, come scrive Lévy-Bruhl, «porti ai primitivi dei dati che valgono altrettanto, se non più, che le percezioni acquisite durante la veglia» [57]e che sulla base di una simile documentazione si possa affermare che non vi è, per il primitivo, alcuna netta linea di demarcazione tra il sogno e la veglia.
Dall’indistinzione tra sogno e veglia all’indistinzione tra vita e morte il passo è breve. Si tratta del resto di una connessione già presente in Lévy-Bruhl. Egli rammenta che secondo un modo di considerare il sogno molto diffuso, nel sogno l’«anima» si allontana temporaneamente dal corpo: esattamente come accade nel caso dei morti recenti, la cui anima «dimora nelle vicinanze e continua ad agire sul gruppo sociale». Colui che dorme e sogna «si trova in uno stato simile a quello dei morti recenti»[58], e proprio per via di questa affinità intrinseca spesso incontrerà i morti intrattenendosi con loro: oppure potrà accadere che siano i morti stessi a visitarlo mentre egli dorme.
Queste ombre, questi incontri misteriosi nella dimora dei morti sono, anche per Lévy-Bruhl, apparizioni e incontri reali, che in nulla si distinguono dagli incontri della veglia.«Se si è visto in sogno qualcuno che è morto da molto tempo si è veramente conversato con lui» [59]E la domanda «Sei vivo?» che si rivolge a modo di saluto quando si incontra un amico andrà intesa nel suo senso letterale, perché l’altro che io vedo potrebbe ben essere morto e allora è il caso anzitutto di operare un accertamento preliminare [60] .
Tutto ciò si ripresenta in Cassirer strettamente fuso nel quadro filosofico che gli è proprio. La vita e la morte - «queste due sfere non si trovano tra loro in un rapporto simile a quello che intercorre tra essere e non essere, ma sono come parti omogenee di un solo e medesimo essere»[61]. Del resto, continua Cassirer, la distinzione stessa non è proposta «in modo diretto e immediato nel dato di esperienza come tale»: l’idea della morte come pura e semplice degradazione del vivente a pura materialità inerte è una costruzione posteriore della riflessione che cancella il rapporto emotivo che permane con la persona al di là della sua morte. «Se si ammette che "realtà" sia tutto ciò che si offre nell’impressione immediata, se si considera questa realtà come sufficientemente attestata nel potere che essa esercita nella nostra vita rappresentativa, affettiva e volitiva, in tal caso il morto è ancora anche se ha cambiato la forma del suo manifestarsi... Il fatto che il vivente si trovi in rapporto con lui come prima, nelle apparizioni del sogno, come pure negli affetti dell’amore, della paura, ecc., non può essere "spiegato" ed espresso... altrimenti che con la sopravvivenza del morto»[62]. In altri termini l’idea della sopravvivenza è l’espressione simbolica di questo rapporto, ma proprio questo simbolismo non può che rimanere nascosto e ciò che è soltanto l’espressione di un sentimento viene vissuto come qualcosa di affatto reale e concreto. E con ciò naturalmente si afferma anche che, al di là della enorme varietà di credenze e di pratiche rituali relative alla morte, l’idea della sopravvivenza fa parte del pensiero mitico in generale dal momento che inerisce al suo principio formale.
 11. Tematica della causalità
11. Tematica della causalità
Ma l’autentico punto nodale che riunisce tutte le caratteristiche che qualificano la direzione fondamentale del pensiero mitico verso l’oggetto secondo Cassirer è l’atteggiamento nei confronti della causalità. Proprio in rapporto a questo problema si misura con particolare evidenza la distanza del mondo costituito attraverso l’esperienza mitica e il mondo empirico, cioè il mondo della semplice percezione che diventa, di grado in grado, il mondo costituito nelle operazioni propriamente conoscitive.
Questa distanza appare qui come una vera e propria opposizione: il pensiero mitico viene costantemente commisurato a ciò che Cassirer chiama pensiero empirico o pensiero empirico-teoretico, intendendo con ciò in senso ampio non solo le operazioni intellettuali che intervengono nella scienza ma tutte quelle operazioni che sono mosse da un obiettivo conoscitivo in genere. Quindi anche, per esempio, tutti gli atti percettivi in quanto in essi si effettuano in generale degli accertamenti. Nella scienza il pensiero empirico-teoretico trova la sua «elaborazione più perfetta»[63], ma un orientamento conoscitivo, e quindi anche una componente puramente intellettuale non è presente solo nella scienza interamente dispiegata, ma nei più semplici accertamenti della percezione.
A questo proposito vale per Cassirer integralmente la lezione epistemologica kantiana: «In realtà già quello che noi chiamiamo mondo della nostra percezione non è un dato semplice fin da principio evidente, ma è solo in quanto e compenetrato da certi fondamentali atti teoretici mediante i quali esso è colto, appreso, determinato»[64]: percepire non e altro che un giudizio implicito, e ogni attività giudicativa presuppone che si sia ormai consolidata la differenza tra ciò che è meramente apparente e soggettivo e ciò che invece appartiene al nucleo solido dei fenomeni, tra ciò che varia secondo le circostanze e le condizioni costanti di questa variabilità.
L’idea dell’oggettività è d’altro lato circoscritta da quella della legge, dal momento che la costanza, la solidità, il permanente assume il senso, nella prospettiva della conoscenza, della conformità ad una legge. Il pensiero empirico nell’accezione lata del termine avrà pertanto alla propria base la nozione della causalità nella misura in cui questa nozione, concepita essenzialmente come relazione di dipendenza funzionale tra eventi, è una nozione equivalente a quella generale della legge. |107|
Tuttavia ciò che caratterizza la tematica cassireriana intorno a questo problema e che consente di considerare la causalità come il nodo intorno a cui possono essere collegate le varie modalità dell’apprensione mitica della realtà non è tanto il carattere sintetico della causalità quanto piuttosto la presenza, nel giudizio causale, di un ineliminabile momento analitico che resta in via di principio inaccessibile al pensiero mitico.
Pertanto Cassirer mette una cura particolare per spiegare che per la posizione di un rapporto causale non basta accertare la concomitanza spaziale e temporale di due eventi, ma occorre operare una scomposizione che abbia lo scopo di accertare quali, fra i molteplici componenti degli eventi, stiano fra loro in un rapporto di effettiva dipendenza funzionale. La valutazione causale richiede dunque un’analisi e nello stesso tempo una «astrazione isolatrice» [65]che sappia risolvere la complessità dell’evento in quei componenti che costituiscono la sua effettiva condizione. Questa capacità analitica che nel corso della sua esplicazione si imbatte nella necessità di operare con costruzioni astratte è in generale propria del pensiero conoscitivamente orientato: «Prima di poter essere inseriti nella forma della totalità sistematica, i dati debbono subire in se stessi una trasformazione; essi debbono venire ricondotti e in certo qual modo risolti in "elementi" ultimi che non sono più tali da essere colti nell’immediata impressione sensibile, ma possono venire posti soltanto nel pensiero teoretico»[66].
Tutto ciò urta naturalmente contro la concretezza del pensiero mitico. Esso è incapace di una posizione autentica di nessi causali proprio perché ignora la dimensione analitica nella quale si situa l’idea della causa. Poiché il pensiero mitico non compie alcuna analisi degli eventi concomitanti, lo stesso rapporto di concomitanza si presenta senz’altro come rapporto causale diretto tra eventi presi nella loro singolarità. «Ivi ogni rapporto di contemporaneità, ogni contiguità e contatto spaziale racchiude già in sé una reale conseguenza...». Cosicché vale il principio: «Post hoc, ergo propter hoc»; oppure: «Iuxta hoc, ergo propter hoc». «Per il punto di vista mitico è davvero la rondine che "fa" primavera» [67]
Il tema del simbolismo implicito si ripresenta al termine di questo percorso argomentativo. Del resto questo percorso intende anche evitare la via breve dell’associazione delle idee, che avrebbe subito fatto notare la diretta transizione immaginativa dalla contiguità alla conseguenza causale, per tentare di dare di questa transizione una motivazione in certo senso più organica e strettamente integrata in una modalità tipica dell’esperienza.
Di qui la funzione essenziale che assolve in tutto ciò il problema dell’analisi. Anche nei confronti di Hume e del modo in cui egli propone in sede di teoria della conoscenza il problema della causa, Cassirer obietta anzitutto che il difetto fondamentale della sua concezione e della sua critica psicologica è che «questa funzione analitica insita nel concetto di causalità non viene riconosciuta come si sarebbe dovuto fare» [68]e ciò ha come conseguenza «il fatto curioso che Hume, mentre in apparenza analizzava il giudizio causale della scienza, ha scoperto invece una radice di tutte le spiegazioni mitiche circa il mondo»[69].
Questo stesso interesse a esibire l’organicità del comportamento mitico nei confronti dei nessi causali, mette chiaramente in secondo piano l’ovvia falsità delle connessioni così istituite. Ciò che importa far notare è che questa falsità va considerata nella forma del suo prodursi, e allora ci rendiamo conto che essa fa parte di un vero e proprio unitario sistema del pensiero.
Si consideri, per esempio, in che modo viene proposto il problema dell’intero e della parte: anche qui il richiamo alla capacità analitica assolve una funzione essenziale per esibire questa sistematicità. Nella visione empirica del mondo l’intero è formato dalle sue parti ed è analizzabile in esse: le parti a loro volta saranno chiaramente differenziate dall’intero stesso. E anche in questo caso, la prima osservazione che deve essere compiuta in rapporto all’atteggiamento mitico nei confronti di questa relazione consisterà nel rilievo, ormai consueto, di una «mancanza di differenziazione». «Il tutto non ha parti e non si divide in esse; la parte è invece qui direttamente il tutto, esplica la funzione del tutto»[70]. Nel pensiero mitico vige allora il principio «Pars pro toto» - la parte in luogo dell’intero, dove ogni senso di rappresentanza meramente simbolica è naturalmente escluso: «Non si tratta di un nesso simbolico ideale, ma di un nesso oggettivo-reale»[71].
Esempi di una simile mancata differenziazione si trovano ovunque nelle pratiche magico-rituali. Gli stessi esempi che ritroviamo in Frazer per illustrare le fatture della magia secondo il nesso di contiguità possono naturalmente servire a questo scopo illustrativo. E del resto Frazer viene rammentato a questo punto. Ma mentre per Frazer, per esempio, le fatture compiute sui capelli tagliati di un uomo o sulle sue unghie documentano unicamente l’azione della legge psicologica associativa della contiguità, in Cassirer questi stessi esempi diventano significativi per mostrare l’insussistenza di un orientamento analitico e la connessione attraverso questa via con il problema della relazione causale: «Siccome il mito non conosce la forma di pensiero dell’analisi causale, per esso non ci può essere neppure il netto confine che solo questa forma di pensiero traccia tra il tutto e le sue parti»[72].
E se la coscienza della parte come tale rimanda a quella «funzione analitica e classificatoria del pensiero mediato che dagli oggetti, quali realtà concrete, risale alle loro condizioni costitutive»[73], vi è certamente da attendersi che nel pensiero mitico sia sostanzialmente assente un’autentica capacità di operare subordinazioni concettuali.Del resto il rapporto tra specie e genere può essere inteso come un caso particolare del rapporto tra parte e intero. La fusione e l’indistinzione si manifesta «non soltanto là dove si tratta di rapporti reali, ma anche dove si tratta di rapporti - nel nostro senso - puramente ideali»[74]. Pertanto vi sarà da un lato l’incapacità di elevarsi all’astrazione del concetto, e dunque la tendenza a concretizzare il genere stesso, dall’altro a considerare il genere come concretamente presente nelle sue «parti». Secondo Cassirer, anche prescindendo dal prendere posizione sulle varie ipotesi tendenti a spiegare l’origine e la natura del «totemismo», tuttavia la «concezione totemica» potrebbe essere rammentata per illustrare questa situazione.
È infatti indubbio che qui si fa valere una tendenza alla classificazione - una tendenza che tuttavia non ha modo di esplicarsi autenticamente proprio per la mancanza di consapevolezza del rapporto simbolico: «Nella suddivisione totemica non troviamo una semplice coordinazione fra le classi dì uomini e di cose da una parte e determinate classi di uomini e di animali dall’altra; qui invece il singolo viene pensato come dipendente in modo reale dal suo progenitore totemico e anzi come identico a esso»[75]. Ciò è coerente, non solo con la forma complessiva del pensiero mitico, ma anche con il mondo di esperienza costituito entro questa forma. Alla rigidità del mondo, come campo di oggettività da conoscere, quale si presenta al pensiero empirico, che comporta continue operazioni di distinzione e di confronto che confermino e fissino le cose nella loro determinatezza, si contrappone la fluidità del mondo proposta dal pensiero mitico come pensiero concreto. La stessa idea della specie umana e della nostra appartenenza a essa, apparentemente così ovvia, è in realtà un’acquisizione evoluta: «I limiti della specie uomo non sono affatto rigidi per la coscienza mitico-religiosa, ma del tutto fluttuanti... Per i gradi primitivi della concezione mitica non vi è ancora un taglio netto che divida l’uomo dal complesso dei viventi, dal mondo degli animali e delle piante». «Il ciclo rappresentativo del totemismo è caratterizzato proprio dal fatto che ivi l’affinità tra uomo e animale o, più esattamente, l’affinità tra un determinato clan e il suo animale o pianta totem vale non in senso figurato, ma nel senso proprio della parola»[76]. Tutto ciò «deve avere una ragione in qualche tratto generale della "logica" del pensiero mitico e soprattutto nella forma e nella direzione del suo modo di formare i concetti e le classi»[77].
Questo deve essere tanto più vero perché innegabilmente la coscienza primitiva «è caratterizzata proprio dall’acutezza con cui coglie tutte le sfumature sensibili concrete, tutte le differenze tra le forme percepite»[78]. Un riconoscimento alquanto raro nel testo di Cassirer: e del resto esso viene compiuto, marginalmente, in un contesto tutt’altro che favorevole ad una sua elaborazione in positivo. Infatti proprio questo acume della sensibilità, che assumerà tanta importanza in Lévi-Strauss per teorizzare la pensée sauvage come un sapere autentico, finisce con il rappresentare in Cassirer un vero e proprio ostacolo che si frappone all’esercizio di operazioni classificatorie realmente valide. In queste operazioni intervengono in generale atti del distinguere, del connettere, del paragonare. Ma la presenza di questi atti non è sufficiente di per se stessa per rilevare la presenza di una direzione conoscitiva efficace. Nel pensiero mitico essi si svolgono interamente sul terreno della immediatezza sensibile. Mentre occorre scorgere, ancora una volta, la connessione tra il problema qui in questione e quello dell’analisi causale.
La conoscenza empirico-teoretica suddivide l’essere in classi, ma per operare questa suddivisione fa intervenire considerazioni che rimandano alla causalità in un’accezione ampia del termine. Perciò sarebbe erroneo accentuare più del dovuto la parte assolta dalla sensibilità, quindi dalle «somiglianze o differenze riconoscibili dal punto di vista puramente sensibile»[79]. Una classificazione comincia infatti ad avere una portata conoscitiva effettiva solo quando tra i suoi criteri intervengono in modo determinante considerazioni relative ai rapporti di «discendenza», quando dunque è implicato «l’esame della successione e dei nessi causali della procreazione e della nascita»[80].
La centralità del problema causale come punto di riferimento che qualifica la direzione fondamentale della coscienza mitica trova naturalmente conferma anche nella tendenza alla sostanzializzazione che Cassirer riconosce come uno dei tratti caratteristici del pensiero mitico. Questa connessione appare direttamente nella forma immaginativa della metamorfosi così spesso assunta dalla causalità mitica dove il problema posto dalla processualità, nella sua concatenazione causale, viene risolto dal mito fissando un punto iniziale e un punto terminale del processo che saranno entrambi rappresentati da cose materiali e concependo il processo stesso come una trasformazione altrettanto materiale dell’una nell’altra[81].
Parlando di tendenza alla sostanzializzazione Cassirer non intende in realtà affermare una sorta di preferenza del pensiero mitico per la categoria della sostanza. Si tratta piuttosto di una sorta di indecisione che il pensiero mitico manifesta rispetto alla differenziazione tra la sostanza e le sue proprietà - anche questo rapporto non è altro che un caso particolare del rapporto tra parte e intero. Tanto più che Cassirer argomenta anche in questo caso in termini strettamente kantiani: la sostanza è, appunto, una categoria; dunque un «medio ideale» che rimanda a una funzione propriamente intellettuale di organizzazione dell’esperienza. Essa presuppone una duplicità di livelli - sensoriale e intellettuale - che interagiscono tra loro per istituire l’esperienza nella sua unità e stabilità. Il pensiero mitico invece, in quanto pensiero sensibile intuitivo, ignora questa duplicità, dispone «tutto il reale sullo stesso piano» [82]e pertanto non può che fluttuare tra sostanze e attributi inerenti, assumendo al più come modello la cosa così come si esibisce direttamente nella sua materialità sensibile concreta. Dentro questo quadro, interamente libero da riferimenti psicologici, andrà riassorbita la tematica associativa della somiglianza, cioè la tendenza a operare fusioni concrete sulla base di somiglianze esteriori.
Infine, dovunque viene ribadita la tesi del simbolismo implicito come condizione fondamentale che dà senso a questi sviluppi di dettaglio. Così, rammentando la credenza che la malattia contagiosa contratta da una comunità possa essere «trasferita» a un singolo, «per esempio ad uno schiavo ed essere eliminata con l’uccisione di questi», Cassirer osserva che «in tutti questi riti di purificazione e di espiazione non si tratta affatto, se si considera il significato originario dell’usanza, di una semplice rappresentazione simbolica, bensì di un trasferimento perfettamente reale e perfino fisico»[83]. Analogamente, considerando le unità associative fondate sulla somiglianza si fa notare: «Nel fumo che si sprigiona dalla pipa, il pensiero mitico non vede un semplice simbolo, né lo intende come un semplice mezzo per provocare la pioggia, ma ha dinanzi a sé in modo diretto e chiarissimo l’immagine della nube; e in questa la cosa medesima, cioè la pioggia desiderata. E un principio generale della magia che anche senza intraprendere alcuna azione "adeguata al fine" come noi la intendiamo si possano ridurre in proprio possesso certe cose unicamente per mezzo della loro rappresentazione mimica, giacché dal punto di vista della coscienza mitica non vi è nulla di semplicemente mimico, di semplicemente significativo»[84].
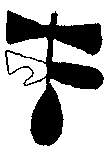 12. L’indifferenza verso i nessi causali secondo Lévy-Bruhl
12. L’indifferenza verso i nessi causali secondo Lévy-Bruhl
L’indifferenza alle condizioni causali più semplici è, come noto, una delle tesi centrali che secondo Lévy-Bruhl caratterizza ciò che egli chiama la «mentalità primitiva». Un confronto ravvicinato con la posizione di Cassirer sarebbe indubbiamente istruttivo ed anche se esso non può qui essere condotto a fondo merita di essere almeno accennato.
Nel più tardo Saggio sull’uomo (1944) Cassirer polemizza esplicitamente con la posizione di Lévy-Bruhl, con considerazioni che vanno in parte oltre lo spunto polemico mettendo in questione, almeno indirettamente, alcuni degli assunti fondamentali della propria Filosofia delle forme simboliche [85]. Da quest’opera una simile polemica è d’altra parte assente: Lévy-Bruhl viene abbastanza spesso rammentato, anche se non vi sono esplicite affermazioni di consenso e l’uso di alcuni termini caratteristici del filosofo francese è sempre accompagnato da una certa circospezione.
Anche senza considerare la posizione espressa nel Saggio sull’uomo, non c’è dubbio che vi è una netta distanza tra Cassirer e Lévy-Bruhl per ciò che concerne la cornice filosofica del problema, una cornice particolarmente massiccia e raffinata in Cassirer, lineare e relativamente elementare in Lévy-Bruhl. La differenza più vistosa sta in primo luogo nel fatto che Cassirer considera il pensiero primitivo all’interno del programma di una filosofia dello spirito, e quindi le sue produzioni come produzioni rette in qualche modo da regole «trascendentali» dell’esperienza mentre Lévy-Bruhl è legato ad un concetto di «mentalità primitiva» che conferisce ai suoi a priori una connotazione accentuatamente psicologica.
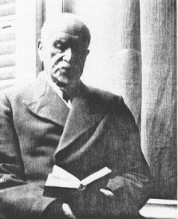 Secondo una direzione peraltro nettamente diversa da quella di Frazer. In Frazer infatti, come abbiamo osservato in precedenza, vale come presupposto la fondamentale unità della natura umana. Essa può differenziarsi in infiniti modi, in dipendenza dalle circostanze di natura storico-accidentale; ma per ciò che concerne l’apparato psichico considerato nelle sue strutture elementari, esso è ovunque lo stesso, e proprio questa identità rende possibile da parte nostra la comprensione di modi di comportamento che ci appaiono inizialmente inintelligibili. Lévy-Bruhl invece ritiene che per rendere realmente giustizia al modo di pensare e di agire delle popolazioni primitive sia necessario partire dal presupposto che vi sia, rispetto alle popolazioni «civili», una radicale differenza di «mentalità», dove questa parola deve essere assunta in un senso fortissimo: non si tratta di una pura e semplice differenza di atteggiamento nei confronti della realtà, ma di una differenza negli stessi meccanismi che regolano la produzione del pensiero. Il principio di non contraddizione non ha qui alcun carattere normativo - e ciò incide in maniera determinante sulla forma delle argomentazioni, anzi tende a sopprimere questa forma; mentre l’indifferenza ai nessi causali incide sulla forma stessa della realtà.
Secondo una direzione peraltro nettamente diversa da quella di Frazer. In Frazer infatti, come abbiamo osservato in precedenza, vale come presupposto la fondamentale unità della natura umana. Essa può differenziarsi in infiniti modi, in dipendenza dalle circostanze di natura storico-accidentale; ma per ciò che concerne l’apparato psichico considerato nelle sue strutture elementari, esso è ovunque lo stesso, e proprio questa identità rende possibile da parte nostra la comprensione di modi di comportamento che ci appaiono inizialmente inintelligibili. Lévy-Bruhl invece ritiene che per rendere realmente giustizia al modo di pensare e di agire delle popolazioni primitive sia necessario partire dal presupposto che vi sia, rispetto alle popolazioni «civili», una radicale differenza di «mentalità», dove questa parola deve essere assunta in un senso fortissimo: non si tratta di una pura e semplice differenza di atteggiamento nei confronti della realtà, ma di una differenza negli stessi meccanismi che regolano la produzione del pensiero. Il principio di non contraddizione non ha qui alcun carattere normativo - e ciò incide in maniera determinante sulla forma delle argomentazioni, anzi tende a sopprimere questa forma; mentre l’indifferenza ai nessi causali incide sulla forma stessa della realtà.
Perciò Lévy-Bruhl parla di una mentalità prelogica, secondo una direzione che sembra integrarsi nell’orizzonte culturale degli anni Venti nei quali la tematica dell’irrazionalismo desta particolare attrazione. Proprio la decisione con cui Lévy-Bruhl imbocca questa via è certamente uno dei motivi che spiegano la prudenza di Cassirer, avvertibile anche nella Filosofia delle forme simboliche, nei suoi confronti.
Resta tuttavia il fatto che l’uno e l’altro autore sono accomunati dall’idea di una coscienza mitica come una totalità coerente e unitaria che si regge su determinati principi e che può essere compresa solo in base a essi. E che questi principi hanno il loro centro nell’atteggiamento nei confronti dei nessi causali.
Su quest’ultimo punto l’orientamento di Cassirer bada soprattutto ai momenti formali, istituisce connessioni concettuali a partire da un ampio apparato filosofico. In Lévy-Bruhl invece il problema è affrontato in termini più direttamente contenutistici. Secondo Lévy-Bruhl la realtà si presenta al primitivo come dominata nel suo insieme e nei suoi dettagli da potenze e forze invisibili che egli chiama «mistiche». Questo dominio non rimanda tanto a entità trascendenti quanto ad una effettiva compenetrazione, a una partecipazione del mondo visibile e del mondo invisibile direttamente data nell’esperienza vissuta.
Non vi è alcun passaggio vero e proprio dal dato empirico alla potenza mistica, ma il dato empirico è investito da un senso mistico che viene colto immediatamente in esso. Lo stesso termine di «passaggio» osserva Lévy-Bruhl «conviene alle nostre operazioni discorsive», ma «non esprime esattamente il modo di attività della mentalità primitiva che assomiglia piuttosto a una apprensione diretta o ad una intuizione. Nel momento stesso che percepisce quel che è dato ai suoi sensi, il primitivo si rappresenta la forza mistica che vi si manifesta»[86].
Lévy-Bruhl insiste dunque sul carattere intuitivo, quindi sull’immediatezza dell’esperienza primitiva: vi è qui un rapporto analogo a quello che sussiste tra la parola e il suo senso, che noi sentiamo risuonare direttamente in essa; oppure a quello che si istituisce quando «leggiamo la simpatia o la collera nel viso di una persona senza aver bisogno di percepire prima i segni di quelle emozioni, per interpretare poi quei segni. Non è un’operazione che si compia in due tempi successivi. Avviene in un colpo solo». «In questo caso si può dire davvero che il mondo è un linguaggio che gli spiriti parlano ad uno spirito. Linguaggio che non ricorda di avere imparato e che le preconnessioni delle sue rappresentazioni collettive gli rendono naturale»[87].
Pur in un contesto molto diverso e con una terminologia propria affiorano qui idee interamente presenti nella posizione di Cassirer.
Ciò vale, io credo, anche per la tematica della causalità. Anche su questo punto, non troviamo in Lévy-Bruhl una discussione così ampia e così filosoficamente impegnativa come nel caso di Cassirer. Ci troviamo invece di fronte alla contrapposizione pura e semplice tra la nostra mentalità e quella primitiva. Anche indipendentemente da un atteggiamento rivolto in una direzione conoscitiva, osserva Lévy-Bruhl, negli atti più semplici della vita quotidiana è sempre presente l’idea della concatenazione causale degli eventi: «Noi abbiamo un senso continuo di sicurezza intellettuale che non vediamo come possa essere scosso; poiché anche supponendo l’apparizione improvvisa di un fenomeno del tutto misterioso e le cui cause ci sfuggissero interamente agli inizi, non saremmo per questo meno persuasi che la nostra ignoranza è soltanto provvisoria, che queste cause esistono veramente e che presto o tardi potranno essere determinate. Così la natura in seno alla quale viviamo è, per così dire, intellettualizzata in anticipo. La nostra attività quotidiana, fin nei suoi più umili particolari, implica una tranquilla e perfetta fiducia nella invariabilità delle leggi naturali»[88].
L’atteggiamento mentale del primitivo è invece radicalmente diverso proprio su questo punto. Non appena si presenta un evento insolito, egli vede senz’altro l’azione di una forza mistica e le cause naturali diventano per lui indifferenti o vengono indebolite a pure e semplici occasioni per il suo manifestarsi. Gli esempi più significativi che Lévy-Bruhl adduce a questo proposito riguardano il problema della morte:
«Dappertutto nelle società inferiori, la morte richiede una spiegazione diversa dalle cause naturali. Secondo un’osservazione che è stata fatta spesso, quando vedono morire un uomo, sembra che per loro questo fatto si verifichi per la prima volta e che non ne siano mai stati testimoni altre volte... Lo stesso indebolimento senile, come ogni malattia, non è dovuto neanch’esso a ciò che noi chiamiamo causa naturale: deve anche spiegarsi con l’azione di una forza mistica. Insomma, se il primitivo non presta alcuna attenzione alle cause della morte è perché egli sa già perché la morte si è verificata; e sapendo questo perché, il come gli è indifferente. Ci troviamo qui in presenza di una specie di apriori sul quale l’esperienza non ha presa»[89].
In che modo questo problema sia connesso con la tesi della partecipazione tra mondo visibile e mondo invisibile non ha certo bisogno di molte spiegazioni. Questa nozione assolve del resto in Lévy-Bruhl la stessa funzione di indicazione fondamentale unitaria a cui riportare e giustificare i comportamenti dei primitivi che è svolta, in Cassirer, dal principio dell’indistinzione tra il simbolo e la cosa.
Sembra anzi che si possa affermare, più impegnativamente, che ci troviamo di fronte a due formulazioni che, nonostante la diversità dei contesti, si implicano reciprocamente. A partire dall’indistinzione tra il simbolo e la cosa si giunge, per esempio, all’indistinzione tra il fisico-naturale e lo psichico-spirituale, e il materiale documentario a questo proposito potrebbe altrettanto bene essere impiegato per illustrare la partecipazione di cui parla Lévy-Bruhl, dai cui testi del resto esso è spesso tratto. Inversamente, stando all’esposizione di Lévy-Bruhl deve essere sempre dato per scontato che comportamenti e azioni siano fondate su credenze autentiche. Sembra dunque che, a partire dal postulato della indistinzione tra simbolizzante e simbolizzato si debba pervenire a quello della partecipazione e inversamente che, parlando di partecipazione, quella indistinzione debba essere senz’altro presupposta.
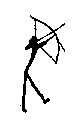 13. Il processo dello spirito e la rarefazione dei simboli
13. Il processo dello spirito e la rarefazione dei simboli
Ora è tempo di ritornare sui nostri passi: quando ci siamo chiesti le ragioni per le quali la relazione del mito all’immaginazione rappresenta in Cassirer solo un’ovvietà priva di interesse per una filosofia della mitologia ed abbiamo tentato, dopo di ciò, una sintesi della sua impostazione filosofica, il nostro scopo era già essenzialmente quello di approfittare dell’ampiezza e dell’articolazione della tematica in discussione per metterci alla prova.
Le nostre intenzioni sono infatti essenzialmente critiche: vogliamo sperimentare la nostra capacità di sviluppare una critica e nello stesso tempo cercare di guadagnare in rapporto ai problemi emersi un nuovo luogo di osservazione.
Abbiamo osservato in precedenza che la posizione di Cassirer può essere indicata come una posizione fenomenologico-strutturale, che è tuttavia proposta secondo una angolatura dalla quale l’ispirazione idealistica risulta determinante. Questo è il primo nodo che siamo interessati a tagliare. L’indubbia perfezione, la consumata abilità con la quale Cassirer riesce a far confluire l’uno nell’altro il momento idealistico con quello propriamente fenomenologico nasconde in realtà più di un problema.
Cominciando a indicare questo nodo non vorremmo semplicemente orientarci verso una critica dell’idealismo cassireriano considerato nei suoi lati più espliciti e manifesti. Nonostante la raffinatezza della elaborazione restano, nel complesso della ricerca cassireriana della Filosofia delle forme simboliche, alcuni atteggiamenti tipici ricorrenti che fanno parte dell’idealismo come luogo comune e ai quali è indubbiamente possibile contrapporre i luoghi comuni di una critica già compiuta.
Su di essi è certamente interessante richiamare l’attenzione perché individuano prima ancora che una filosofia, uno stile filosofico. Di questo stile fa indubbiamente parte l’esigenza di un punto di vista unitario portata al suo grado di esasperazione estrema. Il nostro scopo, se fossimo filosofi cassireriani, diventerebbe quello di mostrare che dalle primitive formazioni della comunicazione linguistica, dalle pratiche magiche più rozze alle forme religiose più evolute e, al di là di esse, alle tecniche dell’arte, alle tecniche in genere, sino alle più sofisticate teorie scientifiche moderne - dell’uomo delle caverne al grande cervello di Einstein - di tutto ciò vogliamo mostrare la derivazione da un unico centro. Magari scrivendo un libro enorme. L’enorme varietà del mondo deve poter essere non solo attraversata dal pensiero, ma anche ripensata e infine messa per iscritto in una sorta di enciclopedia filosofica.
L’esasperazione della tendenza all’unità come la vocazione enciclopedica sono appunto tratti che caratterizzano l’idealismo in genere. Con tutto l’apparato di immagini che essi comportano. Lo Spirito: il Maestoso fiume, il cui incedere non può essere realmente interrotto da nessuna interna conflittualità; il Grande Animale che muove dapprima torpidamente strisciando, e poi a poco a poco si eleva sempre più agilmente verso gli orizzonti della più compiuta spontaneità e autonomia; l’Albero Millenario la cui cima svetta alla fine nel terso cielo del pensiero puro.
L’idealismo è una filosofia elevata, è una filosofia dell’elevazione. E tutto il percorso della Filosofia delle forme simboliche procede verticalmente da un disordine primario a un ordine crescente, che è anche un ordine sempre più rarefatto. Vorremmo quasi dire: il processo dello spirito è un processo di progressiva spiritualizzazione - per quanto ciò possa sembrare strano.
L’esprimersi in questo modo, e proprio in rapporto a Cassirer, potrebbe certamente sollevare qualche perplessità. Infatti basterebbe rammentare i precisi spunti polemici che Cassirer rivolge a Kant in particolare per ciò che concerne la frattura fra sensibilità e intelletto: un atteggiamento critico che si concretizza, negli sviluppi particolari, in un’aperta difesa dei diritti della sensibilità, dell’elemento materiale in genere così come dell’elemento affettivo ed emotivo. E tuttavia, nonostante ciò, se consideriamo con attenzione la tematica cassireriana considerata nel suo insieme, non possiamo non sottolineare che una simile filosofia dello spirito descrive il suo processo come una graduale liberazione dalle impurità dei materiali sensibili.
Del resto di ciò abbiamo già discorso: proprio la nozione di simbolo assunta come nozione unificante di tutta la tematica cassireriana può assolvere questa funzione solo rarefacendosi e nello stesso tempo ponendo come modello e punto di arrivo l’attività produttiva di simboli che realizza un puro rapporto di significazione, nel quale non vi è più alcuna traccia delle cose e delle determinatezze dei contorni. La matematica ha per Cassirer anche questo fascino. E inoltre solo quando questa attività è stata conseguita si può parlare di un’azione autenticamente libera, di un’azione che non soggiaccia ad altre condizioni oltre quelle che le impone la soggettività stessa, una soggettività intesa come autocoscienza, come pensiero puro, come centro degli atti del puro volere.
La posizione cassireriana della nozione di simbolo contiene già, per quanto obliquamente e indirettamente, l’idea che la quintessenza delle operazioni spirituali stia nella loro perfetta trasparenza e impalpabilità. D’altronde, che cosa vuol dire «spirituale»? Eppure l’immagine della rarefazione come immagine della spiritualità non è affatto obbligatoria, e la sua adozione fa parte invece di una decisione filosofica. Siamo filosofi idealisti non semplicemente perché subordiniamo tutta la nostra filosofia sotto il titolo di «filosofia dello spirito», ma soprattutto perché siamo guidati nel nostro argomentare da immagini come queste. Tuttavia, come abbiamo osservato, la nostra riflessione critica non intende muoversi su un terreno così generale, e nemmeno compiere una troppo facile aggressione nei confronti dei tratti tipicamente idealistici della impostazione di Cassirer: vorremmo invece avviarci in una direzione più produttiva, tentando di considerare le conseguenze che derivano dalla sua impostazione entro il quadro di una filosofia dell’esperienza che, pur potendo essere, a sua volta, caratterizzata come orientata in senso fenomenologico-strutturale, sia tuttavia interamente libera da presupposti idealistici.
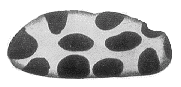 14. Riflessioni sulla nozione di esperienza mitico-religiosa
14. Riflessioni sulla nozione di esperienza mitico-religiosa
Il primo punto su cui è interessante prestare attenzione riguarda la stessa nozione di esperienza mitico-religiosa o, più semplicemente, di esperienza religiosa, assumendo quest’ultimo termine nella sua accezione più lata. La consistenza di questa nozione è naturalmente presupposta in Cassirer con argomenti che rimandano a considerazioni di carattere fenomenologico: come abbiamo rammentato a suo tempo, Cassirer fa valere nei confronti di Husserl la necessità di ampliare, dal punto di vista dei compiti analitici, il campo delle direzioni intenzionali della coscienza, così come, in stretto parallelismo, fa valere nei confronti di Kant, il problema di una estensione della tematica categoriale che sappia abbracciare le modalità dell’esperienza che giacciono al di fuori di un orizzonte epistemologico. La nozione di esperienza religiosa sta del resto alla base della cosiddetta «fenomenologia della religione» che ha assunto da tempo lo statuto di una disciplina autonoma all’interno delle scienze dei fatti religiosi in genere. Per quanto possano essere differenziati i suoi impieghi, si tratta pur sempre di assumere l’esperienza religiosa tra le esperienze vissute con la conseguente proposizione di compiti descrittivi specifici, rivolti nella duplice direzione soggettiva e oggettiva della polarità intenzionale.
Naturalmente, il parlare di esperienza religiosa non pone nessun problema se una simile espressione viene utilizzata in una accezione filosoficamente non troppo impegnativa facendo eventualmente poggiare il suo impiego sull’esistenza di credenze e pratiche che sono dati di fatto culturali incontestabili. Questi dati di fatto rimandano a modi di sentire e di concepire il mondo che hanno le loro peculiarità e pongono un’amplissima gamma di problemi di varia natura.
Le cose stanno molto diversamente se con esperienza religiosa si intende o si sottintende un’esperienza semplice, un esperienza che non solo sta a fondamento di determinati comportamenti, ma che è definita da una caratteristica direzione verso l’oggetto, anzi, più precisamente, da un oggetto intenzionale caratteristico, che potremmo designare come il sacro stesso, anche se questa designazione potrà essere assunta non solo come libera da implicazioni direttamente ontologiche, ma anche come una designazione indeterminata che proprio l’indagine descrittiva avrebbe il compito di riempire di contenuto.
Per chiarire meglio in che senso si parli qui di esperienza semplice, è opportuno richiamare l’analogia con i fatti della percezione in genere. La complessità di ogni esperienza percettiva, il fatto cioè che in essa intervengano componenti di varia natura - componenti emotive, memorative, immaginative, interpersonali, socioculturali, ecc. - tutto ciò è naturalmente fuori questione. E ciononostante è lecito citare la percezione come esempio di un’esperienza vissuta semplice in quanto vi è qui indubbiamente la possibilità analitica di isolare la funzione costitutiva assolta, così come è determinatamente indicabile l’oggettività che nella percezione si ha di mira.
 Parlando di esperienza religiosa come esperienza semplice intendiamo allora non già una nozione che un generico rimando a esperienze vissute del genere più vario basta a giustificare, ma una nozione che è costruita su un preteso parallelismo con le esperienze percettive.L’esperienza religiosa potrebbe allora essere definita come percezione del sacro. E allora si vede subito che l’affermazione «esiste una percezione del sacro» cessa di essere ovvia e che si possono di conseguenza avanzare dubbi sulla sua effettiva consistenza.
Parlando di esperienza religiosa come esperienza semplice intendiamo allora non già una nozione che un generico rimando a esperienze vissute del genere più vario basta a giustificare, ma una nozione che è costruita su un preteso parallelismo con le esperienze percettive.L’esperienza religiosa potrebbe allora essere definita come percezione del sacro. E allora si vede subito che l’affermazione «esiste una percezione del sacro» cessa di essere ovvia e che si possono di conseguenza avanzare dubbi sulla sua effettiva consistenza.
Un primo segno di inconsistenza sta nel fatto che la nozione di esperienza religiosa, non appena viene proposta, non può essere propriamente teorizzata, ma alla sua teorizzazione deve subentrare la pura e semplice constatazione del vissuto, una constatazione da effettuare necessariamente in prima persona, cosicché l’indagine deve assumere fin dall’inizio un andamento pronunciatamente introspettivo.
Questo orientamento introspettivo, che si trova in netto contrasto con uno stile di indagine fenomenologico-strutturale, è espresso con esemplare chiarezza in un passo del volume di Rudolf Otto intitolato Il Sacro (1917), nel quale la nozione del sacro non viene discussa e introdotta secondo uno stile argomentativo ed a partire da un apparato teologico precostituito, ma facendo riferimento alla nozione di esperienza religiosa nel senso in cui ne parlavamo poc’anzi. Rudolf Otto, fin dalle prime pagine, ci mette di fronte, coerentemente, alla circostanza che l’esperienza religiosa nel suo insieme, così come le determinazioni particolari del sacro che andiamo via via estraendo da essa, possono essere comprese solo a caldo, cioè solo se siamo effettivamente partecipi di essa, se la condividiamo nel nostro intimo.
Abbiamo appena letto poche pagine di questo libro, siamo stati appena informati che l’esperienza del sacro è una esperienza del «numinoso», secondo la particolare parola coniata da Otto, stiamo anzi sforzandoci di capire che cosa mai questo neologismo possa significare, quando veniamo perentoriamente ammoniti: «Invitiamo il lettore a rievocare un momento di commozione religiosa e possibilmente specifica. Chi non può farlo o chi non ha mai avuto tali momenti è pregato di non leggere più innanzi»[90].
Il problema della comunicazione decide anche la questione del parallelismo con gli atti percettivi in genere. In certo senso, anche in rapporto ad essi ci si potrebbe avventurare a sostenerne l’incomunicabilità - perché è certo che non potrò mai trasferire le mie sensazioni uditive nell’orecchio di un altro. Ogni fenomenologia della percezione soggiace d’altra parte alla condizione che qualunque cosa si dica, per esempio, intorno al vedere o all’udire, si sappia già di che si tratta. In che cosa consista l’esperienza di udire un suono, questo non lo posso affatto spiegare. Eppure questa incomunicabilità non ci preoccupa, perché un’intesa è qui già da sempre presupposta. Mentre le cose stanno in maniera del tutto diversa nel caso dell’esperienza religiosa: la radicale assenza di un’intesa si rivela nel fatto che non solo, se qualcuno mi invita a «rievocare un momento di commozione religiosa e possibilmente specifica», io non so assolutamente che cosa dovrei fare; ma anche: ammesso che un’altra persona sappia che cosa sia avere un momento di commozione religiosa, io non so nemmeno esattamente che senso abbia per me il dire di non averlo. A me non manca nulla.
In fin dei conti è proprio questa idea della mancanza che decide l’inconsistenza del parallelismo su cui si fonda la nozione di esperienza religiosa come esperienza semplice. A questo proposito la metafora della cecità, che così spesso ricorre per indicare l’assenza di commozioni religiose, meriterebbe di essere presa alla lettera.
I termini del confronto sembrano qui essere particolarmente vicini, se si pensa che la parola «vedere» sarà per sempre priva di contenuto per un cieco. E tuttavia sarebbe sbagliato risolvere questa mancanza, che è certo concretamente avvertita, in una sorta di sensazione interiore relativa alla parola «vedere». Essa riguarda piuttosto una rete di impedimenti, e chi non vede sa benissimo che cosa significhi «vedere» perché sa che, vedendo, questi impedimenti sarebbero tolti. Egli sente una mancanza e sa che cosa gli manca.
I termini del confronto si allontanano a questo punto irrimediabilmente e il parallelismo appare così interamente privo di fondamento. Ciò significa che non esiste, accanto a tutte le varie nostre facoltà, una specifica facoltà di apprensione del sacro, che in taluni è attiva e in altri invece è andata incontro a un processo di disfunzione e di ottundimento.
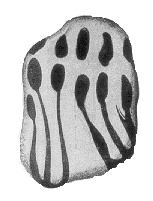 15. Riapertura del problema
15. Riapertura del problema
Si noterà che solo in parte le osservazioni precedenti toccano l’impostazione propriamente cassireriana del problema. In effetti, l’impianto kantiano suggerisce a Cassirer direttamente il problema non tanto della qualità dell’esperienza mitico-religiosa, quanto quello delle sue categorie. Considerazioni di carattere introspettivo vengono dunque in linea di principio escluse.
Tuttavia l’orientamento che ci conduce ad affermare, contro l’idea della semplicità dell’esperienza mitico-religiosa, il suo carattere composito si sviluppa fin dall’inizio in una direzione completamente diversa.
In base a esso infatti non solo mettiamo da parte i compiti di un’indagine introspettiva, ma anche un programma di ricerca che sia tutto puntato sulla forma di unità dell’esperienza mitico-religiosa e dunque su questa esperienza come costitutiva di un mondo.
In effetti, se da un lato l’impianto kantiano fa si che Cassirer eviti un approccio di carattere introspettivo, dall’altro questo stesso impianto pregiudica in questa direzione i compiti che egli ascrive a una fenomenologia dell’esperienza mitico-religiosa. L’analogia con il mondo costituito nella percezione si impone in ogni caso, benché da un diverso punto di vista: come ci sono forme strutturali dell’esperienza percettiva, di quella esperienza cioè che sta alla base della visione empirico-teoretica del mondo, così debbono esservi forme strutturali dell’esperienza mitica.
Parlando del carattere composito dell’esperienza mitico-religiosa noi ci avviamo invece fin dall’ inizio ad attribuire a una analitica fenomenologica il compito preliminare di penetrare in questa composizione per mettere in evidenza il ruolo che assolvono le sue componenti: e a questo titolo può essere riproposto il problema della relazione del mito all’immaginazione.
Con ciò facciamo indubbiamente regredire il nostro problema dal terreno di una filosofia dello spirito a quello di una filosofia dell’esperienza nella quale la vecchia distinzione tra le facoltà assume ancora un ruolo. Più precisamente: cominciamo a far valere le ragioni di una considerazione fenomenologico-strutturale orientata in una direzione nettamente anti-idealistica. In effetti, uno degli aspetti che caratterizza il passaggio storico-filosofico all’idealismo romantico è proprio l’abbandono e la critica dello schematismo delle facoltà entro il quale è, in fin dei conti, ancora ordinata la filosofia kantiana dell’esperienza. L’articolazione e le distinzioni tra le facoltà si presentano al filosofo idealista come il risultato di un modo di pensare che pone l’accento sulla separazione piuttosto che sull’unità e che rischia di irrigidire il corso fluente della totalità della vita spirituale.
Potremmo dire addirittura che lo stesso concetto dello Spirito che si fa avanti nella prospettiva idealistica con la massima enfasi può essere considerato come cresciuto in opposizione al tema delle facoltà. Di qui in avanti non parleremo più delle facoltà e quindi delle loro articolazioni, delle loro connessioni e intrecci, da porre in evidenza analiticamente, ma dello spirito come una unità inscindibile e in continuo movimento, la cui tematica va sempre colta sinteticamente, in uno sguardo di insieme.
Vi è dunque un’implicita tensione polemica in una filosofia dell’esperienza che impieghi il riferimento alle facoltà come un modo di ordinare i propri problemi - una tensione che dovrà riuscire a concretizzarsi mostrando la centralità della tematica dell’immaginazione ai fini dell’impostazione preliminare delle questioni filosofiche che possono essere proposte in rapporto al pensiero mitico.
 16. L’immaginazione come facoltà dell’eterogeneo
16. L’immaginazione come facoltà dell’eterogeneo
Va da sé che non siamo affatto convinti che le ragioni che tengono lontano questo problema della tematizzazione cassireriana siano senz’altro da condividere. Secondo Cassirer, il richiamo all’immaginazione deve essere escluso in primo luogo per il fatto che esso imporrebbe all’indagine un’impronta nettamente psicologistica: e proprio su questo punto egli si richiama all’impostazione metodica della fenomenologia husserliana. |168| Tuttavia, stando a quella impostazione, il problema si pone in realtà in modo assai diverso: dentro il quadro di una filosofia fenomenologica dell’esperienza, si pone naturalmente anche il compito di una fenomenologia dell’immaginazione nettamente distinta dall’ambito delle questioni psicologiche. Un’ovvia conseguenza di ciò è che il problema della relazione tra mito e immaginazione potrà essere affrontato da questo punto di vista senza che si stabilisca alcun nesso necessario tra la natura del problema e la sua risoluzione in termini psicologistici.
Ciò che vale dal punto di vista metodico per l’immaginazione in generale vale anche per le sue specificazioni.Il mito può essere considerato una specificazione dell’immaginazione.La nostra indagine si orienta in questa direzione e i suoi sviluppi successivi sono essenzialmente determinati da questo punto di avvio. Dobbiamo anzitutto fissare in breve una caratterizzazione corretta della facoltà di produrre immagini in generale, in modo da poter disporre delle prime indicazioni senza le quali non potremmo muovere nemmeno i primi passi. Tutta un’ampia serie di problemi si apre poi non appena volgiamo la nostra attenzione alle molteplici modalità in cui si realizzano le funzioni immaginative.
Come parliamo per esempio dell’immaginazione poetica o musicale, così possiamo parlare dell’immaginazione in quanto il suo operare si esplica nelle produzioni mitiche - e siamo tenuti allora ad accertare, mantenendo fermo lo stile puramente fenomenologico dell’indagine, le differenze che la caratterizzano in quanto immaginazione specificamente mitica.
L’indicazione generale da cui prendiamo le mosse potrebbe essere formulata così: l’immaginazione è la facoltà dell’eterogeneo.Questa formula non è certamente una definizione, ma un concentrato di problemi: e noi non cercheremo di dare di essa un’ampia giustificazione [91] ma di fornire le poche indicazioni utili per comprendere il suo senso orientandola nella direzione del nostro problema.
Diremo allora che ciò rispetto a cui le produzioni immaginative sono eterogenee è la realtà stessa - una nozione che viene dunque senz’altro presupposta. Questo riferimento alla realtà non è propriamente un riferimento per opposizione, altrimenti avremmo parlato più semplicemente di facoltà dell’irreale. Quella formula intende invece contestare la pura e semplice opposizione tra reale e irreale come sufficiente a rendere conto dello statuto dei contenuti immaginativi. Piuttosto che di opposizione, si potrebbe parlare di diversità, benché anche questo termine non sia realmente adatto. Ogni valutazione di diversità presuppone infatti uno strato in qualche modo omogeneo, presuppone tratti comuni a partire dai quali abbia senso mettere in risalto le differenze. Impiegando la parola «eterogeneo» noi vorremmo invece mettere fuori gioco anche questo strato di omogeneità, vorremmo alludere a una sorta di diversità radicale che può essere illustrata con l’immagine delle rette parallele: esse giacciono l’una accanto all’altra, hanno in qualche modo a che vedere l’una con l’altra e formano perciò una configurazione unitaria, e tuttavia forniscono l’immagine di una radicale indipendenza reciproca.
Le nostre considerazioni cominciano dunque con il sottolineare un netto dualismo, una disparità di livelli: il livello della realtà e il livello immaginativo. Quest’ultimo può essere indicato come un campo di irrealtà solo pagando il prezzo di possibili equivoci: si tratta piuttosto di una realtà totalmente altra, di una realtà parallela. Fin dall’inizio ci troviamo dunque a rilevare una sorta di doppiezza, a porre l’accento su una unità paradossale che rimanda a una scissione profonda.
Lo stesso problema dell’eterogeneità può anche essere introdotto ed illustrato osservando che gli oggetti e gli eventi immaginativi sono essenzialmente caratterizzati dal fatto che a essi sono inapplicabili le distinzioni tra vero e falso, tra esistente e inesistente.
Per intendere la portata di questo punto, pensiamo alla tematica della percezione. Poiché ci riferiamo qui all’immaginare come a una modalità dell’esperienza, è abbastanza naturale che le circostanze che la caratterizzano siano messe in evidenza attraverso il rimando comparativo ad altre modalità. In Cassirer, sia pure per tutt’altre ragioni, si nota una volta che il termine tedesco che indica la percezione (Wahrnehmung)contiene persino nella forma linguistica un richiamo al problema della verità[92]. Questa osservazione è compiuta da Cassirer per sottolineare che ogni percezione è in qualche modo un giudizio implicito e in essa sono dunque immanenti determinate operazioni categoriali-intellettuali. Su questo modo di approfittare della peculiarità del termine tedesco si potrebbe avanzare qualche dubbio: in fin dei conti ci potrebbe apparire almeno una forzatura il presentare ogni nostro atto percettivo come accertamento di verità. Sarebbe invece opportuno distinguere tra percezione e constatazione:dove con percezione possiamo intendere il puro e semplice afferramento visivo o uditivo di qualcosa, mentre la constatazione è appunto l’accertamento che noi compiamo visivamente o uditivamente di qualcosa che c’è. Tuttavia poiché ogni percezione può assumere la forma di una constatazione, può essere giustificato segnalare la presenza del problema della verità già sul piano degli atti semplicemente percettivi.
Nella percezione la cosa è posta come sussistente qui e ora di fronte a me. Parleremo pertanto del carattere posizionale della percezione come di un carattere che appartiene alla sua essenza fenomenologica. Tenendo conto di ciò diremo che l’immaginazione non ha carattere posizionale ovvero che in essa ogni posizione d’essere viene neutralizzata.Poiché una simile neutralizzazione toglie di mezzo non solo la sensatezza della domanda sulla sussistenza o insussistenza, ma la possibilità di un confronto tra oggetti immaginativi e oggetti reali, per questa via facciamo ritorno al tema della eterogeneità.
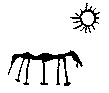 17. Avviamento della critica alla tesi del simbolismo implicito
17. Avviamento della critica alla tesi del simbolismo implicito
Eterogeneità e neutralizzazione delle posizioni d’essere, nella loro reciproca implicazione, è tutto ciò che ci serve per muoverci incontro al nostro problema.
Certamente non è facile intravedere senz’altro in che modo una simile caratterizzazione elementare dell’immaginazione in generale possa fornire indicazioni sul tema dell’immaginazione mitica.
Tutto ciò riguarda anche la trasposizione del tema della neutralizzazione sul lato soggettivo, cioè sul lato delle condizioni che debbono essere soddisfatte per l’apprensione dei contenuti immaginativì. Alla neutralizzazione delle posizioni d’essere che riguarda le entità e gli eventi immaginari corrisponde da questo lato una sorta di neutralizzazione della credenza.Se consideriamo, per esempio, il caso di una rappresentazione teatrale, è chiaro che alcune condizioni debbono essere soddisfatte affinché lo spettatore si disponga nel giusto rapporto nei confronti dello spettacolo. Questa disposizione deve essere strettamente correlativa al carattere non posizionale degli eventi proposti nella scena. Ed essa non può essere certamente indicata parlando di una credenza autentica nell’effettività degli accadimenti rappresentati; ma nemmeno parlando di una costante coscienza del loro carattere fittizio, come se la coscienza della falsità fosse lo sfondo attuale e permanente della visione dello spettacolo. Nell’uno come nell’altro caso, per motivi diversi, si avrebbe una soppressione di quella forma di partecipazione che è appunto condizione della ricezione delle produzioni immaginative in generale. Lo spettatore partecipa invece allo spettacolo anzitutto in quanto vive le scene che gli si dispiegano dinanzi in una credenza neutralizzata. Che è quanto dire: egli crede agli eventi rappresentati e nello stesso tempo non vi crede, senza che in questo sussista alcuna contraddizione. Infatti ciò che accade qui è essenzialmente una sorta di dislocazione temporanea dello spettatore sul piano stesso su cui accadono gli eventi dello spettacolo, sul piano della realtà eterogenea dell’immaginazione.
Con ciò si sbarazza il terreno da un altro dei motivi critici che potrebbero essere mossi alla riproposta della questione del mito a partire dalla problematica dell’immaginazione. Non solo è sbagliato ritenere che una simile via conduca a distorsioni psicologistiche ma anche che essa proponga senz’altro una considerazione del mito dal punto di vista dell’errore. Da una simile obiezione noi ci troviamo al riparo proprio perché essa rimanda a quella caratterizzazione dell’immaginazione come facoltà dell’irreale che è stata da noi respinta in via preliminare.
Ciononostante non risulta ancora chiaro se da tutto ciò possiamo trarre indicazioni realmente significative in relazione al problema dell’esperienza mitico-religiosa. Considerando la questione a un primo sguardo, tenderemo probabilmente a dare a questa domanda una risposta negativa. Un racconto mitico è certamente anzitutto un racconto, e noi lo possiamo considerare dunque alla stregua di ogni altro racconto liberamente inventato. Ma sappiamo già che non è così per la coscienza mitica. Analogamente, una cerimonia religiosa è qualcosa di interamente diverso da una rappresentazione teatrale - anche se l’elemento spettacolare non è certo assente. Per quanto possano essere messe in rilievo affinità, andrà sottolineato anzitutto che il modo della partecipazione ad una rappresentazione teatrale e ad una cerimonia religiosa - quindi anche il modo della «credenza» - è in entrambi i casi profondamente diverso. Del resto il carattere totalmente esplicito dell’origine e della natura immaginaria delle produzioni mitiche sopprimerebbe ovviamente l’esperienza mitica stessa. Come è chiaro, ciò che fin d’ora è in questione è proprio il problema centrale di Cassirer, il problema del simbolismo implicito. Per quanto in Cassirer si tratti propriamente di una teorizzazione dell’inconsapevolezza della distanza simbolica, essa fa tutt’uno con l’inconsapevolezza della natura immaginativa del mito, e proprio per il fatto che questa natura non fa parte dell’esperienza vissuta essa non può entrare in linea di conto nella sua fenomenologia.
E tuttavia noi vogliamo insistere proprio su questa strada. La tesi del simbolismo implicito non coglie nessun indizio interessante nel tema della credenza neutralizzata e in realtà è interamente orientata in direzione della credenza autenticamente posizionale.
Si tratta di un punto che va sottolineato con particolare decisione per il fatto che, essendo quella tesi formulata essenzialmente avendo di mira la relazione simbolica, potrebbe sembrare che la questione della verità e della falsità non venga affatto sfiorata. E chiaro invece che l’inconsapevolezza della distanza tra simbolo e simbolizzato ha come conseguenza l’effettuazione di posizioni d’essere, e precisamente di posizioni d’essere false. Nella misura in cui la distanza simbolica viene tolta, le connessioni immaginative diventano connessioni reali. La rondine produce realmente la primavera, la persona intera è realmente presente nelle sue parti, fra cose simili vi è una effettiva identità sostanziale. E tutto ciò è naturalmente falso. Vi è dunque un significativo punto di intersezione tra autori tanto diversi come Cassirer e Frazer (e del resto anche Lévy-Bruhl). La differenza sta essenzialmente nella posizione che questo problema assume nell’uno e nell’altro: una posizione centrale in Frazer, laddove Cassirer ci avverte subito che il tema della falsità non può occupare alcuna parte rilevante in una filosofia della mitologia correttamente impostata.
Tuttavia, se ora, liberi da preoccupazioni espositive, ritorniamo a riflettere sul simbolismo implicito e sull’ovvio corollario che ci impone di assumere la credenza nei prodotti del pensiero mitico come una credenza autenticamente posizionale, cominciamo a dubitare della sua effettiva praticabilità come principio dell’interpretazione. Vi deve essere in esso, certamente, qualcosa di giusto: l’esempio di una qualunque pratica magica sembra attestare la sua ovvietà ed evidenza. Ma che invece si nascondano proprio in questo assunto numerosi problemi è in fondo mostrato dalla stessa insistenza con la quale Cassirer di continuo lo ribadisce e in qualche modo cerca di documentarlo. La tesi del simbolismo implicito formula una condizione di confusione - e ora possiamo aggiungere: una confusione tanto grossolana da apparirci quasi inverosimile. L’immagine viene confusa con la cosa rappresentata; le nuvolette di fumo che escono dalla mia pipa con le nuvole che si rincorrono in cielo. Io, uomo civilizzato, so distinguere l’una cosa dall’altra. Lui, il selvaggio, fonde e confonde l’una e l’altra cosa. E veramente possibile questo? Non accade forse qui che quel tanto di giusto che è contenuto nella tesi del simbolismo implicito appaia totalmente compromesso se quella tesi viene presa alla lettera e in particolare se essa viene intesa nella direzione di una nozione posizionale della credenza?
Si tratta di dubbi più che giustificati. Se da un lato la pura e semplice nozione della neutralizzazione considerata nella sua generalità, non pare all’inizio esserci di particolare aiuto, non vi è dubbio che l’adozione del punto di vista del simbolismo implicito può apparirci come inficiata da difficoltà a cui è possibile dare una forma particolarmente urtante. In realtà dobbiamo riportare la riflessione proprio sul tema elementare della neutralizzazione e in particolare sul dualismo che in esso è implicato. Prendendo così sempre più le distanze dalla posizione di Cassirer.
Come abbiamo notato più volte, la tematica dell’unità è dominante nello stile filosofico di Cassirer, fa in certo senso corpo con il suo idealismo. Ed essa si ritrova naturalmente nell’elaborazione del problema dell’esperienza mitica. Questa esperienza non soltanto viene proposta come costitutiva di un mondo strettamente omogeneo, ma anche come una modalità esclusiva dell’esperienza, come una modalità proposta globalmente in opposizione ad altre. Basti pensare al fatto che i caratteri del pensiero mitico vengono di continuo illustrati in opposizione a ciò che Cassirer definisce pensiero empirico-teoretico. Si tratta certamente di un’opposizione concettuale, che tuttavia comporta nello spirito e nel senso della posizione cassireriana, la negazione di una possibile coesistenza. Il mondo mitico è, in altri termini, un mondo compiuto e completo che corrisponde ad una fase primaria della costituzione del mondo: l’«empiria» è qui in generale esclusa e può sorgere solamente al suo crepuscolo. Solo quando, in seguito ad un complesso sviluppo dialettico-fenomenologico la soggettività ha acquisito coscienza di sé, essa può assumere rispetto al mondo che la circonda quella distanza che è necessaria per l’effettuazione di autentiche constatazioni.
Prestare attenzione al dualismo significa, in certo senso, riformulare la stessa nozione di pensiero empirico e di mondo empirico ripresentando il problema della sua connessione con l’esperienza mitica. Già Cassirer tende a distinguere tra pensiero empirico e pensiero scientifico, benché nel primo veda subito profilarsi l’orizzonte della scienza. Noi potremmo allora in primo luogo calcare la mano su questa differenza; un conto è l’acquisizione di un orientamento rivolto al mondo circostante secondo un intento conoscitivo programmatico e sistematico, e un altro è concludere dall’assenza di un simile atteggiamento alla totale immersione in una realtà costituita emotivamente e dunque miticamente, all’esclusione che si diano elementi di conoscenza autentica, benché interamente affidati alla sensibilità e strettamente integrati nel campo dei bisogni e degli scopi della vita. Il riferimento all’empiria, ad una costituzione pratico-esperienziale del mondo, che non si propone affatto secondo una semplice simmetria oppositiva al mondo mitico, appare in realtà essenziale alla stessa impostazione del problema.
Qui del resto tocchiamo l’effettivo nodo critico di ogni concezione che in qualche modo presupponga tacitamente o esplicitamente una nozione posizionale della credenza nell’ambito dell’atteggiamento mitico. Queste concezioni non possono mai essere prese alla lettera - in questo sta tutta la sostanza della critica che può essere a esse rivolta. Ciò vale in particolare per la posizione di Cassirer. Benché egli cerchi di mostrare che l’indistinzione tra simbolizzante e simbolizzato rappresenta un vero e proprio criterio per l’interpretazione delle operazioni mitiche come operazioni che conducono ad una coerente organizzazione del mondo, tuttavia quella indistinzione, se presa alla lettera, sopprime qualunque possibilità della costituzione di un mondo in generale. Lo stesso vale anche per la pretesa indifferenza alla contraddizione di cui parla Lévy-Bruhl; oppure per l’idea di un totale assorbimento nelle connessioni associative secondo ciò che teorizza Frazer. Da un lato queste concezioni esigono di essere prese alla lettera, altrimenti esse ci rimettono tutta la loro pregnanza ed il loro interesse; dall’altro possono esserlo solo a patto di tacere del tutto sul fatto che vi è una organizzazione dell’esistenza che presuppone una precisa cognizione empirica dell’ambiente circostante, una cognizione che coesiste con le operazioni vere e proprie della coscienza mitica.
La prospettiva nella quale ci muoviamo presuppone dunque che il mondo circostante quotidiano appaia al primitivo esattamente come appare a noi, che si dia uno strato del mondo che si costituisce esattamente nelle stesse forme e negli stessi modi. E addirittura, come osserva Wittgenstein in un testo che prenderemo fra breve in considerazione, che la conoscenza della natura del primitivo non sia affatto fondamentalmente diversa dalla nostra[93].
La conoscenza della natura di cui qui si parla non è evidentemente una conoscenza acquisita programmaticamente che si procura via via i propri strumenti nella posizione di un fine conoscitivo autonomo, ma è quella conoscenza che possiamo considerare concresciuta nella stessa costituzione pratico-esperienziale della realtà. Anche il primitivo conosce la legge di gravità, nella misura in cui sa benissimo che una pietra cadrà inesorabilmente a terra se la solleviamo in alto e poi abbandoniamo la presa. E se conosce la legge di gravità in questo senso conosce nello stesso senso una vera folla di altre leggi: benché non le conosca affatto in quanto leggi. Del resto noi le conosciamo esattamente nello stesso modo nelle nostre azioni quotidiane.
Per il primitivo come per noi si tratta di momenti che fanno direttamente parte dello stile del mondo così come esso viene praticato nella nostra esperienza di esso.
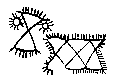 18. Doppiezza della credenza e coscienza dell’immagine
18. Doppiezza della credenza e coscienza dell’immagine
Ma in che modo il riconoscimento che abbiamo or ora effettuato si connette con un diverso punto di vista sulla costituzione del mondo mitico mettendo in questione la tematica della credenza neutralizzata e mostrando così la rilevanza della componente immaginativa della stessa compagine dell’esperienza mitica come esperienza vissuta?
In effetti, se ripensiamo ai materiali che siamo andati prendendo via via in esame, secondo un punto di vista che è stato reso attento a questo lato del problema, siamo colpiti da una circostanza alla quale tenderemmo ora ad attribuire la massima importanza: ogni documentazione relativa a pratiche o a comportamenti mitico-magici è in realtà sempre accompagnata dal sottinteso che queste pratiche e questi comportamenti sono localizzati su un terreno completamente diverso rispetto alle pratiche, alle azioni, ai comportamenti ed alle credenze in senso usuale.
Per esempio: in Lévy-Bruhl si parla delle previsioni intorno al decorso di una malattia attraverso la pratica del gettare i dadi[94]. L’episodio, narrato così, potrebbe farci concludere che non ci si rende conto della mancanza di connessione tra la malattia e il tiro dei dadi, che il primitivo istituirebbe una connessione profonda tra eventi che non hanno nemmeno una connessione superficiale. La narrazione ha tuttavia un sottinteso, e precisamente è sottinteso che la previsione è possibile solo se i dadi vengono tirati da una determinata persona, il cosiddetto uomo-medicina. Se qualcun altro, per esempio un congiunto del malato, effettuasse il tiro dei dadi, il risultato verrebbe certamente ritenuto insignificante ai fini della previsione. Ci chiediamo allora: crede o non crede colui che si affida ad una simile pratica che esista una connessione profonda tra la malattia e il tiro dei dadi? In realtà accade qui che la stessa azione può ricevere due sensi, o più precisamente, la stessa azione non è affatto la stessa se la compie una persona qualunque oppure se la compie lo stregone. Compiuta dallo stregone essa appartiene ad una sfera di azioni completamente diverse dalle azioni quotidiane. E se da un lato il presagio affidato allo stregone mostra che si istituisce una relazione profonda tra la malattia e il tiro dei dadi, dall’altro il fatto che la stessa azione non possa essere svolta da chiunque mostra che non si istituisce alcuna connessione profonda tra la malattia e il tiro dei dadi.
Oppure si pensi all’esempio, di genere diverso, ma che illustra lo stesso problema, della malattia concepita come un corpo estraneo - una pietra o un animale - che è entrato nel malato e deve esserne cacciato fuori.
Cassirer si serve di questo esempio essenzialmente per illustrare la tendenza alla sostanzializzazione che sarebbe propria del pensiero mitico[95]. Alla base di una simile concezione della malattia vi è certamente un’immagine, ma essa c’è solo per noi, e non invece per chi è totalmente immerso nell’atteggiamento mitico. La cosa che è la malattia è proprio una cosa come tutte le altre: ogni coscienza dell’immagine è esclusa.
Noi ci chiediamo invece fino a che punto si possa dire che questa coscienza non sussiste ovvero in che senso possiamo dire che essa non sussiste. Infatti, se da un lato è vero che si parla della malattia come di una cosa, e quindi indubbiamente al di fuori di un contesto innocuo come quello delle immagini del discorso corrente (come quando diciamo che «un tarlo ci rode»), non sembra invece affatto vero che proprio nulla subentri alla coscienza dell’immagine e che in qualche modo ne faccia le veci. Infatti, se l’indistinzione tra simbolizzante e simbolizzato fosse realmente da prendere alla lettera, allora sarebbe logico attendersi che la cura non possa consistere in altro che nel ricercare questa pietra nel corpo del malato tentando di estrarla - proprio come accade nel quadro di Bosch nel quale un medicastro si accinge a trapanare il cranio di un poveraccio per estrarne la pietra della follia. Se si tratta di una credenza effettiva, cioè di una opinione autentica intorno alla malattia, vi sarà anche una tecnica adeguata a quella opinione.
Invece normalmente non accade così. All’«opinione» della malattia come corpo estraneo non corrisponde alcuna tecnica conseguente di estrazione, ma una speciale cerimonia dalla quale ci si attende che il corpo estraneo venga cacciato fuori - e cioè semplicemente che l’ammalato guarisca... Qualche cosa di simile ad una sostanzializzazione è certamente avvenuta, ma non possiamo affatto passare sotto silenzio il fatto che nessuno si attende poi di vedere rotolare via il sasso sul terreno della capanna o di poterlo far passare di mano in mano dicendo: «Si trattava di questo».
Come stanno allora le cose quanto al problema della credenza? Fede e malafede si sostengono l’una con l’altra. Il tratto fondamentale dell’esperienza mitico-magica e, forse, dell’esperienza religiosa in generale, è una sorta di intrinseca doppiezza: |200|
«Egli sa bene che il fulmine viene dalle nuvole - scrive un osservatore a proposito di un africano a cui il fulmine ha distrutto la casa - e che le nuvole sono inaccessibili alla mano dell’uomo. Ma qualcuno gli ha detto che quel fulmine gli era stato mandato da un vicino che gli vuole male, lui lo ha creduto, lo crede ancora, lo crederà sempre»[96].
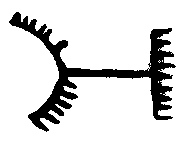 19. La reificazione delle immagini come reificazione incompleta
19. La reificazione delle immagini come reificazione incompleta
Alla base dei comportamenti e delle credenze mitiche vi sono immagini. Ma questo carattere immaginativo sfugge alla coscienza mitica. Ciò significa che l’immagine viene ridotta a cosa, viene sottoposta in vari modi a un processo di reificazione.Fin qui giunge la tesi del simbolismo implicito. Ma non appena attiriamo l’attenzione sul fatto che l’esperienza mitica non può essere una esperienza globalizzante, costitutiva di un mondo in sé compiuto, non appena cioè effettuiamo il riconoscimento che una concezione empirica del mondo deve essere comunque presupposta, allora ci rendiamo conto che resta ancora un aspetto del problema che deve essere messo in rilievo. Infatti la reificazione delle immagini non giunge fino al punto di integrare le formazioni mitiche nella realtà stessa e la credenza non arriva a essere una credenza autenticamente posizionale. Che le cose non stiano così è indicato dal fatto che ogni azione, oggetto o pratica mitico-magica viene segregata da tutto il resto, coesistendo con i decorsi degli eventi e delle azioni quotidiane nella forma di una rigida frattura. In altri termini, non appena ci sembra che la neutralizzazione sia stata soppressa, e dunque che l’immagine abbia perduto il carattere di immagine, ci troviamo di fronte a procedure segreganti che richiamano il tema dell’eterogeneità. E come se la coscienza mitica si realizzasse in un doppio processo: in primo luogo essa mette in opera una vera e propria degradazione dell’immagine; ma le cose in cui le immagini si sono degradate vengono subito poste da parte, delimitate e circoscritte rispetto al mondo empiricamente costituito, effettuando in questo modo una sorta di ripristino della loro valenza immaginativa.
La nostra tesi è dunque che la reificazione delle immagini che caratterizza l’esperienza mitica è una reificazione incompleta.
Proprio nella misura in cui le procedure di segregazione possono essere intese come la forma peculiare che assumono le operazioni neutralizzanti nell’ambito dell’immaginazione mitica la tesi dell’inconsapevolezza della distanza simbolica deve essere respinta.
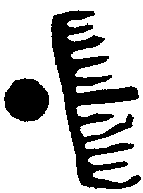 20. Sacro e profano
20. Sacro e profano
Alcune osservazioni sull’opposizione tra sacro e profano potranno forse servirci per compiere una prima verifica di questo spunto iniziale che ha certamente bisogno di essere messo alla prova, per accertare se esso sia in grado di offrirci un punto di vista realmente significativo al fine di una nuova impostazione del nostro problema.
Questa opposizione si trova formulata a titolo di antitesi fondamentale in apertura della seconda parte del volume della Filosofia delle forme simboliche dedicato al mito, ed essa assolve del resto un ruolo determinante all’interno della letteratura sull’argomento.
Ciò che attira il nostro interesse su questa opposizione è naturalmente il modo stesso in cui abbiamo sviluppato fin qui il nostro discorso, un modo che poneva l’accento su una duplicità di principio inerente alla natura del problema. Tuttavia dobbiamo subito sottolineare che l’intera questione viene resa confusa già dalla terminologia impiegata. Infatti non si dovrebbero mettere l’uno di fronte all’altro il sacro e il profano, ma piuttosto il sacro e il quotidiano, la realtà sacra e la realtà comune. Che il profano sia per così dire una faccenda interna al sacro e che del resto ne presupponga la nozione sembra del tutto evidente - basti pensare all’impiego del verbo «profanare» - per quanto, stranamente, né in Cassirer né in altri autori venga attratta l’attenzione in modo particolare su questo punto.
Mircea Eliade - un autore che merita di essere ricordato anche in rapporto a Cassirer e che può essere considerato fra i più notevoli e interessanti rappresentanti della «fenomenologia della religione» - nel volume Il sacro e il profano parla del sacro come di ciò che si oppone al profano[97];mentre sembra appunto evidente che si debba dire l’esatto inverso e, beninteso, una simile inversione incide sul contenuto della questione.
Di norma questo equivoco è reso possibile dal fatto che si considerano il profano e il quotidiano come nozioni di senso perfettamente equivalente, mentre una simile equivalenza non ha alcuna ragione di sussistere e la sua assunzione, implicita o esplicita che sia, è destinata a incidere in profondità sulla trattazione del problema. Infatti, mentre il profano presuppone il sacro, la quotidianità è in se stessa libera da questo rimando, e anche disponendosi dal punto di vista del sacro non avrebbe certamente senso caratterizzare tutto il resto - un qualunque oggetto del mondo circostante di ogni giorno, ogni azione o comportamento comune - come profano.
In che modo questa annotazione terminologica abbia un preciso rilievo concettuale è mostrato dal fatto che il porre al centro la coppia sacro-quotidiano tende a porre il problema in una forma diversa da quella di una pura e semplice antitesi. L’antitesi sussiste solo tra il sacro e il profano, mentre tra il sacro e il quotidiano sussiste un rapporto di totale alterità. È un fatto certamente significativo per le valenze critiche in esso implicite che anche noi ci possiamo associare alla nota designazione del sacro come Ganz Anderes, già presente in Rudolf Otto, e poi ripresa ovunque nell’ambito della fenomenologia della religione. Solo che per noi la trasposizione in una regione totalmente altra non solo rappresenta il punto nodale che connette il mito all’immaginazione, ma assume il senso di un’operazione che conduce a una vera e propria costituzione delle oggettività sacre. Siamo dunque molto lontani dall’atteggiamento consueto del fenomenologo della religione che si accinge ad una pura e semplice descrizione del sacro come di una pretesa oggettualità di riferimento di una esperienza mitico-religiosa caratterizzata da una direzione intenzionale univoca.
Si tratta invece di prestare attenzione alle procedure di reificazione e di alterificazione che conducono all’investimento sacrale di oggetti e di eventi. Tutte le descrizioni che in vari modi ripresentano la tematica dell’eterogeneità all’interno delle forme di manifestazione del mito assumono allora una portata ed un significato interamente diversi.
Si consideri per esempio la circostanza più volte sottolineata e richiamata anche da Cassirer [98], secondo cui il sacro è spesso connesso con ciò che è eccezionale, che è nuovo e straordinario. Si dovrebbe commentare, a questo proposito, che già questo attesta come uno stabile senso della realtà debba in qualche modo essere dato come presupposto: l’eccezionalità, l’essere fuori dalla norma presuppone la norma. La realtà ha le sue consuetudini ed esse ci sono perfettamente note. Ma potremmo anche spingerci oltre. La sacralizzazione dell’evento straordinario potrebbe talvolta essere addirittura intesa come una reazione ai suoi potenziali effetti disaggreganti. Ciò che è anomalo minaccia la norma e da questa minaccia ci si può difendere respingendo l’anomalia nella regione di eterogeneità che è il sacro stesso. La sacralizzazione può presentarsi così talvolta come funzione del senso di realtà.
Che dire allora di una posizione come quella cassireriana che propone l’esperienza mitica come anteriore alla distinzione tra reale e irreale, tra il sonno e la veglia, tra il morto e il vivo?
Eppure si potrebbe pretendere che tutto ciò sia ben documentato: gli uomini bianchi vennero spesso considerati, secondo quanto riferisce Lévy-Bruhl, come morti vaganti nella foresta[99]. Ma è indubbio che anche in racconti come questi vi sono importanti sottintesi: incontrare un morto in giro per la foresta non è appunto cosa di ogni giorno e questa possibilità non può certamente essere integrata facilmente nella realtà senza scompaginarla. Il luogo dell’incontro sarà dunque presumibilmente sacralizzato, contrastando così una simile confusione di piani.
Quanto al modo della sacralizzazione, esso può essere ripreso direttamente dalle descrizioni fenomenologiche relative al sacro, nelle quali il tema della segregazione si ripresenta di continuo. Il primo atto, l’atto che costituisce il luogo come luogo sacro è la costruzione di un recinto, anche soltanto l’atto di tracciare una linea sul terreno. Al di là di questa linea vi è il radicale altrove. In esso non si accede di passo in passo per transizioni successive, ma di salto - come negli spazi dell’immaginazione in genere, nello spazio del gioco o dell’azione teatrale.
E naturalmente ogni prescrizione rituale deve essere intesa come l’istituzione di un recinto. Se dovessimo dire, per esempio, che cosa caratterizza una narrazione mitico-religiosa rispetto a un semplice racconto, non ci richiameremmo affatto alle peculiarità del suo contenuto o a uno speciale modo di «percepirlo», ma faremmo piuttosto riferimento alle pratiche rituali prescritte per la sua comunicazione.
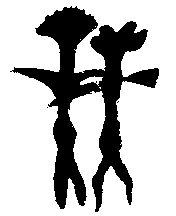 21. L’uniformità indifferente del quotidiano e la pretesa funzione ordinatrice del sacro
21. L’uniformità indifferente del quotidiano e la pretesa funzione ordinatrice del sacro
Consideriamo ora in che modo lo stesso problema dell’opposizione tra sacro e profano si presenta all’interno della tematica di Cassirer.
Come abbiamo osservato, anche in Cassirer la coppia dei termini viene assunta come tale e il tema della quotidianità viene per così dire interpolato sotto il titolo del profano. Ma Cassirer non si limita a questo: in realtà compie una operazione molto più sofisticata che è in certo senso resa necessaria dalla sua impostazione complessiva e che orienta subito la discussione secondo una direzione interamente diversa. Evidentemente, data la natura dei presupposti filosofici da cui egli prende le mosse ciò che va tenuto fermo è il carattere primario dell’esperienza mitica, e dunque nulla può essere più estraneo alla prospettiva cassireriana - almeno nella forma che essa assume nella Filosofia delle forme simboliche - quanto l’assumere la quotidianità come un mondo già in se stesso strutturato. Perciò questa stessa nozione deve essere sottoposta a una sorta di manipolazione filosofica in modo da renderla quanto più prossima è possibile al materiale indifferenziato dell’esperienza che attende di essere messo in forma.
In effetti, quando Cassirer parla del «profano», intendendo con ciò anzitutto il «piano dell’esperienza di tutti i giorni»[100], come di una «serie dei soliti fatti della comune esistenza empirica»[101], non fa altro che proiettare su questo piano l’immagine della dispersione che precede quella strutturazione che solo l’esperienza del sacro è in grado di apportare. Ciò che viene messo in evidenza è l’uniformità dell’esistenza quotidiana, la perfetta indifferenza di livello dei piccoli fatti che accadono in essa - dunque nello stesso tempo, l’assenza di un senso e di una direzione. Si avverte qui qualcosa di simile a una lacuna argomentativa, o meglio ad un passaggio che non sembra avere alcuna giustificazione teoretica interna. Una giustificazione comunque c’è, ed essa sta precisamente nello scopo che Cassirer persegue. Ponendo le cose in questo modo, infatti, il sacro verrà senz’altro assimilato alle forme kantiane: esso cioè verrà in questione essenzialmente come un modo primario di dare ordine al modo.
Di conseguenza l’alterità del sacro assume un senso completamente diverso. Anche qui si dice, per esempio, che l’idea di mana «contrappone al piano dell’esistenza di tutti i giorni e di ciò che avviene nelle maniere usuali un altro piano nettamente distinto»[102]. Ma questa differenza è intesa anzitutto come rottura, indotta dal sacro, del continuo omogeneo e insensato, del profano quotidiano: il problema della differenza si prospetta in primo luogo come inserimento di una discontinuità ordinatrice. Tutta la trattazione dello spazio e del tempo mitico, a cui introduce il tema dell’antitesi tra sacro e profano come antitesi fondamentale, nonostante la grande varietà degli aspetti considerati che la rende così ricca di interesse, è dominata da una simile prospettiva che subordina i temi della segregazione a quelli dell’organizzazione.
Ora, non si tratta certo di negare il sussistere di un aspetto tanto notevole che appartiene indubbiamente alla tematica di una fenomenologia dell’esperienza mitico-religiosa. Ma il riconoscimento di questo aspetto e della sua portata - e quindi anche il riconoscimento dell’interesse intrinseco che riveste l’indagine cassireriana - non implica affatto che si debbano assumere le implicazioni filosofiche che sono a esso sottese e che si prestano peraltro ad impieghi nettamente ideologici.
Per quanto da Cassirer possa essere lontano l’intento di approdare a una pura e semplice apologetica indiretta della religione in genere, tuttavia non vi è dubbio che il modo in cui questa tematica viene messa in gioco si presta ampiamente a essere utilizzata in questa direzione.
Ciò appare chiarissimo nel volume di Eliade che abbiamo rammentato in precedenza per altri motivi. Nonostante il fatto che nella stessa terminologia si facciano sentire alcuni echi della filosofia esistenzialista, vi è una profonda affinità con la posizione di Cassirer proprio per ciò che concerne il modo di intendere l’«antitesi fondamentale». Attraverso il sacro si opera una rottura di livelli [103]; il sacro implica una scissione, una frattura: esso si manifesta come una irruzione[104]. E tutto ciò accade in funzione del problema dell’ordine e nello stesso tempo del problema del senso. Perciò Eliade parla spesso del sacro in quanto realizza una vera e propria fondazione del mondo.La frattura organizza il mondo. La sacralizzazione deve essere considerata anzitutto come un processo di cosmizzazione. «La manifestazione del sacro fonda ontologicamente il mondo. Nella distesa omogenea e infinita senza punti di riferimento né impossibilità alcuna di orientamento, la ierofania rivela un "punto fisso" assoluto, un "centro"»[105].
Ma se la sacralizzazione assolve questo compito, allora la desacralizzazione, cioè la demitizzazione dell’esperienza del mondo sembra dover essere niente altro che una regressione nell’amorfo, una regressione dal senso al non senso. Ed è naturalmente questa la conclusione che trae Eliade. Di qui gli antichi e rinnovati lamenti sulla «modernità», sul disorientamento esistenziale che sarebbe componente essenziale necessaria della «gigantesca trasformazione del mondo prodotta dalle società industriali e resa possibile dalla desacralizzazione del Cosmo per effetto del pensiero scientifico»[106].
In positivo andrà allora proposta una sorta di nuova progressione verso il sacro, in modo da riattivare il potenziale di esperienza mitica sempre latente in noi, andrà messo in opera un processo di rimitizzazione che ostacoli la demitizzazione in corso.
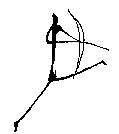 22. Riconsiderazione della posizione di Lévy-Bruhl
22. Riconsiderazione della posizione di Lévy-Bruhl
Sempre allo scopo di mettere alla prova il punto di vista che abbiamo adottato, per mostrare in che modo a partire da esso possa essere articolata una discussione sui materiali precedentemente esposti, può essere interessante riprendere nuovamente in esame la posizione di Lévy-Bruhl a cui abbiamo rapidamente accennato come una estensione del nostro commento alla posizione cassireriana. Ora che abbiamo messo in questione quest’ultima nel principale dei suoi capisaldi, tendiamo a rileggere le stesse pagine che abbiamo prese in considerazione a suo tempo, dando il massimo rilievo ad aspetti del problema sui quali in precedenza, tutti presi nel cercare conferme alla tesi del simbolismo implicito, avevamo sorvolato. E ci rendiamo subito conto che la nostra esposizione era stata certamente troppo unilaterale - e ciò non soltanto per via della sua brevità.
Riconsideriamo per esempio la questione dell’indistinzione tra sogno e veglia: in rapporto al sogno Lévy-Bruhl afferma certamente che «il sogno porta ai primitivi dei dati che, ai loro occhi, valgono altrettanto, se non più, che le percezioni acquisite durante la veglia»[107]; ma afferma anche, in maniera inequivocabile, che nell’attribuire questo valore al sogno i primitivi «non sono nemmeno vittime di una grossolana illusione psicologica. Sanno benissimo distinguere il sogno dalle percezioni della veglia, e sanno benissimo di sognare quando dormono»[108]. Non solo: essi distinguono tra sogno e sogno e operano questa distinzione facendo riferimento alla differenza tra vero e falso: essi «non danno credito a tutti i sogni indistintamente. Certi sogni sono veridici e altri no». Così accade talvolta che si dia un nome speciale ai sogni veridici, considerando tutti gli altri come frutto di pura immaginazione. «Presso gli indiani della Nuova Francia quelli che hanno il dono di sognare non accettano tutti i loro sogni indifferentemente; ne riconoscono di falsi e di veri e questi - dicono - sono assai rari»[109].
C’è dunque la veglia; e il sonno con i suoi sogni; e ci sono i grandi sogni, che accadono solo a persone che ne hanno il dono, e i piccoli sogni di tutti che non hanno nessuna importanza.
Ed è naturale che sia così - è naturale dal punto di vista che abbiamo adottato. Mentre da un punto di vista che nega la doppiezza e la consapevolezza di essa, circostanze come queste dovrebbero essere passate sotto silenzio. È naturale persino che a certi sogni venga attribuita una veridicità, in un senso che sarebbe peraltro tutto da chiarire. Se infatti è vero che il sogno si presenta, alla sua superficie, come una serie di eventi non localizzabili nel contesto della realtà, una circostanza che denuncerebbe la sua origine immaginativa, è anche vero che almeno per certi aspetti il sogno ha la forma dell’accadere autentico. Se un morto mi appare mentre dormo e io ne odo distintamente la voce, come posso sapere che si tratta soltanto di una illusoria creazione dell’immaginazione? Di fatto il sogno ci mette di fronte all’enigma di eventi irriducibili alla realtà perché sfuggono alle sue regole, e che sono nello stesso tempo provvisti di alcuni caratteri che sono propri degli eventi reali. Una soluzione di questo enigma sta proprio nel raddoppiamento della realtà stessa, un raddoppiamento che non solo non ha nulla a che vedere con l’indistinzione tra sogno e veglia, ma che anzi presuppone che tra l’uno e l’altra sia stata effettuata una chiara distinzione.
Ciò mette in questione, naturalmente, anche il tema della simbiosi tra «mondo visibile» e «mondo invisibile». Secondo Lévy-Bruhl, il primitivo vive direttamente questa unità e siamo noi a introdurre questa differenza, essenzialmente per dire che essa è ignorata dal selvaggio. Mentre essa deve essere considerata come posta all’interno della stessa esperienza mitico-religiosa nella forma di una sovrapposizione, in apparenza contraddittoria, secondo i modi che abbiamo illustrato in precedenza.
Da questo punto di vista dovrebbe essere ripresa la discussione intorno al problema causale così vivacemente proposto da Lévy-Bruhl e ripreso da Cassirer che lo inserisce in un contesto filosofico più ampio e particolarmente elaborato. |231|
Come in rapporto alla posizione di Cassirer, così anche in rapporto a quella espressa da Lévy-Bruhl si può obiettare che essa non può essere presa alla lettera. Una filosofia della mitologia non può affatto ignorare che vi è una forma primaria di unità costitutiva della nozione di mondo e che ad essa appartiene l’idea di una concatenazione causale degli eventi. Per usare una espressione di Husserl: il mondo ha uno stile causale.Questa frase va rammentata qui perché Husserl la enuncia proprio in rapporto al mondo della vita, cioè al mondo come si dà all’interno dell’esistenza stessa, al mondo che antecede le elaborazioni concettuali ed intellettuali della scienza.
Sarebbe tuttavia ingiusto ritenere che Lévy-Bruhl non scorga le difficoltà insorgenti dalla negazione di questo presupposto. L’unilateralità della nostra esposizione precedente consiste anche nell’aver taciuto sulle restrizioni con cui Lévy-Bruhl accompagna l’asserita indifferenza alla causalità naturale da parte del primitivo: anzi, più che di restrizioni si tratta proprio dell’emergenza di una difficoltà intrinseca che egli enuncia in tutta chiarezza. Nonostante tutto, «i primitivi si servono costantemente della connessione effettiva delle cause e degli effetti». Infatti, comunque ne sia della sua costituzione mentale, non si può non riconoscere che «il primitivo si muove nello spazio esattamente come noi e per lanciare i suoi proiettili o per raggiungere uno scopo lontano sa come noi e a volte meglio di noi valutare rapidamente le distanze, ritrovare una direzione, ecc.». «Nella costruzione degli utensili, per esempio, o in quella delle trappole essi danno spesso prova di una ingegnosità che implica una finissima osservazione di questa connessione»[110].
Ma la difficoltà appena intravista viene ben presto sbrigativamente superata. Possedere un modo di attività, dice Lévy-Bruhl, è tutt’altra cosa che «possedere contemporaneamente l’analisi di questa attività». Da un sapere pragmatico, incorporato nell’azione dobbiamo distinguere un sapere che è il risultato di una riflessione. Ma ciò non basta ancora: un sapere pragmatico è ancora pur sempre un sapere implicito e rimarrebbe allora il paradosso secondo cui la teoria a cui si attiene esplicitamente il primitivo per ciò che concerne la nozione di realtà in generale sarebbe l’esatto opposto della teoria implicata in quelle pratiche. Cosicché Lévy-Bruhl propone la scissione in modo più radicale, negando alle tecniche esercitate dal primitivo ogni carattere di un sapere implicito: esse sorgono invece dall’istinto. Si costruiscono capanne così come si cammina: e anche gli animali lo fanno. «Dal punto di vista dell’azione essi si spostano nello spazio come noi (e come gli animali), raggiungono i loro scopi per mezzo degli strumenti il cui uso implica la connessione effettiva delle cause e degli effetti; e se non si conformassero a questa connessione, ancora come noi (e come gli animali) perirebbero subito»[111].
Di una simile soluzione non possiamo certo ritenerci soddisfatti. Il paradosso che essa doveva sciogliere è diventato soltanto più clamoroso. Infatti, ponendoci in questa prospettiva, tutto ciò che sembra richiedere un ampio complesso di cognizioni autentiche sul mondo circostante, tutto ciò che presuppone un assennato progetto di appropriazione dell’ambiente, una cosciente posizione di scopi e la ricerca di mezzi a essi adeguati, tutto questo dovrà essere livellato ad un atto puramente motorio, a quella componente istintiva che abbiamo in comune con gli animali. L’homo faber non è altro che un castoro. Ciò che è propriamente umano nell’uomo lo ricercheremo invece nella sua «cultura», in un’accezione tanto riduttiva del termine da comprendere esclusivamente l’ambito delle credenze religiose e dei comportamenti rituali in genere: per quanto forsennati ci possano apparire.
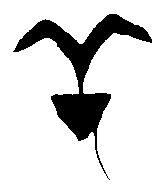 23. Digressione bergsoniana
23. Digressione bergsoniana
Quando dunque Bergson, in Le due fonti della morale e della religione, avvia la propria critica a Lévy-Bruhl rilevando che vi è una cognizione causale immanente nelle pratiche quotidiane, tocca una difficoltà che anche Lévy-Bruhl aveva scorto e risolto a suo modo[112]. Tuttavia Bergson non è interessato in modo particolare a mettere in rilievo il fatto che anche Lévy-Bruhl si rende conto della difficoltà ed a discutere il modo in cui egli pensa di venirne a capo. Bergson è invece colpito da un unico punto che assume il carattere di un punto nodale. Quando Lévy-Bruhl insiste sull’indifferenza rispetto alle cause naturali, portando a riprova numerose testimonianze e documentazioni, «un primo punto è notevole: che in tutti i casi riportati, l’effetto di cui si parla e che è attribuito dal primitivo a una causa occulta è un avvenimento che concerne l’uomo o più particolarmente un avvenimento accaduto a un uomo o più particolarmente ancora, la morte, e la malattia di un uomo. Non si tratta mai dell’azione dell’inanimato sull’inanimato (tranne nel caso di un fenomeno meteorologico nel quale l’uomo ha, per così dire, degli interessi). Non si dice che il primitivo vedendo il vento che curva un albero, il flutto che trascina dei sassolini, il proprio stesso piede che solleva la polvere, faccia intervenire qualche cosa di diverso da ciò che noi chiamiamo causalità meccanica»[113].
Ma se le cose stanno così, allora non possiamo contentarci di rilevare che in taluni casi interviene il rimando a una «forza mistica», ma dobbiamo invece cercare di andare più a fondo nel problema, chiedendoci quale sia il tipo di operazione che viene effettivamente compiuta. Poiché dobbiamo senz’altro riconoscere che, quando il primitivo vede che un uomo è stato ucciso da un frammento di roccia, coglie la connessione causale esattamente come la cogliamo noi, dobbiamo chiederci perché mai introduce una causa soprannaturale. E se osserviamo le cose da vicino, ci rendiamo conto che «ciò che il primitivo spiega in tal caso con una causa soprannaturale non è l’effetto fisico, ma il suo significato umano, la sua importanza per l’uomo, e più particolarmente per un certo uomo determinato, quello ucciso dalla pietra. Non vi è nulla di illogico, né di conseguenza di prelogico... nella credenza che una causa debba essere proporzionata al suo effetto e che, una volta constatate l’incrinatura della roccia, la direzione e la violenza del vento.., resti da spiegare questo fatto di importanza capitale per noi, la morte di un uomo»[114].
Emerge così un motivo che deve essere indubbiamente ripreso, indipendentemente dal contesto filosofico nel quale esso si trova inserito. La nostra attenzione viene qui richiamata sul fatto che ci si rifiuta, con un simile comportamento, di ammettere l’equivalenza tra due serie causali una delle quali sfocia in un fatto che ha una rilevanza umana. La richiesta di qualcosa di simile ad una spiegazione supplementare è una diretta conseguenza di questa operazione di discriminazione.
Ora, la prima domanda che ci si deve proporre è se, così facendo, il primitivo si trovi già sotto la presa del pensiero mitico-magico che lo orienta senz’altro in questa direzione, oppure se non si tratti piuttosto di un problema indipendente rispetto alla soluzione mitico-magica proposta nei casi particolari, che peraltro, secondo la nostra concezione, non potrà in ogni caso essere intesa come una soluzione autentica nemmeno per la coscienza mitica.
Noi propendiamo a confermare il secondo polo di questa alternativa. Ciò non dipende affatto dall’intenzione di prendere partito per una direzione tendenzialmente «spiritualistica» piuttosto che tendenzialmente «materialistica». La questione non verte infatti sulle nostre convinzioni filosofiche o su quelle dei primitivi: non si tratta di prendere decisioni sulla natura in sé degli eventi, ma sulla nostra esperienza di essi; e per quanto le nostre convinzioni possano pesare su questa esperienza, non riusciremo probabilmente a ricondurle integralmente sul piano stesso del vissuto, che è il piano su cui quella discriminazione viene operata.
Basterà riflettere, a questo proposito, sul fatto che il problema di una doppia interpretazione, si ripresenta come un problema fondamentale della costituzione intersoggettiva. I movimenti dell’altro, per esempio, sono anch’essi eventi di questo mondo che possono essere considerati come strettamente inseriti in una concatenazione meccanico-causale. Nell’apprensione dell’altro, tuttavia, questo modo di considerazione non può essere originario: anche se parliamo, nel discorso corrente di cause, intendiamo di norma qualcosa di profondamente diverso dalle cause meccaniche, intendiamo piuttosto le motivazioni, le intenzioni che orientano l’agire. Alla pura e semplice percezione del movimento si sovrappone e diventa dominante l’apprensione di una gestualità che rimanda a una ininterrotta produzione di senso.
Nel contesto di una fenomenologia dell’intersoggettività, la morte si presenta, nell’esperienza stessa, come un problema: come se le forme originarie della costituzione dell’altro si prolungassero anche su questo evento, investendo l’esperienza che noi abbiamo di esso. Quando muore un uomo, ciò che viene percepito è anzitutto il chiudersi di un universo irriducibile e irripetibile di significati, i significati che emanano dalle sue azioni e dai loro prodotti, ma forse in primo luogo, e più semplicemente, i significati che vengono direttamente colti nel suono della voce, nelle minime variazioni espressive del volto.
Ciò che resta, dopo la morte di un uomo, è l’infinita nostalgia di una gestualità definitivamente perduta.
E proprio questa chiusura della produzione del senso che resta un problema: le causalità meccaniche che nel processo di costituzione dell’altro stanno sullo sfondo come totalmente irrilevanti, sembrano qui operare un livellamento intollerabile. Di qui l’istanza di confermare la differenza dei piani, di riportare l’evento sul piano degli eventi-valori, integrando anche la morte nel fiume della produzione soggettiva del senso.
Tutto ciò ci consente di scorgere un nuovo aspetto, di fondamentale importanza e fin qui non ancora considerato, del problema della relazione del mito all’immaginazione. In effetti, il mito dà a quella istanza una risposta immaginativa. Sappiamo già che questo carattere immaginativo non si sottrae affatto alla stessa esperienza vissuta. Ora dobbiamo aggiungere che l’immaginazione interviene qui non soltanto come facoltà dell’eterogeneo, ma anche secondo l’altra funzione essenziale che deve esserle attribuita: la funzione di valorizzazione. Infatti, la via che conduce da un determinato contenuto all’immagine è una via nel cui corso il contenuto, entrando nei dinamismi relazionali dell’associazione delle idee, attenua sempre più le proprie connotazioni che lo vincolano al contesto dei fatti per accedere al contesto dei valori. Questa funzione valorizzante dell’immaginazione - che è una sua funzione originaria connessa allo stesso concetto delle sintesi immaginative - entra qui in opera su contenuti che hanno già un indice di valore.Ciò significa che l’elaborazione immaginativa dell’evento non tende a dare una giustificazione per così dire metafisico-sostanziale dell’evento stesso, quanto piuttosto a confermare, a rafforzare, ad ampliare il suo carattere di evento-valore.
Solo a questo punto, quando cioè si sia effettuata la connessione della nostra tematica precedente con il problema del valore, si può realmente parlare di immaginazione mitica, e più in generale di immaginazione sacra.Di qui le operazioni immaginative traggono tutta la loro serietà, riproponendo una forma di connessione profonda con la vita stessa.
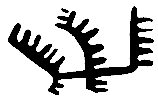 24. La profondità dell’immaginazione
24. La profondità dell’immaginazione
Il parlare della sacralizzazione come di un processo di reificazione incompleta, di un doppio processo che consta di operazioni che concretizzano le immagini e di operazioni, di segno opposto, di segregazione rituale, dunque non basta. Dobbiamo anche parlare della profondità dell’immaginazione mitica, di quella profondità che appartiene all’aura immaginativa secondo cui appaiono le produzioni del mito e che istituisce un raccordo con il problema del valore.
Tuttavia introdurre ed illustrare questo problema sulla base di un esempio così estremo come quello della morte può essere per molti versi fuorviante. Il movimento che dà origine al sacro non ha infatti il suo inizio soltanto nelle questioni ultime della esistenza, ma anche nello stesso ambito del suo decorrere quotidiano. La posizione di valori si effettua di continuo proprio in questo decorso ed in essa è da subito implicata la soggettività pratico-attiva in quanto è orientata verso il proprio mondo circostante secondo gli scopi della produzione e della riproduzione della sua stessa esistenza. Per questo, quando qui si parla di valore, sarebbe opportuno pensare anzitutto alla nozione generale di valore d’uso. La valorizzazione è anzitutto una valorizzazione pratica che certamente non mette ancora in causa, in se stessa, le funzioni immaginative. Nell’ambito della quotidianità viene operata una precisa differenziazione tra le cose del mondo circostante, tra gli eventi della vita di ogni giorno. Ciò che ha appunto un «significato umano», proprio perché è attinente ai bisogni e ai desideri umani e alle pratiche che tendono a soddisfarli, viene distinto, raccolto e messo accuratamente da parte. Tutto ciò ha certamente a che vedere anzitutto con l’utilità. Eppure saremmo disposti a sostenere che qualunque azione di chiusura, di custodia dell’oggetto in quanto tale, può arricchire l’oggetto di una densità immaginativa autonoma, può determinare, insieme ad altre circostanze, l’inizio di un percorso che conduce alle soglie del sacro immaginario. Il legame con l’utilità comincia ad allentarsi e quindi anche si allentano le posizioni d’essere ancora implicite nella valorizzazione direttamente pratica. Nella custodia dell’oggetto d’uso - nella custodia del fuoco, nella sua alimentazione perenne - esso comincia a entrare nel gioco delle sintesi immaginative che attraverso una catena di rimandi e di connessioni nuove lo ripropongono in una totale trasfigurazione. Alla valorizzazione pratica subentra la valorizzazione immaginativa che approfondisce le differenze ed opera, secondo le regole sue proprie, un’amplificazione e un’intensificazione di valore.
Seguendo una simile linea di discorso, da un lato saremmo tenuti a inserire all’interno della fenomenologia dell’atteggiamento mitico il problema delle condizioni e delle forme della vita entro cui quell’atteggiamento ha origine e si sviluppa in modi diversi e diversamente determinati; dall’altro, assumerebbe particolare rilievo il fatto che l’immaginazione sacra non investe soltanto oggetti o eventi che sono inquietanti o insoliti, portentosi o semplicemente fuori dell’ordinario ma anche, e altrettanto spesso, essa si dirige su oggetti quotidiani e familiari - sulle cose che ci stanno intorno e che ci danno sicurezza, tutto ciò che sta vicino a casa.
Sono questi gli spunti problematici contenuti nel tema della profondità dell’immaginazione. L’immaginazione sacra opera su eventi già valorizzati, amplificando e spostando il loro accento di valore: l’evento che emergeva già all’interno della quotidianità viene immaginativamente trasfigurato entrando nel racconto mitico, nella cerimonia, nel rito, esprimendo tutte le proprie potenzialità immaginative. In questa trasfigurazione resta tuttavia il legame interno con l’origine, e anzi proprio da questo legame esso riceve tutta la sua intensità. Nella cerimonia della primavera, la primavera non è soltanto liberamente fantasticata attraverso immagini di ogni genere giocate interamente al di fuori delle connessioni reali: la primavera del rito non è semplicemente la rappresentazione della primavera, ma è la primavera profonda, la profondità della primavera.
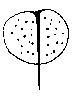 25. Riconsiderazione della posizione di Frazer alla luce delle osservazioni di Wittgenstein
25. Riconsiderazione della posizione di Frazer alla luce delle osservazioni di Wittgenstein
Le nostre riflessioni possono avviarsi a un riepilogo ed a una conclusione considerando il breve testo steso da Wittgenstein come appunti di lettura al Ramo d’oro di Frazer. Essi si prestano indubbiamente a questo scopo dal momento che vanno molto oltre - nonostante la loro brevità - le contingenze di una critica nei confronti di questo autore: le osservazioni di Wittgenstein infatti, non solo non sono prive di rilevanza nei confronti della posizione di Cassirer, ma presentano spunti di impostazione del dibattito teorico che possono essere considerati in coerenza con l’angolatura che abbiamo proposta, anche se essa è stata da parte nostra diversamente elaborata.
La direzione della critica peraltro non ci è nuova. Essa si rivolge al punto centrale della posizione di Frazer: l’esibizione dei costumi e delle usanze è costantemente accompagnata dal rilievo della loro erroneità; e tutta la teoria della magia si sviluppa a partire dal problema dell’errore. Per questo l’esposizione è attraversata da una polemica «positivistico-illuministica» contro la superstizione che non esita a ironizzare e a ridicolizzare i comportamenti selvaggi.
E contro di ciò, Wittgenstein: «Vorremmo dire: è accaduto questo e quest’altro: ridi se puoi»[115].
Frazer lo può, e proprio perché fin dall’inizio è installato in una certezza che deve essere messa in questione. Non a caso le osservazioni di Wittgenstein si aprono con l’invito filosofico a immergersi «sempre di nuovo nelle acque del dubbio», a mettere in questione l’apparente saldezza dei principi sui quali siamo attestati - ed a maggior ragione in presenza di una documentazione di modi e di forme della vita che tanto ci sconcerta.
Gli studi antropologici ci mettono di fronte all’inattesa varietà delle risposte umane ai problemi dell’esistenza e questa varietà deve rappresentare uno stimolo costante per la riflessione filosofica, non solo come dato di fatto, ma nella sua stessa possibilità. La filosofia dovrebbe imparare ad agitare i propri problemi attraverso l’esercizio di una sorta di antropologia immaginaria, di un metodo di «invenzione antropologica» che consiste «nell’immaginare una tribù nella quale ci si comporta in questo modo...» [116]traendo di qui sviluppi problematici ed argomentativi.
Degli atteggiamenti selvaggi dovremmo dunque anzitutto limitarci a prendere atto. Il ridicolizzare, invece, non solo tradisce l’assenza del dubbio, ma anche implica ciò che sempre si accompagna a essa: l’arroccamento su pregiudizi che alla fine potrebbero rivelarsi meschini.
 Il tono di Wittgenstein è qui particolarmente aspro: le spiegazioni di Frazer dei costumi dei primitivi «sono molto più rozze dello stesso significato di quegli usi» e un primitivo sarebbe probabilmente più capace di comprendere un evento qualunque della vita spirituale di quanto lo sia «un inglese del XX secolo». Sino all’efficacissimo e spiritoso sarcasmo: «Frazer sarebbe capace di credere che un selvaggio muoia per errore»[117]. Le parti si invertono con un effetto parodistico: Frazer presenta le usanze dei selvaggi in modo che alla fine essi non possono che apparire infinitamente stupidi - in questo modo rende certamente plausibili quelle usanze «a gente che la pensa in modo simile al suo»; ma nello stesso tempo attribuisce in una buona fede così perfetta una tale dose di ingenuità credulona al selvaggio da fare egli stesso la figura del credulone; e il selvaggio potrebbe certamente farsi beffe di lui.
Il tono di Wittgenstein è qui particolarmente aspro: le spiegazioni di Frazer dei costumi dei primitivi «sono molto più rozze dello stesso significato di quegli usi» e un primitivo sarebbe probabilmente più capace di comprendere un evento qualunque della vita spirituale di quanto lo sia «un inglese del XX secolo». Sino all’efficacissimo e spiritoso sarcasmo: «Frazer sarebbe capace di credere che un selvaggio muoia per errore»[117]. Le parti si invertono con un effetto parodistico: Frazer presenta le usanze dei selvaggi in modo che alla fine essi non possono che apparire infinitamente stupidi - in questo modo rende certamente plausibili quelle usanze «a gente che la pensa in modo simile al suo»; ma nello stesso tempo attribuisce in una buona fede così perfetta una tale dose di ingenuità credulona al selvaggio da fare egli stesso la figura del credulone; e il selvaggio potrebbe certamente farsi beffe di lui.
La prima reazione di Wittgenstein di fronte alla lettura di Frazer è dunque questa: «E molto strano che tutte quelle usanze alla fine vengano presentate per così dire come stupidaggini». E non è in linea di principio plausibile che «gli uomini facciano tutto ciò per pura stupidità» [118]. A tutto ciò si ricollega naturalmente il tema delle abilità pratiche, il tema della lotta per la sopravvivenza. Il selvaggio intaglia a regola d’arte le sue frecce; costruisce capanne e canoe, ha conoscenze sufficienti per soddisfare i propri bisogni vitali, per dominare le avversità del mondo circostante. Ciò significa, in particolare, ed è una frase che abbiamo già rammentato, che «le conoscenze della natura, se le esponessero per iscritto, non si distinguerebbero fondamentalmente dalle nostre»[119].
Su questi motivi, che abbiamo già incontrato in precedenza, non è il caso di indugiare: mentre è interessante soffermarsi sul modo in cui, una volta dichiarato non plausibile «che gli uomini facciano tutto ciò per pura stupidità», Wittgenstein cerchi di rispondere al problema di rendere conto dei comportamenti mitico-magici. In che modo può essere realmente superato il punto di vista dell’errore che sembra imporsi persino nel quadro di concezioni come quella di un Cassirer, che ha un fondamento filosofico ed è guidata da intenzioni così diverse da quelle di Frazer?
La posizione di Wittgenstein su questo punto è molto netta e significativa: non ogni volta che ci troviamo di fronte ad un comportamento, quindi ad una usanza, ad un modo di agire, dobbiamo ritenere che esso abbia al proprio fondamento una vera e propria opinione.
Ciò può certamente accadere: io «la penso così» e proprio per questo in certe circostanze mi comporterò in un modo piuttosto che in un altro. Delle opinioni che stanno alla base del mio comportamento posso anche essere del tutto consapevole, so cioè di avere agito in quel modo in coerenza con convinzioni che mi accingerei a difendere se il mio comportamento fosse contestato. Oppure può accadere che le opinioni siano solo implicite, che io non sia chiaramente consapevole di esse e che esse richiedano, per diventare esplicite, una qualche forma di analisi. Nell’uno come nell’altro caso le opinioni potrebbero essere riconosciute come ingiustificate e in linea di principio basterebbe allora «fare notare all’uomo il suo errore per distoglierlo dal suo modo di agire»[120].
Ma il problema è appunto questo: è realmente lecito, di fronte a ogni comportamento, considerarlo come fondato su opinioni implicite che sarebbe nostro compito portare alla luce, come se ogni azione non fosse altro che la logica conseguenza di una teoria? Wittgenstein dà a questa domanda una risposta negativa. Nega ciò che in Frazer era una circostanza del tutto ovvia: le pratiche magiche implicano una teoria, un complesso di opinioni che si espongono alla valutazione del giusto e dello sbagliato, del vero e del falso. Mentre nozioni come queste risultano inapplicabili se viene meno il riferimento alle opinioni. La critica a Frazer diventa così indubbiamente più ricca di contenuto e nello stesso tempo Wittgenstein propone un motivo di fondamentale importanza per orientare le riflessioni di una filosofia del pensiero mitico.
Questo motivo si annuncia fin dall’inizio quando Wittgenstein osserva che l’esposizione di Frazer è insoddisfacente anzitutto perché «fa apparire come errori» le pratiche magiche e religiose degli uomini[121], volendo con ciò non solo affermare la marginalità di questo problema rispetto agli scopi di una comprensione autentica (come accade in Cassirer e in Lévy-Bruhl) ma sviluppare una critica più radicale che è anche una critica nuova: non vi è errore se non vi è alcuna opinione, e la prima circostanza da mettere in rilievo nei comportamenti mitici e religiosi in genere è proprio il fatto che l’opinione non appartiene all’essenza del comportamento, anche se può naturalmente essergli giustapposta. Se un dio viene invocato, nell’invocazione non è contenuta necessariamente la posizione della sua esistenza e tanto meno la dimostrazione argomentativa di essa.
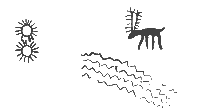 26. Le pratiche magiche dicono i desideri degli uomini
26. Le pratiche magiche dicono i desideri degli uomini
Per illustrare il senso della tesi esposta converrà ricorrere a esempi tratti dai nostri comportamenti quotidiani: facendo riferimento a essi, infatti, quella tesi assume tutta la sua evidenza. Si vede subito qui che non tutti i comportamenti possono essere interpretati come se, agendo, non facessimo altro che trarre conseguenze dalle nostre teorie. Prendiamo il caso della collera: questo stato d’animo si esprime in determinate azioni. Può accadere, stando all’esempio proposto da Wittgenstein, che se abbiamo tra le mani un bastone percuotiamo la terra oppure la scorza di un albero o un qualunque altro oggetto che si trovi nelle vicinanze [122] .
Si tratta di un’azione che chiameremmo «istintiva», e ciò significa in primo luogo che di essa non cercheremmo affatto spiegazioni e soprattutto non le cercheremmo in opinioni soggiacenti. Eppure basta spostare di poco l’accento dell’esempio perché cominci a perdere la sua apparente ovvietà: il comportamento ben noto dei bambini nei confronti dello spigolo del tavolo contro cui hanno urtato - un grande strillo, immediatamente placato dall’atto di punizione - non è molto diverso dal precedente: ma la maggior parte degli adulti saranno probabilmente convinti che un simile comportamento attesterebbe che il bambino crede che gli oggetti siano animati come le persone che gli stanno intorno. A partire dall’osservazione di un comportamento, viene ipotizzata un’opinione che sembra l’unica in grado di spiegarlo.
In questa direzione va intesa l’affermazione di Wittgenstein, indubbiamente piuttosto impegnativa: «Già l’idea di volere spiegare l’usanza mi sembra sbagliata»[123]. È sbagliato porre il problema di una spiegazione, se si tratta poi di andare alla ricerca di opinioni da cui l’azione possa essere conseguentemente dedotta. Se il nostro scopo è quello di comprendere, un primo livello della comprensione è indubbiamente da attingere anzitutto alla superficie dell’azione stessa: «Ciò che conta è la somiglianza con l’atto del punire»[124].
Segnaliamo così dei comportamenti quotidiani in rapporto ai quali la tesi critica iniziale sia illustrabile con evidenza, suggerendo nello stesso tempo che «i miti sono tutti di questa natura»[125]: un’affermazione che non va intesa come se si volesse sostenere che ogni atteggiamento mitico sia riducibile a una pura e semplice reazione emotivo-istintiva, ma che, richiamando l’esempio di una manifestazione espressiva come è la reazione irosa, intende insistere sul fatto che l’intero mondo delle produzioni mitiche risponde ad esigenze essenzialmente espressive.
Questo problema riveste una grande importanza anche nel quadro di un’impostazione come quella di Cassirer, come mostra la trattazione del fenomeno espressivo e della sua connessione con il problema del mito nel terzo volume della Filosofia delle forme simboliche.In esso, a parte ogni considerazione relativa a un mutamento di accento nell’impostazione complessiva del problema, si dà la massima pregnanza alla contrapposizione tra «impressioni» ed «espressioni», indicando nell’espressività già presente nella percezione il tratto dell’esperienza della realtà che sta alla base della esperienza mitica.
Per rendere giustizia al mito, osserva Cassirer, occorre rendere anzitutto giustizia «a quella forma di esperienza percettiva in cui il mito ha la sua radice e da cui trae di continuo nuovo nutrimento. Senza una tale fondazione di una originaria maniera del percepire, il mito sarebbe sospeso nel vuoto invece di essere una universale forma fenomenologica dello spirito sarebbe soltanto una specie di malattia spirituale, un fenomeno che, per quanto diffuso, avrebbe soltanto il valore di un fenomeno contingente e patologico»[126]. Appare tuttavia chiaro, nonostante la ricchezza dei problemi che vengono messi in gioco, che la tematica della immediatezza dell’espressione che si presenta come centrale nella trattazione del fenomeno espressivo, deriva la sua centralità dal fatto che sembra sancire in modo definitivo l’inconsapevolezza del rapporto simbolico nell’atteggiamento mitico. Per Cassirer non si tratta dunque di notare soltanto che il mondo della esperienza mitica è un mondo carico di connotazionì espressivo-emotive, ma soprattutto di rilevare che nel concetto stesso della espressione nella quale la cosa è immediatamente portatrice del suo senso, sarebbe contenuta quella soppressione del rapporto rappresentativo che istituisce il mito come modalità del pensiero. «Il mondo di esperienza del mito - ribadisce Cassirer - è fondato non tanto in atti rappresentativi o simbolici, quanto in pure esperienze espressive»[127]. Non sarebbe dunque possibile mettere in questione la tesi del simbolismo implicito senza mettere in questione questo modo di fondare l’esperienza mitica e dunque di connettere questa esperienza con la tematica dell’espressività in genere.
La posizione delineata da Wittgenstein procede in una direzione opposta. Dal rilievo della connessione tra manifestazioni espressive e produzioni mitico-religiose, si passa infatti alla sottolineatura della rilevanza del momento simbolico come un momento che non è soltanto riconosciuto dalla nostra coscienza analitica, ma che deve in qualche modo far parte della stessa apprensione mitica della realtà.
Quella sorta di realismo magico che è associato all’idea dell’indistinzione tra simbolo e cosa viene insistentemente negato nelle esemplificazioni proposte e ci si avvia a sostenere che «la magia poggia sempre sull’idea del simbolismo e del linguaggio» [128]in un senso interamente diverso da quello che una simile affermazione potrebbe avere nel contesto filosofico cassireriano. Di fronte alle pratiche adottive che imitano le vicende del parto, «sarebbe da stolti credere che qui vi sia un errore, che la madre creda di aver partorito il bambino»[129]. Il fatto che il bambino venga fatto passare attraverso le vesti della madre esprime l’adozione e, a suo modo, la dice.Così in generale le pratiche magiche dicono i desideri degli uomini: il desiderio di una caccia abbandonante o che la terra sia fertile e la siccità non devasti il raccolto: senza che si effettui il passaggio dal desiderio soggiacente alle operazioni magiche all’idea della onnipotenza del pensiero, della sua realizzazione «magica». Certamente, le operazioni magiche presentano desideri appagati, ma ciò accade per il semplice fatto che non è possibile rappresentare un desiderio se non rappresentando il suo appagamento. Solo in questo modo possiamo renderci ragione del fatto che nonostante tutte le pratiche che dovrebbero assicurare il successo della caccia, il selvaggio provvede ad assicurarsi in proprio avvelenando accuratamente la punta delle sue frecce.
Non meno significativi da questo punto di vista sono gli esempi che attaccano la pretesa identità tra l’immagine e la cosa. Talvolta l’innamorato bacia l’immagine dell’innamorata: e questo comportamento non si basa sulla credenza «in un determinato effetto sull’oggetto rappresentato dal ritratto»[130]. E allora perché ci si comporta così? A quale scopo mira questo atto? A nessuno scopo. Agiamo così, e ci sentiamo appagati. Il solo fatto di cercare spiegazioni ci sembra sbagliato.
 27. Il ripresentarsi del nesso tra immaginazione e mito
27. Il ripresentarsi del nesso tra immaginazione e mito
Le osservazioni nelle quali risulta con la massima evidenza che per Wittgenstein la componente simbolica fa parte della stessa coscienza mitica sono probabilmente quelle che riguardano il problema dell’efficacia delle pratiche magiche. La credenza in questa efficacia è naturalmente un ovvio corollario dell’inconsapevolezza della distanza simbolica. Così in Cassirer non si dubita sull’autenticità della credenza nell’efficacia, per esempio, dei riti per la caccia: benché il rito stesso si presenti come una sorta di pantomima del desiderio che anticipa imitativamente «fin nei più minuti particolari la cattura e l’uccisione dell’animale»[131], questa relazione con il desiderio dovrebbe restare nascosta alla coscienza mitica stessa, la quale vincolerebbe l’effettuazione del rito al risultato che con esso si ritiene di poter conseguire. L’importanza del rito sarebbe così strettamente dipendente dalla sua efficacia: mentre appaiono invece subito chiare le difficoltà e i paradossi a cui una simile concezione si espone. Queste difficoltà non erano certo sfuggite a Frazer che si era posto il problema di spiegare le ragioni per le quali gli inevitabili e continui insuccessi delle pratiche magiche non fossero senz’altro palesi e non conducessero al loro rapido declino. In particolare Wittgenstein trae da Frazer l’informazione che i riti della pioggia si verificano quando sta per arrivare la stagione delle piogge. Per Frazer ciò va spiegato indubbiamente con l’astuzia dello stregone, il quale del resto può anche contare sul fatto che prima o poi pioverà. L’efficacia deve in qualche modo essere subdolamente garantita, e ciò richiede tanto l’intelligenza dello stregone quanto 1’ottusità della sua tribù.
A tutto ciò Wittgenstein obietta molto semplicemente: «È molto strano che gli uomini non giungano a rendersi conto che prima o poi pioverà»[132]. E con ciò l’impostazione del problema è interamente ribaltata. Il fatto che i riti si svolgano in prossimità della stagione delle piogge mostra proprio che tutti hanno una chiara cognizione delle vicende meteorologiche e che di conseguenza l’importanza connessa al rito è totalmente indipendente dalla credenza nella sua efficacia. La relazione con il desiderio che conferisce all’azione una funzione di rasserenamento, il fatto che il desiderio stesso riguardi eventi che hanno una importanza vitale, tutto ciò e sufficiente ad illustrare la serietà del rito. In esso viene evocato e celebrato un evento vissuto nella carica emotiva che gli proviene dalla sua connessione con il ritmo stesso della vita. Solo quando il sole sta per sorgere «vengono celebrati dagli uomini i riti per il sorgere del sole»; di notte essi «accendono semplicemente dei lumi»[133].
Il centro verso cui convergono tutte queste considerazioni è ormai chiaro: nel loro insieme esse portano alla massima accentuazione il carattere celebrativo e cerimoniale del comportamento mitico-magico. Se noi proponessimo la formula «l’uomo è un animale cerimoniale», questa formula conterrebbe certamente qualcosa di giusto[134]. Essa attirerebbe infatti l’attenzione sul fatto che, accanto alle azioni quotidiane, gli uomini ne compiono altre, di natura interamente diversa, che potremmo chiamare «azioni rituali».Un libro di antropologia dovrebbe cominciare, a titolo di chiarificazione preliminare che stabilisca un orientamento di lettura del materiale documentario, proprio con il proporre una simile distinzione, cercando nello stesso tempo di circoscrivere con precisione la nozione di «azione rituale».
Certamente Wittgenstein non va oltre una simile indicazione sommaria. Anche se a noi essa non sembra di poco conto, soprattutto se teniamo presente la tematica che abbiamo svolto in precedenza in modo autonomo e seguendo un diverso filo conduttore. Che la pratica magica debba essere intesa come un ripristino del livello metaforico sembra implicito nell’insieme così come in alcune osservazioni di dettaglio. Per esempio, quando Wittgenstein, alludendo alla concezione della malattia come un animale estraneo, osserva che «nella guarigione di una malattia con la magia, si intima alla malattia di abbandonare il paziente. Dopo la descrizione di una cura magica del genere, verrebbe sempre da dire: se la malattia non capisce questo, non so proprio come glielo si debba dire», egli sembra voler sottolineare che la cura che consiste nella intimazione non è una tecnica conforme a quella concezione, ma si ricollega piuttosto all’immagine stessa da cui quella concezione è sorta.
Anche il tema della segregazione è ovunque implicitamente operante, e lo è in particolare nei luoghi che illustrano la nozione di azione rituale. Si consideri in proposito l’esempio dei comportamenti possibili nei confronti della persona del re. Wittgenstein sottolinea che, in linea di principio, questi comportamenti potrebbero essere i più vari e anche incompatibili tra loro: «Ci possiamo immaginare, per esempio, che il re di una tribù non sia visibile per nessuno, ma anche (all’opposto) che ogni uomo della tribù lo debba vedere. Certo, in quest’ultimo caso, ciò non dovrebbe accadere più o meno per caso, ma il re dovrebbe essere mostrato alle gente. Forse nessuno può toccarlo o forse, invece, lo dovrà toccare»[136]. Questo esercizio di antropologia immaginaria dimostra che non è tanto il contenuto delle prescrizioni proposte che interessa, quanto anzitutto il semplice fatto che vi siano delle prescrizioni. Queste sono poi tali da conferire alle azioni rituali una proprietà che le contraddistingue nettamente dalle azioni quotidiane: lo stesso scopo può essere conseguito da azioni o comportamenti strettamente antitetici. Le prescrizioni sono dunque indifferenti al contenuto, ma esse debbono in ogni caso attenersi ad una regola che presuppone una opposizione. In questo senso va intesa anche l’affermazione secondo cui l’azione cerimoniale deve essere fredda o calda, in contrapposizione alle azioni comuni che sono invece tiepide [137].
La scelta deve essere netta ed esclusiva tra alternative opposte: cosicché se si è deciso che il re debba essere invisibile, allora esisteranno prescrizioni che imporranno, per esempio, la messa a morte di chi ha scorto il re che viene tenuto nascosto; inversamente, se il re può essere visto, al tempo stesso lo deve, e ciò non avverrà in un modo qualunque, per così dire, tiepidamente. La visione accidentale deve essere esclusa perché sopprime la sacralità della persona regale.
Nel contesto di considerazioni come queste il problema dell’immaginazione non potrà alla fine non ripresentarsi in tutta la sua rilevanza; e in particolare proprio il tema della associazione delle idee, come un tema a cui non possiamo affatto rinunciare in una considerazione che abbia di mira le produzioni del mito.
Note
[1] E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (in seguito indicato con FFS), 3 voll., La Nuova Italia, Firenze 1961-66, II, p. 9.
[2 ] ivi, p. 10.
[3] ivi, p. 19.
[4] J.G. Frazer, Il ramo d’oro, 3 voll., Boringhieri, Torino 1965.
[5] ivi, p. 9.
[6] ivi, p. 21.
[7] ivi, p. 82.
[8] ivi, p. 84.
[9] ivi, p. 91.
[10] ivi, p. 97.
[11] ivi.
[12] ivi, p. 98.
[13] ivi, p. 77.
[14] ivi, p. 75.
[15] ivi, pp. 78-79.
[16] ivi, p. 31.
[17] ivi.
[18] E. Cassirer, Storia della filosofia, Il Saggiatore, Milano 1968, IV, pp. 165-175.
[19] ivi, p. 169.
[20] ivi.
[21] ivi, p. 173.
[22] ivi, pp. 173-174.
[23] ivi, p. 186.
[24] FFS, I, p. 7.
[25] ivi.
[26] ivi, p. 10.
[27] ivi, p. 8.
[28] ivi, p. 19.
[29] ivi, p. 21.
[30] ivi, p. 37.
[31] ivi.
[32] ivi, p. 38 e sgg.
[33] ivi.
[34] ivi, p. 39.
[35] ivi, p. 40.
[36] ivi, p. 41.
[37] ivi. p. 43
[38] ivi, p. 47.
[39]ivi, p. 37
[40] ivi, p. 47.
[41] ivi, p. 48.
[42] ivi.
[43] ivi. p. 49.
[44] FFS, II, p. 38.
[45] E. Cassirer, Linguaggio e mito (in seguito indicato con LM, Il Saggiatore, Milano 1961, p. 59.
[46] FFS, II, p. 52.
[47] LM, 59.
[48] FFS, II, p. 37.
[49] ivi, p. 57.
[50] ivi, p. 58.
[51] ivi.
[52] ivi.
[53] ivi.
[54] ivi p. 63.
[55] ivi, p. 53.
[56] L.Lévy-Bruhl, La mentalità primitiva, (in seguito indicato con MP), Einaudi, Torino 1966.
[57] ivi, p. 86.
[58] ivi.
[59] ivi, p. 87.
[60] ivi, p. 54.
[61] FFS, I, p. 54.
[62] ivi, p. 55.
[63] ivi, p. 44.
[64] ivi.
[65] ivi, p. 66.
[66] ivi, p. 48.
[67] ivi, p. 67.
[68] ivi, p. 65.
[69] ivi, p. 67.
[70] ivi, p. 73.
[71] ivi.
[72] ivi, p. 75.
[73] ivi, p. 73.
[74] ivi, p. 95.
[75] ivi, p. 96.
[76] ivi, p. 250.
[77] ivi, p. 251.
[78] ivi.
[79] ivi, p. 253.
[80] ivi, p. 252.
[81] ivi, pp. 69 e 80.
[82] ivi, pp. 97.
[83] ivi, p. 83.
[84] ivi, p. 100. Deve essere notato che tutti quei principi che Cassirer rammenta come principi informatori dell’esperienza mitico-magica (dunque la pars pro toto, il post hoc, ergo propter hoc, la sostanzializzazione, ecc.) non sono altro che i principi che reggono la formazione delle immagini in genere e che la retorica ha analizzato e classificato. Per quanto poco si insista sul rapporto tra retorica e mito nella Filosofia delle forme simboliche, esso è ben presente in Cassirer e appare formulato a tutte lettere in Linguaggio e mito.E interessante tuttavia sottolineare che, attraverso il richiamo a un piano di esperienza «radicalmente metaforico», la cui radicalità consisterebbe nel fatto che la metafora non viene appresa come tale, questo tema viene esso stesso subordinato alla tesi del simbolismo implicito, il cui carattere portante per un approccio filosofico al problema dell’esperienza mitica viene così ulteriormente ribadito.
[85] E. Cassirer, Saggio sull’uomo, Armando Editore, Roma 1968. Cfr. in particolare p. 160 e sgg.
[86] MP, p. 46.
[87] ivi.
[88] ivi, p. 20.
[89] ivi, p. 23.
[90] R. Otto, Il sacro, Feltrinelli, Milano 1966, p. 19.
[91] Sull’argomento si rimanda a G. Piana, Elementi di una dottrina del dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1979.
[92] FFS, p. 52.
[93] L. Wittgenstein, Note sul «Ramo d’oro» di Frazer, (in seguito indicato con LW), Adelphi, Milano 1975, p. 37.
[94] MP, p. 296.
[95] FFS, II, p. 85.
[96] MP, p. 34.
[97] M. Eliade, Il sacro e il profano, Boringhieri, Torino 1967, p. 14.
[98] FFS, II, pp. 113-114.
[99] MP, p. 344.
[100] FFS, 11, p. 123.
[101] ivi, p. 109.
[102] ivi, p.113.
[103] M. Eliade, op. cit., pp.24, 28, 31.
[104] ivi, pp.23, 34, 45, 64.
[105] ivi, p.19.
[106] ivi, p. 37.
[107] MP, p. 86.
[108] ivi.
[109] ivi, p. 89.
[110] ivi, p.82.
[111] ivi, p. 83.
[112] H. Bergson, Le due fonti della morale e della religione, Comunità, Torino1963, p. 123.
[113] ivi.
[114] ivi, p.124.
[115] LW, p. 21.
[116] R. Rhees in L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni, Adelphi, Milano 1967, p. 43.
[117] LW, p. 28.
[118] ivi, p. 18.
[119] ivi, p. 37.
[120] ivi, p. 18.
[121] ivi, p. 17.
[122] ivi, p. 34.
[123] ivi, p. 18.
[124] ivi, p. 34.
[125] ivi.
[126] FFS, III, 1, p.82.
[127] ivi, p. 90.
[128] LW, p. 22.
[129] ivi.
[130] ivi, p. 21.
[131] FFS, II, , p.255.
[132] LW, p. 19.
[133] ivi, p. 26.
[134] ivi.
[135] ivi, p. 24.
[136] ivi.
[137] ivi.
Ritorna all'inizio di questo saggio
