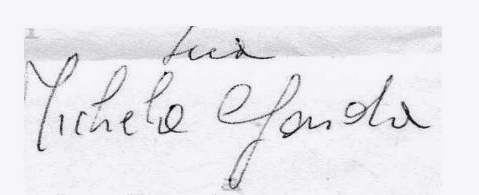è attualmente docente di Storia della musica e musicologia presso la Facoltà di Musicologia, Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona e presso il dipartimento di Musicologia e dei Beni culturali dell'Università di Pavia. Ha scritto una densa e ampia recensione della mia "Filosofia della Musica" per la rivista Musica/Realtà, Agosto 1992, n. 38 che viene riportata qui per intero. Contenendo essa alcuni precisi rilievi critici, intercorse tra noi uno scambio epistolare che mi sembra interessante allegare alla sua recensione.
GIOVANNI PIANA, Filosofia della musica, Guerini e associati, Milano 1991, pp. 295.
Un volume dal titolo Filosofia della musica si impone all’attenzione prima di tutto per la dichiarazione d’intenti. Dalla Filosofia della musica moderna di Adorno (1949) in poi la conside-razione filosofica di quest’arte sembra essersi fatta impossibile come riflessione teoretica autonoma. Il su “luogo naturale” si è spostato in altri ·campi: nell’ambito di quella che è stata chia-mata speculazione compositiva (cfr. Borio G., “Filosofia della musica oggi?”, Musica/Realtà, 32, 1990), e nelle discipline musicologiche particolari, come la semiologia, la psicologia, la psicoacustica ecc. Questa riapertura del fronte filosofico-musicale si inscrive tuttavia in un orizzonte ben diverso sia dall’impostazione adorniana (la cui problematica non viene sfiorata nell’opera, neppure come riferimento polemico) sia da quella delle singole branche musicologiche. Essa si inquadra piuttosto nella dimensione inaugurata dall’Husserl della Crisi delle scienze europee: quella di una riproblematizzazione delle convinzioni dominanti per mezzo di una messa tra parentesi, di un’epochè del sapere scientifico. Il metodo di questa indagine sulla musica è dunque quello di mettere in campo una serie di “ovvietà”, saggiandone la tenuta all’indagine fenomenologica e indicando, nel caso di una loro disfatta, il mutamento di prospettiva della problematica: secondo Piana, un problema malamente risolto nasconde in sé un’angolatura dalla quale è possibile scorgere un interrogativo nuovo e ripensare da capo la questione. Le ovvietà che l’autore mette in gioco fin dall’inizio possono irritare chi legge, in quanto appartengono al novero di quelle convinzioni che si danno appunto per scontate e costituiscono pertanto una base sicura per successive riflessioni. Costante obiettivo polemico risulta infatti un tipo di impostazione che Piana chiama “prospettiva semiologica”, nella sua declinazione empirico-filosofica e convenzionalistica (Nattiez). Di fronte a queste impostazioni, che riconducono la referenzialità della musica in sostanza a un fatto di abitudine, Piana contrappone una risalita a un “piano prelinguistico”. In altre parole, egli propone di abbandonare la dimensione delle opere in quanto “oggettività culturali integrate in una tradizione e che debbono essere colte e afferrate in questa integrazione, in questa loro essenziale storicità” (p. 33) e suggerisce di rivolgere attenzione analitica ai suoni che compongono le opere e ne costituiscono la struttura. I suoni sono dunque intesi come materiale percettivo determinato, “che ha in se stesso ... prima che una qualunque elabora-zione lo faccia rivivere all’interno dell’opera musicale, le sue determinazioni e differenze caratteristiche, le proprie qualità specifiche che stanno a fondamento di molteplici modalità possibili di connessioni e di rapporto” (ivi). Detto in questi termini, sembra si tratti di una contrapposizione tra concezioni differenti e questa esposizione riassuntiva non rende giustizia al metodo utilizzato. Con estrema abilità argomentativa infatti Piana fa nascere la nuova impostazione del problema proprio dal cuore delle stesse ovvietà che, opportunamente interrogate, arrivano esse stesse a mostrare nuove aperture e prospettive interpretative. È questa la fonte del disorientamento del lettore che si sente in un certo senso espropriato delle proprie. certezze quasi senza accorgersene, in quanto la discussione parte proprio da esse, come in un dialogo socratico mascherato. Si conceda tuttavia la schematizzazione delle posizioni allo ·scopo di poterne ragionare in quella forma di riflessione in sessantaquattresimo che è la recensione. Questo mutamento di prospettiva implica almeno una restrizione del titolo: non si tratta a ben vedere di una filosofia della musica (genitivo oggettivo), bensl di una riflessione che ne vuole saggiare la possibilità in generale e determinarne i possibili contenuti, risalendo a una dimensione originaria del suono. L’idea di va considerata quindi in un senso tutto particolare, che non è certo quello di un primum storico fattuale: Piana dice esplicitamente che si tratta di una “proiezione genetica di ciò che si pensa sia la musica stessa – ciò che la musica è alle sue origini è anche ciò che essa è nel suo fondo” (p. 69). Questa affermazione di sapore vichiano nasconde tuttavia un itinerario descrittivo speculativo volto a esplorare quelle forme elementari e immediate della produzione del suono, che la esemplificano in maniera pregnante: sono analisi di atti corporei (l’aprire la bocca formando una cavità in cui risuona il suono, il battere la mazza sul tamburo) che permettono di descrivere le modalità in cui si dà il suono come materiale percettivo. Vi sono a questo proposito pagine bellissime che rivelano a tratti una. vocazione mitopoietica, e a tratti una singolare finezza di interpretazione degli antichi miti, soprattutto quelle dedicate all’origine della voce, alla descrizione del fenomeno dell’ascolto e ai commenti dei miti musicali raccolti da Marius Schneider. La ricognizione dei contenuti possibili della riflessione filosofico-musicale si articola in quattro grandi aree tematiche: materia, tempo, spazio e simbolo. Come si vede, l’esigenza di indagare la dimensione dell’origine non è un semplice atteggiamento neutrale. Esso va invece a toccare proprio quei nuclei tematici che hanno più profondamente impegnato le moderne forze speculative: la riflessione dei compositori dell’avanguardia, l’acustica e la psicoacustica. Premesso che le indagini di impostazione fisicalistica non hanno alcuna rilevanza per il nostro autore, va notato che invece la collisione con tematiche proprie della musica contemporanea viene esplicitamente rilevata. Uno degli intenti dell’opera è appunto quello di collegare in qualche modo due diversi ordini di problemi: quello dei fondamenti possibili di una teoria della musica e quello del carattere della musica novecentesca. Questo secondo proposito rimane tuttavia sullo sfondo e si realizza in generici accenni alle coincidenze tra alcune prospettive adottate dalla musica novecentesca e le prese di posizione scaturite dalle singole analisi fenomenologiche. Si tratta forse dell’aspetto meno convincente dell’opera, non solo per il carattere rapsodico degli accenni che vi sono dedicati. Viene spontaneo chiedersi infatti se sia possibile parlare di carattere generale della musica di un’epoca contraddistinta da manifestazioni musicali cosi varie e contraddittorie come quelle del Novecento (Strauss, Hin-demith, Varèse, le avanguardie, Orff, Bart6k, Boulez ecc.). In un rigurgito di hegelismo l’autore arriva ad affermazioni di questo genere: “Nel quadro di queste opposizioni estreme che fanno parte di un unico problema si definisce una ricerca che contiene in sé, più o meno oscuramente, l’aspirazione a una vera e propria rifondazione del musicale. In realtà è questo il senso più profondo della novità nello spirito della musica novecentesca. E in questo senso è certamente contenuto il pensiero di un ritorno a ciò da cui la musica in generale trae la sua origine” (p.64). Si conceda pure che questa pretesa coincidenza tra la tendenza della musica e quella della filosofia verso un ritorno all’origine sia solo un occasionale stimolo di riflessione e non abbia pretesa di interpretazione storica. Rimane comunque l’idea del carattere unitario della musica novecentesca a suscitare notevoli perplessità. Non si è forse di fronte proprio a una di quelle ovvietà, che in campo storico-musicale ci si sforza di evitare, anche se non sempre con successo? Nell’economia della Filosofia della musica di Piana questo livello d’indagine rimane comunque in secondo piano e rappresenta più un desideratum che un tema sviluppato e pensato fino in fondo. Si tratterebbe del resto di un’impresa impensabile senza un’adeguato e sufficientemente ampio apporto di informazione storica sull’argomento. La difficoltà di mettere in relazione il piano speculativo con quello storico non getta comunque alcuna om-bra sulle affascinanti analisi dedicate agli elementi primari del suono. A trovare spunti preziosi per un’applicazione musicale delle intuizioni del filosofo può essere proprio il compositore che oggi si trova comunque sempre coinvolto nella riflessione sugli apriori del linguaggio musicale: spazio, tempo e - in senso lato - materia. Di estrema finezza speculativa sono le pagine dedicate al rapporto tra musica e tempo. Esse gettano nuova luce sui luoghi comuni tuttora diffusi sull’argomento (si veda per esempio la brillante critica a uno dei più diffusi topoi dell’estetica musicale: la temporalità come dimensione più profonda della musica e quindi espressione del senso interno e della vita affettiva dell’uomo e in quanto tale opposta al dominio esterno delle arti figurative) e al tempo stesso giungono a delineare nuovi concetti: soprattutto quello di suono come oggetto temporale inteso come fenomeno di “evenienza”. Con questo Piana ripensa il concetto di suono in termini di processo e di continuità, confutando fino in fondo la pervicace idea del suono come oggetto puntuale, come cosa paragonabile a ciò che nel campo della geometria è il segmento. Queste riflessioni costituiscono le premesse speculative a una definizione teoretica estremamente innovativa del concetto di ritmo, quanto mai bisognoso di un approfondimento teorico (l’unica monografia dedicata da Wilhelm Seidl a questo argomento e conosciuta an-che in Italia nella bella traduzione edita dal Mulino è una rassegna storica delle teorie sul ritmo, che lascia il lettore non specialista più disorientato di prima, soprattutto in un paese come l’Italia che non ha conosciuto la rigorosa educazione musicale di un Riemann). In una serrata argomentazione condotta sia sul versante fenomenologico sia su quello etimologico Piana giunge a definire il ritmo come “tensione tra suono e silenzio”, come “diga” alla continuità dd flusso temporale, rendendo così conto della peculiare forza o energia che scaturisce da esso. Un suggerimento prezioso per il musicologo inoltre è quello di impiegare il concetto di oggetto musicale nell’analisi soprattutto con lo scopo di ovviare alle difficoltà sollevate dalla necessità di segmentare un testo.
Ci si vuole soffermare ancora sulla discussione di un ultimo problema, che si trova all’incrocio tra interessi compositivi e musicologici e che è stato ed è tutt’ora il letto di Procuste di ogni riflessione sulla musica: quello della differenza tra consonanza e dissonanza. Questo problema emerge quasi inaspetta-tamente nel corso della costruzione del concetto di spazio sonoro, uno dei capitoli più fecondi dell’opera, soprattutto per il costante confronto con le riflessioni di alcuni compositori contemporanei (Boulez e Xenakis). In effetti l’elaborazione di questo concetto costituisce la premessa alla determinazione della coppia dissonanza/consonanza. Proseguendo la critica alla concezione oggettivistica e puntuale del suono, Piana defi-nisce lo spazio sonoro come un continuum in cui non esistono singoli suom, ma un mutamento incessante del suono, inteso come metamorfosi e trasmutazione. Lo spazio sonoro (secondo il modello già elaborato nella Psicologia della musica di Rèvész) risulta cosl visualizzabile in una linea spiraliforme che si eleva nella terza dimensione, a indicare la ciclicità dei ritorni della stessa specie di nota, differenziata nell’altezza, ma non nella sua qualità sonora. Questo modello di spazio sonoro rende possibile un ripensamento del concetto di consonanza, basato unicamente sull’analisi dell’atto percettivo, quindi senza mettere in campo i problemi teorici sollevati dalla diversa composizione degli armonici del suono. I concetti chiave di questa argomentazione sono la coppia simile-dissimile. Piana parte dall’osservazione che l’ascoltatore sia in grado di riconoscere il riapparire del suono nella sua qualità intrinseca a prescindere dall’altezza, ossia di compiere una vera e propria sintesi retroattiva. Egli chiama questo processo “apprensione percettiva della ripetizione”. Questo movimento circolare chiuso (da un suono a un altro e ritorno al primo) si manifesta nel caso più elementare nell’unisono, in cui l’orecchio percepisce l’assoluta identità, ma è facilmente estendibile all’intervallo di ottava. Si tratta infatti di due suoni simili in quanto a qualità sonora, ma non identici in quanto ad altezza. L’elemento essenziale di questa argomentazione è che il carattere di simile e dissimile non pertiene ai suoni in quanto tali, ma all’atto della percezione di una sequenza di suoni. Gli intervalli costituiti da suoni che vengono percepiti come simili andranno perciò nominati secondo il carattere di chiusura che manifestano alla percezione, mentre aperti saranno quelli che non consentono il movimento retroattivo di riconoscimento del suono. In questo modo viene implicitamente dedotto anche uno dei più imbarazzanti principi del sistema tonale: la tendenza della consonanza a riposare in se stessa e, viceversa, della dissonanza a risolvere: “Nel caso dell’intevallo – consonantico l’avanzare del suono è trattenuto e frenato dal richiamo retroattivo - cosicché da questo punto di vista, il suono compie un movimento minimo, non procede, tende a restare nel luogo in cui si trova. Mentre nel caso dell’intervallo dissonantico; il semplice fatto che non vi è alcuna sintesi retroattiva ci consente di affermare che vi è un’effettivo avanzare del suono, un protendersi in avanti piuttosto che all’indietro” (pp. 232-3). Tuttavia l’argomentazione di Piana prosegue sul piano puramente fenomenologico, lasciando da parte i punti di contatto o meno con la travagliata storia del sistema tonale. I diversi gradi di consonanza e dissonanza infatti vengono dedotti a partire dalla concezione continua dello spazio sonoro: il flusso sonoro considerato nello spazio ridotto dell’intervallo di ottava è caratterizzato da un progressi-vo allontanamento dal punto di massima consonanza dell’unisono verso una forte dissonanza che tende poi ad attenuarsi andando verso un punto consonantico. Raggiunto l’acme il flusso torna a invertirsi verso la dissonanza. Il punto di massima consonanza è dunque individuato negli intervalli di quarta e di quinta, che hanno il carattere di “punto di volta”, in quanto “quel punto può essere appreso uditivamente come punto terminale di uno sviluppo sonoro di un determinato tipo” (p. 248). La problematica della differenza di dissonanza e consonanza – che aveva sollecitato l’interesse dell’autore proprio a causa della sua misteriosa persistenza al di là della molteplicità delle definizioni, concezioni e pratiche che a essa si richiamano – viene dunque ricondotta al piano della struttura fenomenologica e intesa come presenza all’interno del flusso sonoro di un “unico punto di consonanza e di aree di consonanza e di dissonanza intese come transizioni”.
Il fatto storico che per i greci oltre l’unisono e l’ottava il termine di consonanza potesse essere applicato solo all’intervallo di quinta e di quarta assume per Piana quasi una dimensione di aurorale disvelamento: “Questa circostanza viene spesso citata come conferma di una visione relativistico-soggettivistica del problema: come se quell’impiego linguistico documentasse che per l’orecchio greco qualunque altro intervallo fosse avvertito come dissonante. A noi invece piace pen-sare che l’impiego tanto ristretto del termine fosse soltanto un segnale della prossimità all’aspetto strutturale del problema” (p. 248-9). Le conclusioni cui giunge Piana per la strada fenomenologica non sono dissimili dai principi proposti da Hindemith già nel 1937 nella Unterweisung im Tonsatz. Ciò potrebbe essere di per sé niente più che una felice coincidenza. Tuttavia il fatto che si giunga a conclusioni simili per strade differenti non è in questo caso del tutto irrilevante. Nel suo manuale di composizioni Hindemith intendeva far tabula rasa della confusione in cui era caduto il sistema tonale e rifondarlo a partire da principi che aveva la pretesa di dimostrare come naturali. Hindemith era pienamente consapevole, che partire dall’intervallo di ottava era una scelta arbitraria e tuttavia opportuna per costruire un sistema utile a determinati scopi. Così giustificava la sua scelta nel capitolo dedicato ai “Modi per costruire una scala musicale”: “Il presupposto per costruire una scala musicale di pratico impiego è suddividere l’intero campo sonoro in segmenti sovrapposti di una certa grandezza e di eguale ampiezza e di riempirli quindi con i suoni della scala. Ci sembra ovvio dalle pre-messe naturali che questi segmenti debbano iniziare con il primo dei suoni che costituiscono un’ottava. Altri tipi di suddivisione sono artificiali, come per esempio i tetracordi dell’antica musica greca basati sull’intervallo di quarta o alcune scale della musica araba, che evitano l’intervallo di ottava. Si tratta infatti di strutture che non tengono conto della successione degli armonici e non si adattano ai nostri scopi. Un sistema che fa a meno delle ottave sarebbe altrettanto adatto a trattamenti armonici e melodici, ma sarebbe fuori questione per la sua scarsa adattabilità a finalità pratiche. Infatti non soddisfa il requisito fondamentale che deve possedere un sistema che si voglia applicare a più voci, ossia che si possano condurre più linee esattamente in parallelo...”(Hindemith P., Unterweisung im Tonsatz, Schott, Mainz 1940, p.42-43). In altre parole la suddivisione dello spazio sonoro in ottave (lo si pensi secondo un modello bidimensionale come Hindemith o tridimensionale come Révész) è una scelta costruttiva e non un apriori della percezione del suono. In quanto scelta costruttiva è anche una scelta storica, legata a esigenze espressive e a modelli linguistici e formali storicamente tramandati. Essa dunque non si colloca solo sul piano della struttura, in quanto la struttura musicale non è in quanto è, ma in quanto gli uomini la pensano, la creano e la pongono in essere. Anche la scelta dell’ottava dunque risulta un’ovvierà che andrebbe per lo meno problematizzata. La concezione della consonanza-dissonanza basata sulla mino-re o maggiore somiglianza tra i suoni che sembra – mutatis mutandis – essere comune a Hindemith e a Piana, pare quanto mai inadatta a una teoria generale della musica come mezzo per comprendere la musica divenuta e già quindi immersa nella dimensione storica. Semmai – come lo era per Hindemith – per la musica a farsi.
Un’ultima osservazione: l’autore non nasconde il suo disprezzo nei confronti delle tendenze convenzionalistiche e re-lativistiche che ama ridurre al minimo comun denominatore dell’abitudine. In conclusione della sua discussione dei concetti di consonanza e dissonanza giunge addirittura a parlare dell"‘ ottusa idea di clausole fondate unicamente sull’abitudine" (p. 252). Questo disprezzo ha la sua origine in un’interpretazione riduttiva del concetto di abitudine appiattito a una dimensione comportamentistica: “Un’abitudine è in generale iun modo di comportamento al quale noi ci atteniamo istintivamente , senza riflessione eplicita: e si intende che essa può essere ·acquisita e anche perduta. Ma una nuova abitudine, nell’ambito dello stesso genere di cose, scaccia la vecchia – questo è ovvio. Non posso es-sere abituato a levarmi il cappello come saluto e a non levarlo affatto […] Sarebbe interessante - conclude l’autore - considerare con quali argomenti ci si potrebbe opporre a esiti così apertamente paradossali” (pp. 32-33). Ora gli esiti di questa argomentazione sono così paradossali perché la scelta dell’esempio è pensata per confondere il lettore e costruire un paradosso che non esiste. Basta introdurre il concetto di ‘contesto’ per indebolirlo. Facciamo anche noi un esempio, tratto dai comportamenti della vita quotidiana. Gran parte degli Europei ha l’abitudine di abbassare e rialzare il capo ripetutamente per esprimere con un gesto il proprio assenso e di scuoterlo per significare la negazione. Durante un viaggio in Grecia o in Bulgaria un viaggiatore, diciamo italiano, avrà modo di imparare l’uso di invertire i gesti e dunque scuotere la testa per annuire e viceversa per negare. Tornato in patria e superato qualche attimo di confusione tornerà a fare quello che avrà sempre fatto, ma avrà imparato un altro comportamento da attivare per esempio in una futura vacanza. Questo per dire che l’abitudine non è un riflesso condizionato, ma una tecnica acquisita sulla base dell’esercizio, applicabile in alcuni contesti e in altri no. L’elemento istintivo è relativo al carattere quasi inconsapevole che assume il gesto abituale: quando cambio la marcia dell’automobile non ho bisogno di pensare separatamente tutta la sequenza di gesti occorrenti. Posso continuare a parlare con il mio compagno di viaggio, senza prestare attenzione e la mia mano eseguirà “da sola” il gesto occorrente. Così il pianista non pensa quale dito abbassare in ogni singolo passaggio musicale, ma gli sembrerà che le mani vadano da sé. Nel caso dell’ascolto la dimensione dell’automatismo dell’abitudine ha senza dubbio un ruolo enorme, altrimenti ci troveremmo di fronte a un ascoltatore del tutto incolto, ma questo automatismo è inserito in un complesso meccanismo di decodificazione dei contesti di regole. Un ascoltatore dotato di sufficiente competenza, infatti, sarà in grado di attivare differenti automatismi, a seconda se ascolta un madrigale di Gesualdo, una sinfonia di Mozart o un brano di Ligeti. Viene dunque da chiedersi: il convenzionalismo e il relativismo sono veramente gli obiettivi polemici primari, contro cui è necessario scagliarsi per giustificare una risalita al piano prelinguistico dei suoni? Oppure il problema non è piuttosto l’inverso ossia che la risalita alla dimensione prelinguistica, pre-storica non risolve il problema storico della differenza dei linguaggi della musica (ci perdoni l’autore l’uso del termine linguaggio che disapprova) e quindi non va in direzione - come vorrebbe Piana - di una teoria generale della musica? Una metateoria musicale dovrebbe a nostro parere fare i conti con altri obiettivi polemici: il concetto adorniano della storicità del materiale musicale e le teorie ermeneutiche della ricezione. La risalita alla dimensione originaria del suono (alla cui fascinazione e interesse non ci si intende in alcun modo sottrarre) ci sembra piuttosto una speculazione con cui sostenere quella reale tendenza manifestatasi nell’avanguardia musicale all’ampliamento e al rinnovamento dei materiali musicali: una filosofia del suono dunque inteso come oggetto temporale e in quanto tale appartenente all’ambito della natura (seppure pensata in termini fenomenologici e non fisicalistici), ma non una filosofia della musica, in quanto oggetto culturale e storico.
Michela Garda
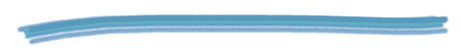
Cara Michela Garda,
voglia scusarmi se mi faccio vivo con tanto ritardo rispetto all'uscita della Sua recensione alla mia Filosofia della musica - sarebbe stata mia intenzione scriverLe alla prima lettura, ma poi il tempo passa in modo veramente travolgente! Desidero ringraziarLa di cuore per la lettura attentissima che ha dedicato a questo mio libro, per il modo in cui espone le tesi che io vi sostengo ed in particolare per la discussione critica che Lei avvia in questa sua recensione – una circostanza che sta diventando sempre più rara e a cui è subentrato una sorta di neutralismo generalizzato del dico e non dico, che ha delle motivazioni alquanto sospette.
Proprio per questo vorrei aggiungere qualche commento ad alcune Sue osservazioni - senza avere la benché minima pretesa di avere l'ultima parola, ma solo di portare un po' di acqua al mio mulino come è abbastanza giusto che io faccia. Ci troviamo del resto di fronte ad argomenti di cui potremmo discutere a lungo e che in larga parte attendono approfondimenti, completamenti, integrazioni. Vi sono intanto alcuni piccoli dettagli che possono essere precisati – e fra i primi naturalmente io porrei la sferzata del «rigurgito di hegelismo» che ho sentito fischiare con una certa violenza al di sopra del mio capo e che sono riuscito ad evitare solo per un soffio.
Naturalmente io mi sento, per formazione culturale e per carattere, lontanissimo dal ritenere che in me parli lo spirito del tempo. Mi sembra solo interessante l'idea che nella musica del nostro secolo serpeggi l'aspirazione ad una rifondazione del musicale, ed è per me motivo di meraviglia che tanto poco essa sia stata oggetto di enunciazione esplicita e di riflessione. E mi sembra anche che il serpeggiare di questa idea sia un tratto caratteristico, un tratto profondo della musica novecentesca. Ciò non ha particolarmente a che vedere con una pretesa unitaria la cui inconsistenza è semplicemente evidente. Oppure non si può proprio parlare di musica novecentesca? E perché mai non si può?
Un altro dettaglio, ma che punta già sulla formulazione di un dissenso più profondo, riguarda i suoi rilievi a proposito di Hindemith – rilievi che vanno peraltro presi con la massima attenzione. Vi è però un punto che non mi sembra possa essermi imputato: ed è la pretesa di far valere una relazione fenomenologico-strutturale su un terreno diverso da quello a cui appartiene. La suddivisione dello spazio sonoro in ottave non è per nulla una scelta costruttiva, ma è una questione che riguarda il modo in cui è fatto lo spazio sonoro - e tuttavia il modo in cui è fatto lo spazio sonoro contiene solo possibilità e non prescrizioni per la pratica compositiva.
Ciò tocca appunto un dissenso più profondo sul quale naturalmente non è il caso di insistere più di tanto e, come ho detto prima, mi sembra particolarmente apprezzabile avere dato ad esso evidenza. Naturalmente l'insistenza con la quale Lei sostiene che questa filosofia della musica non è in realtà veramente tale non essendo in grado di compiere il passaggio alla dimensione storica, e tanto meno di rendere conto di una teoria generale – mi fa pensare che dovrò ancora a lungo portare le mie pene. Le sue conclusioni - che a dire il vero mi hanno un poco sorpreso, dato i Suoi spiriti anti-hegeliani riportano esattamente su quelle che sono appunto le mie premesse polemiche. Ed è superfluo aggiungere che ritengo l'obiezione che la mia sarebbe una filosofia del suono e non una filosofia della musica così alla portata che forse sarebbe prudente non stendere subito la mano per afferrarla.
Le rinnovo i miei ringraziamenti per i tanti apprezzamenti positivi che sono contenuti in questa sua recensione che è indubbiamente tra le più ricche e meditate che siano state dedicate a questo mio libro. Ed augurandomi di poterLa presto conoscere di persona Le invio intanto i miei saluti più cordiali.
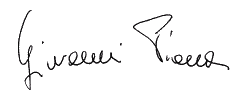
21 Marzo 1993
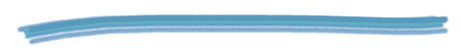
Torino, 19.4.1993
Gentile Professore,
La ringrazio moltissimo per la Sua lettera e l’attenzione prestata alla mia recensione al Suo libro. Le rispondo purtroppo in ritardo e di questo mi scuso. La Sua lettera ha sollevato problemi che mi hanno fatto riflettere e volevo risponderLe adeguatamente. Le mie riflessioni purtroppo non sono state così feconde: ad un più attento esame della questione non posso che concordare su quanto afferma a proposito della suddivisione dello spazio sonoro in ottave. Quanto al suo invito a considerare più in profondità che cosa sia una filosofia del suono, riconosco la mia imprudenza e invoco come attenuante il genere infido della recensione che costringe ad oscillare tra il dir troppo (per poterlo giustificare) e il troppo poco. Su altri punti forse è meglio rimandare ad una possibile, auspicabile da parte mia, conversazione a voce in cui avrò molto da imparare da Lei e forse pochi contributi da portare, oltre a quelli di un lettore attento, affascinato dalla sua scrittura, tanto da cercare di resistervi con qualche critica.
Nel frattempo ho letto le Sue considerazioni inattuali su Adorno. Oltre ad aver appreso bellissime pagine di storia della cultura italiana, ho trovato assai interessante la Sua polemica antiadorniana. A proposito della tendenza a preferire un Adorno piccolo piccolo mi sono sentita un po’ toccata, perché anch’io – come molti della mia generazione “allattati” ad Adorno – mi ritrovo a consolarmi con qualche fulminante pagina del francofortese e al tempo stesso a cercare di lasciar da parte l’impostazione generale del suo pensiero. Il Suo affondo coglie nel segno. Tuttavia mi chiedo se non valga la pena di leggere ancora Adorno contro Adorno, perlomeno come esponente di una cultura musicale che è oggi scomparsa: penso ad Adorno come quell’ascoltatore ideale che il filosofo identificava nel barone Charlus di Proust. È un peccato che nel numero di Musica/Realtà in cui è comparso il Suo saggio non abbia trovato posto un dibattito più ampio. Adorno in Germania – per esempio – ha avuto un significato notevole in campo musicologico: uno studioso come Dahlhaus ha dei grandi debiti nei confronti del filosofo. Dal momento che in Italia oggi si traduce e si legge in dosi massicce Dahlhaus sarebbe interessante porre attenzione anche agli adorniani “civili” oltre che ai “selvaggi”.
La ringrazio di cuore, ancora una volta e in attesa di conoscerLa di persona Le porgo i miei migliori saluti.