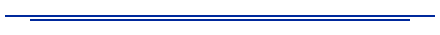Materiali di lavoro per un corso sul tema “Linguaggio ed esperienza nella filosofia della musica” tenuto nel 1987 (Università di Milano, Insegnamento di Filosofia teoretica I). Il testo di riferimento è La musique et l'Ineffable, ed. du Seuil, Parigi 1983, I ed. Colin, Parigi 1961, trad. it. a cura di E. Lisciani-Petrini, Tempi moderni Ed., Napoli 1985. I numeri di pagina delle citazioni si riferiscono a questa traduzione italiana. - Accurate informazioni sulle opere di Vladimir Jankélévitch e sulla bibliografia si possono trovare nel sito internet: http: //utenti.lycos.it /jankelevitch/. Radio France, con lodevole iniziativa, mette a disposizione le interviste di Jankélévitch contenute nei propri archivi all'indirizzo http://www.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/ete2003/jankelevitch/archives.php.
edizione digitale: 2003
 Giovanni Piana, Il tema dell'ineffabilità nella filosofia della musica di Jankélévitch (1987) (pp. 27 - Kb 247
Giovanni Piana, Il tema dell'ineffabilità nella filosofia della musica di Jankélévitch (1987) (pp. 27 - Kb 247

Il tema dell'ineffabilità
nella filosofia della musica
di Jankélévitch
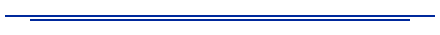
Secondo un aspetto caratteristico del suo atteggiamento filosofico complessivo Jankélévitch, nel suo libro del 1961 intitolato La musica e l'ineffabile (1961 - trad. it. a cura di E. Lisciani-Petrini, Napoli 1985) - non intende impegnarsi in una discussione provvista di una forte base sistematica, ma sviluppare invece considerazioni che funzionano da semplici tracce che in nessun modo impediscono sviluppi divaganti - in un senso che non intende essere peggiorativo. Al contrario! Questa scelta lascia intravvedere alcune prese di posizione generali che conferiscono unità all'insieme, ma nello stesso tempo libera il pensiero a spunti stimolanti - e non importa se alla fine non potremo forse lodare quest'opera per la sua “profondità”. Ci basta la ricchezza delle idee che essa mette a nostra disposizione.
E nemmeno è da intendere in senso peggiorativo il notare che in questo libro le preferenze musicali dell'autore hanno un particolare rilievo - il modo in cui l'autore si appoggia ad esse contiene la rivendicazione implicita e sacrosanta ad avere un gusto ed a farlo valere nei propri ragionamenti, nelle proprie valutazioni che assumono un respiro così ampio da arrivare a fornire interessanti prospettive da cui guardare alla musica del nostro tempo: molto spesso al di fuori di luoghi comuni assai più solennemente annunciati.
In questo libro si parla della musica, e non si vuole pretendere di sentenziare intorno a ciò che la musica del nostro tempo è, o non è, o dovrebbe essere. Questo senso della misura - insieme all'intelligenza delle osservazioni e alla bellezza dello stile - è uno dei pregi non secondari di questo lavoro.
Per la nostra formazione e per le nostre inclinazioni filosofiche - diciamolo subito - il titolo ci appare sospetto. La musica e l'ineffabile - l'ineffabilità della musica. Prima di avventurarci nella lettura conviene rendere esplicite alcune nostre perplessità. Tutti forse siamo convinti che la musica debba dire qualcosa. Un brano musicale non si presenta come un muro di suoni al di là del quale non c'è null'altro. Nello stesso tempo un poco di riflessione insegna subito che non può darsi nessuna traduzione verbale di ciò che viene detto musicalmente. Se dunque la musica è un dire, essa dice ciò che non può essere detto in parole. Ma ciò che non può essere detto in parole è ancora un dire? Cosicché si affaccia subito una possibile relazione interna tra la musica e l'ineffabile. Ma sul modo in cui questa relazione viene posta cominciano i dubbi e le perplessità. Intanto vi sono almeno due modi di impiegare parole come questa queste - l'ineffabile, l'indicibile: un modo strettamente letterale che sembra poter aderire a contesti del tutto quotidiani; ed un modo che esalta il senso letterale e che dunque riporta il loro impiego a contesti eccezionali.
Sarei tentato di dire: vi è un senso calmo ed un senso esaltato. L'indicibile in senso esaltato si riferisce ad un senso nascosto che tuttavia in qualche modo viene comunicato, senza tuttavia uscire dal nascondiglio in cui si trova; vi è perciò un'allusione al mistero, a cose tanto sublimi oppure tanto tremende da non poter trovare espressione nelle parole di cui è costituito il nostro linguaggio. Ineffabile sarà dunque un'esperienza eccezionale, tanto eccezionale da non poter essere trasmessa con parole o contenuta in esse. L'ineffabilità esaltata è dovuta ad una sorta di sovrabbondanza di senso: ciò che è ineffabile è un contenuto troppo grande per il contenente della parola.
Ma vi è anche un possibile impiego del termine che potremmo generalizzare a piacere in rapporto a circostanze affatto comuni. Prendiamo dunque quella parola alla lettera. Ed allora ci avvediamo subito di quante siano le cose che ci circondano che possono essere caratterizzate come ineffabili! Possiamo forse dire in parole che cosa sia la ruvidità della superficie di un oggetto? Oppure il profumo di un fiore? E chi se la sentirà di esporre in parole il senso della parola “rosso”? Ineffabili sono le sensazioni in genere; ed anche i sentimenti - possiamo pretendere forse di porgere all'interno delle parole la sostanza effettiva dei nostri sentimenti?
In questa ineffabilità non vi è nemmeno l'ombra, o almeno non sembra che vi sia, di quello straripamento di senso a cui abbiamo accennato in precedenza: il senso straripa da un contenente inadeguato. E nemmeno vi è da rincrescersi particolarmente di questa “impossibilità” di dire, o almeno la gente comune non se ne rincresce: a differenza, talvolta dei filosofi. Il fatto che il linguaggio non sappia “dire” l'aroma del caffè, secondo un esempio proposto da Wittgenstein, potrebbe non essere per nulla considerato come un suo limite. Il fatto stesso che possa sorgere un simile problema è singolare. In certo senso un'affermazione sull'ineffabilità si svolge in due passi: il primo passo pone il compito della verbalizzazione, il secondo passo rappresenta una sorta di verifica della sua impossibilità. Ma la domanda è: che cosa rende giustificato anzitutto il primo passo? E ciò equivale a chiedere: a chi mai potrebbe venire in mente di tentare una traduzione verbale dall'aroma del caffè? E se a qualcuno viene in mente una cosa simile, non dovrà forse anzitutto rendere conto dei motivi che lo spingono a questa impresa? Così se qualcuno afferma che ogni tentativo di tradurre in parole un motivo musicale va incontro ad un fallimento, una simile affermazione poggia sulla sensatezza del compito della traduzione verbale, sensatezza di cui si può dubitare. Alla richiesta di tradurre in parole possiamo rispondere che ciò non è possibile (come se prima avessimo a lungo tentato di farlo) oppure possiamo respingere la sensatezza del compito. In questo secondo caso ci rifiutiamo di effettuare il primo passo, e quindi non possiamo pervenire al secondo. Tra l'una e l'altra risposta vi è una grossa differenza - nel primo caso la questione dell'ineffabilità viene costruita, nel secondo si impedisce in via di principio la sua costruzione.
Queste considerazioni inviterebbero a una sorta di minimalizzazione del tema dell'ineffabilità in rapporto alla musica, ad evitare il suo surriscaldamento. Ciò che sospettiamo è che il legame tra musica e ineffabilità conduca non tanto ad una concezione sbagliata della musica, quanto piuttosto ad una concezione unilaterale, come se tutta la musica - o anche tutta la musica vera - dovesse contenere allusioni a qualcosa di sublime.
Tanto il nostro interesse viene ravvivato non appena scopriamo nelle pagine di Jankélévitch una più ricca articolazione del problema. Non vi è dubbio infatti che il tema dell'ineffabile sia in questo autore ricco di risonanze metafisiche, di rimandi alla lontana ad una componente religiosa: eppure, se leggiamo con attenzione questo testo si rimane stupiti nel constatare quanto poco venga enfatizzato questo tema dell'ineffabilità, quanto poco esso venga surriscaldato, cosicché quel senso della misura che prima avevo richiamato in via generale per l'insieme dell'opera vale anzitutto proprio per questo suo tema centrale.
Nel primo capitolo, largamente introduttivo, si comincia con il sottolineare la doppiezza della musica.
La musica è sempre stata intesa secondo caratterizzazioni fortemente contraddittorie: come un'arte frivola e marginale, legata alla danza, al piacere, alla sensualità, alla corporeità; ma altrettanto spesso essa è stata invece intesa come un'arte che si appella all'intelletto piuttosto che alla sensibilità, all'interno delle cose piuttosto che all'esteriorità in genere. Tenendo conto di questa doppiezza, si comprende per quale motivo si siano manifestate nel corso del tempo perplessità nei confronti della musica che chiamano in causa il piano dell'etica e della morale; ma vi è anche tutta una tradizione (forse la tradizione dominante) che porta l'attenzione sugli aspetti conoscitivi, sulla relazione con strutture astratte, sulla relazione della musica con l'essenza stessa della realtà.
In rapporto al primo aspetto J. rievoca un problema molto antico che è presente nel mito e che è esemplarmente rappresentato dalla posizione platonica: ciò che Platone teme nella musica è proprio la sua potenza, la sua capacità di incantare - e ciò significa soggiogare, impedire, frenare l'esercizio della razionalità. La musica si collega così alla magia, a quella che Jankélévitch chiama “causalità nera”.
“Se si vogliono schiavi, ci vuole quanto più è possibile musica” - sembra dicesse Tolstoj - sicuramente grande amante della musica - come riferisce un suo biografo, frase che Jankélévitch cita a sua volta. Il potere della musica è un potere “scabroso”, proprio perché questo potere è fondato sul fascino, sullo charme (una parola che potrebbe essere tradotta forse con “incanto”). E perciò essa può essere anche intesa come l'“oggettivazione della nostra debolezza”. Il mito delle Sirene che attraverso il canto portano gli uomini alla perdita di sé è in proposito assai significativo.
Questo tema della capacità seduttiva della musica ricorre di continuo, con intonazione diverse, ma con un fondamento comune. Jankélévitch rammenta anche la posizione di Nietzsche, il suo “rancore” contro quegli aspetti della musica che tengono ad affascinare morbosamente e che fanno affiorare l'elemento mistico, l'elemento notturno.
La posizione vera e propria di Jankélévitch comincia a prospettarsi nel momento in cui egli passa dal problema etico al problema metafisico. Cominciamo allora ad intravvedere i primi segnali intorno al modo in cui Jankélévitch intende far giocare il tema dell'ineffabilità all'interno delle proprie considerazioni.
Questo tema si annuncia nella tesi secondo cui “la musica direttamente e in se stessa non significa niente se non per associazione o convenzione” (ivi, p. 17). Un'affermazione come questa in realtà può essere proposta da punti di vista diversi e il suo senso dipende fortemente dal contesto in cui essa è inserita.
Dal punto di vista filosofico dobbiamo anzitutto richiamare l'attenzione sul fatto che anche sullo sfondo di questa frase, come in generale nella riflessione di Jankélévitch, vi è la posizione di Bergson. Questa presenza è avvertibile in almeno due momenti: il cadere dell'accento sulla tematica temporale secondo inclinazioni che esamineremo tra breve e l'atteggiamento nei confronti del linguaggio e quindi del rapporto tra musica e linguaggio. In Bergson il momento della manifestazione linguistica viene in generale considerato come una sorta di fissazione e quindi anche di irrigidimento e di impoverimento della ricchezza e della fluidità dell'esperienza vissuta. Ciò determina un sorta di connotazione negativa sul linguaggio che viene considerato incapace di restituire sul piano verbale ciò che accade nella realtà della vita spirituale, quando addirittura questa realtà non viene tradita ed esposta al fraintendimento dal linguaggio stesso. Questo accenno negativo investe anche le metafore, le espressioni figurate in genere, che appaiono come artifici con i quali il linguaggio tenta, in realtà senza successo, di dare espressione adeguata ai contenuti dell'esperienza vissuta.
Per Jankélévitch, la frase sulla mancanza di “significato” della musica non ha tanto il senso di una tesi “formalistica”, quanto piuttosto intende attrarre l'attenzione sulla profonda equivocità che consiste nel considerare il fenomeno musicale dal punto di vista linguistico.

La prima conseguenza di questa posizione sta in un netto rifiuto di istituire un rapporto tra musica e ontologia - un rapporto che fa parte dal tempo dei tempi degli intrecci tra musica e metafisica. Ci troviamo così intanto a prendere atto che un libro che si propone di trattare della musica e dell'ineffabile prende le mosse da una polemica che sembra orientata proprio contro questi intrecci.
La tendenza metafisica nella filosofia della musica attraversa tutta la tradizione storica e, ad avviso di Jankélévitch, la sua origine deve essere ricercata nel fatto che l'uomo è da sempre “amante delle allegorie”, e quindi è stimolato a ricercare significati al di là del puro fenomeno sonoro, in ciò guidato indubbiamente dal riferimento linguistico:
"Decifrare nel sensibile non si sa qual messaggio criptico, auscultare dentro e dietro un cantico qualcosa d'altro, percepire nei canti un'allusione ad altro, interpretare una cosa ascoltata come allegoria di un significato inaudito e segreto: ecco i tratti permanenti di ogni ermeneutica applicabili anzitutto all'interpretazione del linguaggio..."(ivi, p. 16).
Questo modello ermeneutico potrà tanto più agevolmente, e tanto più erroneamente, essere applicato al musicale proprio perché “la musica non significa niente, dunque significa tutto...”; si può far dire alle note ciò che si vuole, prestare loro qualsiasi potere anagogico: “esse non protesteranno”.
"La musica ha le spalle larghe! (La musique a bon dos!) con essa tutto è plausibile: le ideologie più fantastiche, le ermeneutiche più insondabili... Chi mai ci smentirà?" (ivi).
Si tratta certo di osservazioni cariche di senso polemico. Si critica qui la tendenza a considerare il brano musicale come un testo, forse più precisamente come un testo sacro: i riferimenti alle interpretazioni misticheggianti (Plotino, Clemente di Alessandria, Agostino) o di stile teosofico (Fabre d'Olivet) sono espliciti; ed è significativo anche, da questo punto di vista, l'uso del termine “ermeneutica”, originariamente riservato all'esegesi biblica come del resto del termine “anagogico”, che si richiama ad un significato allegorico, ed anch'esso riferito in prima istanza ai testi sacri.
Vi è dunque una critica della sacralità della musica, e proprio in nome della sua ineffabilità. Di questa critica fa parte il sottolineare come all'interno di questa posizione si finisca con lo svalutare la fenomenicità, la concretezza percettiva della musica, quasi che essa potesse essere considerata come una manifestazione imperfetta di una musica sovrasensibile che appartiene appunto al livello metafisico del reale.
Ecco dunque che Jankélévitch si fa sostenitore di questa fenomenicità, e di conseguenza assume un atteggiamento fortemente critico contro ogni “metamusica” - ogni al di là della musica che non può che essere considerata come una pura fantasticheria “arbitraria” e “metaforica”.
Perché mai, si chiede Jankélévitch,
"unico fra tutti gli altri, il senso dell'udito avrebbe il privilegio di aprirci l'accesso alla cosa in sé e di sfondare così il tetto della nostra finitezza? In virtù di quale monopolio certe percezioni, quelle dette uditive, sarebbero le sole a sfociare nel mondo dei noumeni?" (ivi, pp. 17-18).
La metafisica della musica, ribadisce Jankélévitch, si può edificare solo “sulla base di analogie e trasposizioni metaforiche” - e quando parla di analogia e di metafora Jankélévitch, ricordandosi di Bergson, intende queste espressioni in senso fondamentalmente negativo. Questa sua critica delle “trasposizioni metaforiche” arriva a rendere del tutto estrinseche le qualificazioni dei suoni che contengono riferimenti spaziali, come il parlare di suoni alti e bassi, di uno scendere e di un salire della linea melodica (ivi, p. 20). Con una simile posizione non possiamo certo concordare per il semplice fatto che è possibile una concezione della metafora e delle immagini in genere che si muove in un orizzonte e con conseguenze del tutto differenti. Una simile concezione è il risultato di una filosofia dell'immaginazione inadeguata, che non arriva a formulare l'idea di un momento immaginativo interno alla percezione. Tenendo conto di questa idea ci verremmo a trovare molto lontani dalle posizioni bergsoniane. Stando ad esse, Jankélévitch non può che sottolineare che quelle qualificazioni semplicemente non esistono nel mondo sonoro: si tratterebbe di metafore totalmente estranee al materiale musicale che vengono invece suggerite dalla scrittura musicale, dalla “trasposizione grafica e spaziale” -“è il pentagramma che proietta nello spazio la distinzione tra il grave e l'acuto”.
Accanto al tema del linguaggio che fa sostenere a Jankélévitch che “il pregiudizio metafisico riposa sull'idea che la musica è un linguaggio, una sorta di lingua cifrata, il cui alfabeto è costituito dalle note della scala musicale” (ivi, p. 23), si coglie qui un altro tratto tipicamente bergsoniano - cioè il riferimento alla spazialità come un momento essenzialmente contrapposto alla temporalità, e perciò anche all'esperienza vissuta.

L'atteggiamento critico verso un'idea della musica modellata su quella del linguaggio viene sviluppata in una notevole varietà di direzioni. Nel secondo capitolo si rammenta fin dall'inizio che il riferimento linguistico, ed in particolare retorico, ha pesato sulla tradizione musicale, proponendo di continuo immagini di provenienza linguistica sui decorsi musicali. Naturalmente occorre prestare attenzione a non confondere i piani di discorso, altrimenti le obiezioni a J. sarebbero realmente troppo facili. Non si tratta di contestare il dato di fatto storico dell'enorme varietà di interrelazioni tra la parola e la musica, e nemmeno l'importanza, ad esempio, che i riferimenti alla retorica hanno avuto nelle pratiche compositive. Si tratta di invece di cogliere le conseguenze che tutto ciò può avere nella sua proiezione sul piano della musicalità in genere, diciamo pure: sul modo di concepire l'essenza della musica. Infatti le immagini di provenienza linguistica hanno avuto tanto peso da far ritenere che esse portino sull'essenza del musicale - ed è questo il punto che viene contestato da Jankélévitch.
In particolare ciò vale secondo Jankélévitch per la nozione di sviluppo. Talora si pensa a questa nozione come qualcosa di assai simile ad un puro dispiegamento di un pensiero, di un ragionamento, come esposizione di una idea che poi viene discussa con l'obbiettivo, ad esempio, di convincere un uditorio della sua giustezza. L'esempio richiamato è quello del conferenziere che si rivolge ad un pubblico e che “sviluppa” il tema annunciato nel titolo della conferenza esplicitandone il contenuto e arricchendolo variamente al fine di ottenere il consenso dei propri ascoltatori. Questi a loro volta presteranno un ascolto teso a cogliere i passi dell'argomentazione: se da un lato il brano viene proposto come uno “sviluppo”, dall'altro l'ascolto assume la forma del “seguire”. Quest'ultima espressione non ha in questo contesto un senso propriamente temporale, ma assume coerentemente il senso del non perdere il filo, del seguire un ragionamento, nel senso di comprendere un passo dopo l'altro e naturalmente il legame tra l'uno e l'altro.
Ed è proprio questo modo di impostare il problema che viene sottoposto ad una critica, peraltro coraggiosa - tanto è diffuso quel modo di concepire le cose. Inteso così lo sviluppo non è altro che un “miraggio”. Sono miraggi lo scoprire in un brano musicale un preambolo ed una conclusione, qualcosa di simile in genere ad un discorso, ad una perorazione. Questa preclusione di Jankélévitch nei confronti dell'impiego di metafore tratte dal riferimento linguistico in taluni casi potrà sembrare eccessiva, perché non è detto, io credo, che l'uso di simili analogie comporti una nozione linguistica “forte” del brano musicale. Ma per Jankélévitch è importante sottolineare che “questi sono solo modi di parlare, metafore, analogie dettate dalle nostre abitudini oratorie e discorsive” (ivi, p. 24), volendo con ciò sottolineare proprio il carattere fittizio, irreale del rapporto istituito.
Ciò vale anche per la ricorrente immagine del “dialogo”. Talora si parla di dialogo in rapporto ad un duetto, oppure per il rapporto tra uno strumento solista e l'orchestra, o per le imitazioni nel senso tecnico del termine. Jankélévitch rileva allora che si tratta solo di metafore, che siffatte conversazioni sono fittizie.
“Nei quattro dialoghi di Bartok le due mani non dicono niente l'una all'altra! Né i due violini nei 44 duetti... Nella musica a quattro mani o a due pianoforti... le imitazioni sono dialoghi sono in senso metaforico... La musica conosce l'eco, che è il riflesso speculare della melodia su se stessa, e conosce l'imitazione del canone, ma non sa niente del dialogo” (ivi, pp. 27-28).
Così se vogliamo comprendere realmente il rapporto particolare che si instaura tra gli esecutori e il pubblico, occorre marcare la differenza tra il rivolgersi a qualcuno di un conferenziere rispetto al suo uditorio e la condizione dell'esecuzione e dell'ascolto di un brano musicale:
“La cantante ha un bel guardarmi con la sua bocca spalancata: non parla a me.. e quel grido rauco, nella seconda Chanson Madécasse di Ravel non apostrofa nessuno in particolare di coloro che ascoltano” (p. 29).
Questa differenza è efficacemente sottolineata quando Jankélévitch fa notare che “per il conferenziere che lo guarda, l'ascoltatore è seconda persona, cioè l'indispensabile correlato dell'invocazione o dell'allocuzione; mentre per il pianista seduto al piano è terza persona” (ivi, p. 29). Si tratta infine di una differenza che rimanda poi a quella tra parola e canto:
“Chi parla da solo è pazzo; ma chi canta da solo, come un uccello, senza rivolgersi a nessuno, è semplicemente allegro” (ivi, p. 29).

Il rifiuto dell'elemento discorsivo mette inoltre in causa l'elemento temporale. Nella nozione di sviluppo, lo si è visto or ora, non si dà particolare rilievo alla componente temporale. Su questo punto Jankélévitch intende far valere una tesi particolarmente forte.
Ogni discorso presuppone un piano - pensiamo all'esempio del conferenziere ed alla “scaletta” che egli prepara. Un piano è anche quello dell'architetto che deve costruire un edificio. In questa idea del “piano” Jankélévitch ritiene di cogliere un rimando spaziale importante, che sarebbe a dànno dell'elemento temporale, prossimo alla dimensione del vissuto, ed a vantaggio di una strutturazione che in ultima analisi è di ordine intellettuale. In certo senso Jankélévitch sostiene qui una posizione simmetrica e opposta a quella che Lévi Strauss suggella nella frase secondo cui “tutto avviene come se la musica e la mitologia non avessero bisogno del tempo se non per infliggergli una smentita. Esse sono entrambe macchine per sopprimere il tempo” (Il crudo e il cotto, trad. it. di A. Bonomi, Milano 1966, p. 32). Secondo Jankélévitch invece il momento temporale ha le netta prevalenza su quello strutturale. (Bergson è naturalmente sempre sullo sfondo).
"Là dove l'intelligenza associativa e spazializzante, sorvolando sul divenire, distingue più parti inquadrate fra un esordio ed una perorazione, l'orecchio, aderendo con genuina immediatezza alla successione vissuta, non si accorge di niente; senza la visione retrospettiva del cammino percorso il puro ascolto non noterebbe il piano della sonata, giacché il piano è cosa concepita, non cosa udita né tempo vissuto"(ivi, p. 24).
Si tratta di un'affermazione piuttosto energica nella quale si suggerisce che la “visione retrospettiva” necessaria per cogliere la struttura derivi da un atteggiamento intellettuale e che essa non sia conforme ad un puro ascolto: un “puro ascolto” si lascerebbe andare alla processualità temporale; anche in questo caso viene portata l'attenzione sulla distanza rispetto all'atteggiamento dell'ascolto di un discorso.
In quest'ultimo caso è essenziale proprio il non lasciarsi andare al puro succedersi l'una dopo l'altro delle parole, dal momento che deve essere afferrato un senso che si va dispiegando dalla prima all'ultima parola. In margine Jankélévitch giustifica con questo fatto la possibilità di “amare” autori molto diversi e persino stilisticamente contrapposti, dal momento che non vi è una “ideologia” da cui dobbiamo essere convinti nell'ascolto e dunque nemmeno un problema di “coerenza ideologica” (ivi, p. 30). Ma è forse marginale una simile osservazione? A mio avviso, si tratta invece di un grande ammaestramento!
In questo quadro rientra quella che Jankélévitch chiama insensibilità alle ripetizioni. La musica è insensibile alle ripetizioni (ivi, p. 26). Il riferimento al linguaggio parlato ancora una volta chiarisce il senso di una simile affermazione. Basti pensare alle ripetizioni nel discorso. Il limite di tolleranza alla ripetizione del discorso è molto basso: in questo senso il discorso è sensibilissimo alle ripetizioni.
"Le ripetizioni sono proscritte perché il discorso, sia che sviluppi un significato, sia che esponga o dimostri una tesi, procede sempre avanzando con progressione dialettica e cammina diritto senza voltarsi né tornare indietro. Qui ciò che è stato detto non deve essere più detto: una sola volta basta e ogni nuovo inizio è ozioso..." (ivi, p. 32).
Naturalmente nella lettura può essere che di continuo torniamo sui nostri passi per comprendere più a fondo un pensiero o uno sviluppo argomentativo: “Ma la necessità di rileggere non implica necessariamente il permesso di ripetere” (ivi, p. 33).
La ripetizione invece non solo è lecita nella musica, ma assolve spesso una funzione di primaria importanza. Occorre però mettere subito in rilievo il fatto che l'attenzione di Jankélévitch non va primariamente alle possibili funzioni strutturanti assolte dalla ripetizione, come a me sembrerebbe giusto fare, quanto piuttosto sulla connessione con il momento magico della musica - sulla musica come charme, come incanto (ed incantesimo).
La ripetizione fa parte della formula magica, delle pratiche di incantamento. Ed essa chiama in causa la “forza ammaliatrice” della musica. Jankélévitch si domanda anche se nella musica il parlare di ripetizione sia realmente appropriato, se la ripetizione sia ripetizione autentica (capace dunque di generare monotonia!). Si tratta di una domanda che sorge sullo sfondo della tematica temporale e di un preciso riferimento bergsoniano: “Non ha mostrato Bergson come ogni successivo ritorno del pendolo, per il solo fatto che è successivo ai precedenti nell'ordine della durata, modifichi qualitativamente il passato di colui che ascolta?” (ivi, p. 32). Così la ripetizione di un tema, il suo riapparire ha una funzione non meramente ripetitiva, ma ricreativa (ivi, p. 34).

Su questi temi di carattere generale si inseriscono riferimenti musicali, in parte con significato puramente esemplificativo, in parte delineando ed indicando precise scelte sugli sviluppi della musica novecentesca. Il discorso filosofico generale si salda così con valutazioni musicali ricche di interesse in quanto mostrano uno dei modi possibili di “guardare” alla musica del novecento.
Sul piano speculativo tendiamo a mostrare lo “sviluppo” come un miraggio: ed allora saremo particolarmente interessati a quelle musiche che rendono difficile l'applicazione della metafora, che in qualche modo la bloccano: le musiche che Jankélévitch chiama “stazionarie”, “brachilogiche”, “stagnanti” (ivi, p. 27) che manifestano nel loro stesso stile la volontà di “strangolare l'eloquenza” - e le citazioni spaziano da Dvorak, Ciakovsky, Mussorgsky, per spingersi sino a Strawinsky, Debussy, Ravel, Satie e altri.
Un miraggio è peraltro anche l'idea che la musica “esprima” qualcosa, benché ora la discussione di Jankélévitch diventi più tesa, più densamente problematica. Il titolo contraddittorio del capitolo secondo L'espressivo inespressivo (L'Espressivo inexpressif) annuncia ampiamente questa problematicità.
Occorre subito notare che lo scetticismo sull' “espressione” è determinato in Jankélévitch dall'intenzione di reagire al romanticismo musicale a cui egli ritiene che quella parola sia strettamente vincolata. D'altra parte la parola “espressivo” nel titolo del capitolo è intesa come indicazione esecutiva (e per questo è lasciata in italiano), e come tale si tratta certo di una parola caratteristica della musicalità romantica. Ma questa critica dell'“espressivo” piuttosto che tradursi in un dibattito astrattamente teorico che dovrebbe decidere se la musica possa esprimere sentimenti piuttosto che idee astratte o qualunque altra cosa, assume il proprio contenuto dello stesso piano musicale, cioè dai modi di reazione musicale all'espressionismo romantico.
Secondo Jankélévitch vi sono almeno due forme importanti di questa reazione. Vi è una reazione che potrebbe essere chiamata “impressionistica” e una reazione che invece potrebbe essere caratterizzata come un oggettivismo che pone l'inespressività come oggetto esplicito della propria ricerca.
Per comprendere questo modo di impostare la questione, occorre tenere presente che la parola “espressione” viene intesa specificamente come manifestazione di sentimenti e passioni: una concezione della musica che sottolinea la sua capacità di esprimere diventerebbe allora una concezione secondo la quale attraverso la musica verrebbero trasmesse “confidenze o confessioni sull'intimità affettiva del creatore” - i suoi umori. L'espressione è dunque per principio in questo contesto un'espressione umorale.
Tenendo conto di questo uso ben delimitato (e in sé, desidero sottolineare questo punto, niente affatto obbligatorio del termine) si comprende come si possa far giocare in contrapposizione il termine di “impressione”. L'impressione è stata talora interpretata - si pensi a Hume - come una sorta di entità intermedia o almeno neutra rispetto alla distinzione tra soggettività e oggettività. Così del resto ne parlavamo i pittori impressionisti. Mentre l'espressione nell'accezione or ora illustrata è “esibizionistica e soggettiva” - l'impressione invece, pur essendo legata alla soggettività, non intende portare alla luce la sua vita interiore, ma dissolvere la soggettività verso l'esterno, ad esempio, nell'esteriorità atmosferica di un paesaggio.
"La coscienza introversa si libera grazie all'impressione atmosferica" -“...uno dei mezzi che l'uomo ha per non raccontare se stesso è quello di parlare delle colline di Anacapri, del vento della pianura o delle campane attraverso le foglie" (p. 43).
A questa forma "impressionistica” di reazione antiromantica, si affianca una reazione più netta, più esplicita e più dura: una tendenza cioè ad escludere l'espressione attraverso una rappresentazione del reale come tale: dunque di un reale che non sia colto attraverso il sentimento o l'impressione, ma nemmeno in qualche modo trasfigurato dagli ornamenti e dalle elaborazioni dell'arte. Il canto degli uccelli, il canto dell'usignolo è stato mille volte imitato nella tradizione musicale: ma come è realmente il canto dell'usignolo? Esso è sempre stato trasfigurato musicalmente. Nel Chant du Rossignol di Strawinsky - osserva Jankélévitch - l'usignolo canta con il suo canto - e lo stesso si può dire per il riferimento agli uccelli nei Quadri di Mussorgsky o per il Catalogo di Messiaen, in contrasto con il Francesco di Assisi di Liszt oppure con Saint-Saëns. Naturalmente si è subito tentati di contestare esempi come questi e l'idea che sta alla loro base; ma essa non va presa, a mio avviso, alla lettera, bensì vista alla luce di una reazione “antiespressiva” teorizzata rivendicando una forma di Sachlichkeit, di aderenze alle cose pure e semplici. Ciò che importa non è il risultato - che ovviamente è in ogni caso plasmato dalla soggettività artistica - ma l'intento, e questo intento conduce del resto ad evitare “musicalizzazioni” secondo mezzi correnti e convenzionali. “Nei Quadri di un'esposizione di Mussorgski il balletto dei pulcini con le sue sonorità acidule e stridenti, con il suo realismo un po' aspro, contrasta con la melodiosa musicalità dei concerti di uccelli che si sentono nel Francesco d'Assisi di Liszt, proprio come l'usignolo di Stravinskij contrasta con gli armoniosi usignoli di Rimskij Korsakov. E il Catalogue d'oiseaux di Messiaen vuol essere la registrazione fedele di veri canti d'uccelli, senza le onomatopee letterarie e le convenzioni imitative di un Daquin o di un Saint-Saëns” (ivi, p. 47).
È interessante notare come questo motivo oggettivistico, questo iperrealismo sia impiegato da Jankélévitch anche per rendere conto dell'avanzare nella musica del novecento di sonorità dure, di dissonanze, di sonorità prossime al rumore, sino all'introduzione del rumore direttamente “trovato” nella vita di ogni giorno.
"L'oggettivismo acuto, che rifugge la vita patica sempre malata di espressione (la vie pathique en mal d'expression), si approssima a quella zona amelodica, amusicale, paramusicale e premusicale che è, come l'oceano, l'universo del rumore amorfo e del brusio caotico" (ivi, p. 52).

Proprio nel riportare il tema dell'espressione nel quadro della cosiddetta “reazione antiromantica”, Jankélévitch propone un proprio punto di vista su alcuni aspetti importanti della musica novecentesca - sia pure sommessamente, secondo il suo stile. Egli suggerisce che questo momento reattivo penetra a fondo negli sviluppi della musica novecentesca determinandone in larga parte il suo senso interno. Più precisamente: da un lato vi è un intenso bisogno di espressione, un “istinto espressionista”, dall'altro un'altrettanto intensa volontà di repressione, vi è il “rigore della musica che lo respinge”. Perciò egli ritiene di poter riconoscere all'interno di questi sviluppi un momento di “violenza” che sorge nel gioco di questo contrasto. Per ragioni certamente profonde, che dovrebbero essere indagate a fonto, tutta la musica del novecento sembra svilupparsi soggiacendo ad una vera e propria fobia dell'espressione (ivi, p. 56). Ecco dunque i due volti possibili della musica novecentesca: il volto come grimace - una smorfia, un ghigno irrigidito; oppure il volto come maschera, dove il volto per il fatto stesso di perdere la propria mobilità cessa di essere espressivo per diventare “volto immobile dell'inespressione”.
La violenza si accanisce contro l'espressione del volto - essa “si diverte a torturare ed a tormentare la tonalità, l'intonazione e tutte le determinazioni espressive del canto” (ivi, p. 57). “La violenza crocifigge la forma” - dice Jankélévitch con una formula molto efficace; ed altrettanto efficace è il parlare della dissonanza atroce (l'atroce dissonance) (ivi, p. 55) oppure della “straziante volontà di bruttezza” (la poignante volonté de laideur) (p. 57).
Di fronte a queste frasi occorre guardarsi dal ritenere che ci troviamo di fronte a condanne o a nostalgie. La violenza di cui si parla non è del resto una violenza puramente distruttiva, ma una violenza che sa essere geniale, che “ritorna all'informe in quanto sorgente di tutte le forme” e che sa scoprire “una poesia inusitata ed un piacere musicale più raffinato” (pp. 57-58).
In effetti io credo che quando si parla di atrocità della dissonanza o della straziante volontà di bruttezza si abbia a che fare non tanto con una valutazione, quanto piuttosto con un suggerimento interpretativo. Esso fa leva sull'idea di un intenso conflitto interno proprio sulla coppia espressivo-inespressivo per mostrare poi le varietà di atteggiamenti che si muovono al suo interno. Tutti gli sviluppi successivi del capitolo consistono in una sorta di rassegna di queste diverse modalità di “rimozione” dell'istinto di espressione. Qualche cenno in proposito, senza entrare nel dettaglio, basterà a rendere conto della cosa.
Come abbiamo notato or ora, al ghigno come manifestazione diretta della violenza si affianca, ed anche si contrappone, la maschera (ivi, p. 60). La rimozione dell'espressione può assumere la forma della semplice impassibilità, dell'indifferenza espressiva, del “non voler esprimere niente”:
"La volontà di non esprimere niente è la grande civetteria del ventesimo secolo" (p. 60).
Ma naturalmente questa civetteria può manifestarsi in più modi: ad esempio attraverso il riferimento diretto o indiretto all'elemento meccanico nei quali si dà manifestazione alla “fobia per l'esaltazione lirica o lo slancio patetico”:
“Gli stridenti meccanismi di Satie, gli organetti di Barberia di Séverac, i marchingegni automatici e gli orologi di Ravel, i burattini di Stravinskij e di De Falla, il rumore delle macchine in Prokofiev rivelano tutti un'identica fobia per l'esaltazione lirica e lo slancio patetico; pianole meccaniche e uccelli automatici, ridicole marionette e automi rimontati: tutte queste musiche artificiose, con le loro sacrileghe contraffazioni, sembrano ironizzare sulla tenerezza e il languore dell'Appassionato” (ivi, p. 61).
Oppure con richiami animaleschi che hanno la stessa direzione di senso, e sono conseguentemente privi di valenze naturalistiche.
“In una certa misura il bestiario moderno risponde alla medesima diffidenza: in Satie e Ravel gli animali, con il loro balbettio, i loro tic e i loro farneticamenti, rappresentano come una scimiottatura delle passioni umane - instancabilmente rimuginata, la cacofonia delle volpi, delle civette e delle rane, in La volpe astuta, è una delle forme dell'antiretorica che caratterizza sia il genio di Janácek sia il genio di Musorgskij” (ivi, p. 61).
A questi momenti contenutistici si aggiungono elementi appartenenti piuttosto al lato formale. È il caso qui di richiamare l'attenzione sulle acute osservazioni di Jankélévitch sull'impiego del pedale nella tecnica pianistica, sulle variazioni agogiche, sullo staccato e sul pizzicato.
Il pedale, prolungando la risonanza dei suoni, provoca una sorta di sfondo sonoro, di bruma sonora, accentuando l'enfasi espressiva. Nel caso dello staccato o del pizzicato si rafforza invece il carattere puntiforme dei suoni, un modo d'essere dei suoni che richiama l'idea della burla, dello “scherzo”, del sarcasmo o dell'ironia piuttosto che gravi momenti di pathos. L'aspetto tecnico-esecutivo è dunque subito associato ad una inclinazione di significato:
"Lo staccato corrisponde, nell'ordine dell'istantaneo, come la brachilogia nell'ordine dello sviluppo, alla fobia per l'indugio patetico... Lo scherzo proscrive la vibrazione che, generando approssimazione e continuità, prolunga i suoni anteriori nei successivi e realizza quella fusione fra presente e passato, quella sopravvivenza o risonanza del passato attraverso il presente, in una parola quell'immanenza il cui nome è il divenire" (ivi, p. 63).
Così il ritardando e l'accelerando sono già di per sé segni di un momento emotivo emergente, un richiamo alle irregolarità che caratterizzano l'uomo rispetto alla macchina e la reazione a ciò sarà naturalmente una “cronometria implacabile”:
"Non attardatevi dunque, continuate a marciare! Non stringete, ma soprattutto non rallentate: si potrebbe credere che vi siate commossi..." (ivi, p. 64).
Vi sono naturalmente anche altri modi di indossare la maschera che ci difende all'espressione: ad esempio, il dire il contrario di ciò che si dovrebbe dire, eventualmente suscitando un effetto umoristico così come il parlare d'altro oppure il dire di meno. Jankélévitch rammenta l'indicazione esecutiva di Ravel “senza espressione” proposta in rapporto ad una frase particolarmente patetica; oppure l'indicazione di Satie di “jouer comme une bête” proprio in un punto in cui la musica “si fa più teneramente commossa”. (Si trova nei Tre pezzi in forma di pera di Satie il cui titolo rappresenta a sua volta un buon esempio di reazione ironica all'espressione).
Con le formule del dire altro o del dire di meno Jankélévitch si richiama ai vari modi in cui è possibile attuare attenuazioni espressive sia giocando su fatti musicali specifici, sia sul rapporto tra musica e testo. In questo quadro ritorna il problema della “brachilogia”. La brevità è certamente da intendere come una reazione al fluire del sentimento.
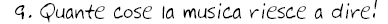
Richiamiamo ora vivacemente l'attenzione su questo punto: tutte queste osservazioni hanno senso solo se si ammette che la musica possa proporre canti di uccelli, gracidar di rane, così come narrare del vento della pianura o di campane attraverso le foglie. Togliete questi riferimenti contenutistici e l'intera discussione perderà il proprio oggetto. Eppure abbiamo cominciato a parlare della relazione della musica con l'ineffabile. Ma quante cose riesce a dire la musica secondo Jankélévitch!
Il contenuto non compare naturalmente mai ingenuamente come contenuto determinato, ed anzi di continuo viene sottolineato in modo particolare la presenza di un momento di pura evocazione e di allusione.
La musica è persino capace di descrivere e di narrare. Jankélévitch non lo nega: ma essa può fare questo solo “a grandi linee” (“en gros”). Come Jankélévitch riesca a mantenere la propria polemica contro il carattere discorsivo della musica, senza rinunciare alla problematica del contenuto, lo si vede con chiarezza in rapporto alla nozione di senso del senso che riceve un' illustrazione particolarmente chiara in rapporto alla musica a programma. Il programma - eventualmente esplicitamente esposto - fa precedere un senso alla musica che segue ad esso. E così anche un titolo descrittivo eventuale. Ora, nota con grande acume Jankélévitch la musica non esprime questo senso e nemmeno lo illustra, ma esprime ed illustra il senso di questo senso. “Nelle melodie e nei poemi sinfonici a programma è il senso che precede e la musica dispiega secondariamente il senso di questo senso” (ivi, p. 78). Che cosa si vuol dire con un'espressione così misteriosa? Io tenderei a commentarla così: il senso dell'espressione “vento della pianura” rinvia a qualcosa di relativamente ben determinato. Ma quante cose possono essere fantasticate in esso! E in questo orizzonte immaginativo più ampio che in questo modo si dischiude consiste il senso di quel senso. Ma si tratta di una nostra accentuazione interpretativa coerente forse più con la nostra filosofia dell'immaginazione che con quella di Jankélévitch.
Quanto più si procede nella lettura e nell'analisi degli esempi, ci si rende conto che il titolo apparentemente contraddittorio del capitolo L'espressivo inespressivo indica una presa di posizione che consente di giocare con particolare duttilità proprio in rapporto al problema semantico. Così è possibile oscillare tra rilevanza e irrilevanza del momento descrittivo per il fatto che in fin dei conti sosteniamo che l'oscillazione tra determinatezza e indeterminatezza del contenuto fa parte dell'essenza stessa del musicale.
Tuttavia si sente qui come altrove la mancanza di una teoria dell'immaginazione che sia in grado di sostenere l'intera tematica, cosicché finisce con il prevalere il richiamo alla “forza dell'abitudine, dell'associazione e delle convenzioni” - nonostante considerazioni che suggeriscono una possibile differente direzione di discorso.

Forse, proprio per quanto riguarda il problema semantico, tutte le idee sembrano convergere verso l'idea dell'ambiguità di principio della musica. A mio avviso si tratta di una idea non del tutto soddisfacente. Un conto è affermare, ad esempio, che serietà e gioco sono due possibilità della musica che richiedono, per essere attualizzate, l'impiego di mezzi e di tecniche di organizzazione del materiale musicale differenti. Un altro è affermare che questo duplice senso può convivere nel musicale in forza di un'ambiguità di principio che non consente di decidere per l'una o per l'altra direzione, e che la musica vive propria di questa oscillazione. Alcune affermazioni di Jankélévitch sembrano presupporre la prima affermazione, ma poi prevale indubbiamente la seconda: l'ambiguità viene considerata come polisemanticità, e questa viene poi intesa come ricchezza inesauribile del senso:
"La musica è dunque inespressiva, non perché non esprima niente, ma perché non esprime questo o quel paesaggio privilegiato, questo o quello sfondo ad esclusione di tutti gli altri; è inespressiva in quanto implica innumerevole possibilità interpretative tra le quali lascia una completa libertà di scelta" (ivi, p. 104).
Ciò che qui non va è il pretendere che la libertà di scelta sia realmente e totalmente “completa”. E ci possiamo avvalere in questa critica degli stessi spunti che ci offre a mani piene lo stesso Jankélévitch. Ad esempio: che senso ha distinguere, come si è fatto, tra la direzione di significato di un legato o di uno staccato se poi si dichiara che all'interpretazione - e quindi al modo di intendere il senso, va attribuita una completa libertà? Coerentemente si dovrebbe ammettere che, a piacere, ad un legato si dovrebbe poter attribuire la stessa nuance espressiva che ad uno staccato. Si risentono qui, al di là di Bergson, i vecchi adagi della teoria dell'associazione: ad un qualunque contenuto può essere associato un contenuto qualunque, purché abitudine ed associazione diano una mano.
Inevitabilmente i luoghi comuni “formalisti” tendono a ripresentarsi piatti piatti. Ad esempio si ripete che “uno stesso testo si presta ad una infinità di musiche radicalmente imprevedibili” (ivi, p. 89); “è impossibile cercare di ricostruire il testo” a partire dal brano musicale, ed inversamente “indovinare la musica a partire dal testo” (ivi, 89).
Ovviamente: si tratta di compiti privi di senso. Ma il punto del problema non sta per nulla nel dedurre un testo dalla musica o la musica da un testo. Nessuno ha mai tentato di fare una cosa simile. Bensì: dato un testo ed una musica considerare in che modo l'uno giochi con l'altra. Questo gioco può avvenire soltanto in forza della capacità di simbolizzazione. Il parlare di ambiguità fuorvia dal problema autentico che è quello della simbolizzazione. Si dovrebbe sostituire il tema dell'ambiguità come qui viene proposto con quello del simbolismo. Nel simbolo certamente l'ambiguità - ovvero la molteplicità di sensi - è certamente contenuta, ma non lo è in una forma tale da far inclinare l'intera impostazione in una direzione in cui la molteplicità diventa infinita e completamente indeterminata.
In effetti seguendo un simile ordine di idee, ci si ricongiunge con un'idea dell'ineffabilità che riconduce ad una indominabile sovrabbondanza di senso. L'ineffabile è “inesprimibile perché su di esso vi è infinitamente da dire” - la vita stessa, e come la vita, la musica stessa, rappresenta un modello di questo ineffabile straricco di senso. L'espressione “senso del senso” - al di là dell'interpretazione che abbiamo or ora proposta, si ricollega alla fine proprio a questa concezione dell'ineffabile.
È superfluo sottolineare che, giunti a questo punto, il tema dell'ineffabilità propende per l'accezione “esaltata” del termine - ineffabile non è soltanto la musica o la vita, ma anzitutto l'“insondabile mistero di dio” (ivi, p. 102). Ed a questo punto non sembra più possibile considerare le tematiche filosofico-musicali di Jankélévitch, come abbiamo tentato di fare finora, in modo relativamente indipendente dal quadro della sua posizione filosofica complessiva. È giusto dunque che il nostro commento si fermi qui, al termine del secondo capitolo del libro, dove cominciano a risuonare le campane: le campane che par di risentire nell'Andante del secondo Quartetto di Fauré -“brusio delle campane lontane portato dal vento dell'ovest in un villaggio dell'Ariège” - e che tuttavia Fauré stesso riconduce ad un “desiderio di cose inesistenti” (ivi, p. 105); così come le campane dell'invisibile città di Kitiez in Rimsky-Korsakov, che “fanno sentire delle armonie udibili” forse perché “la musica del bronzo ha già in sé qualcosa di sovrannaturale” (ivi, p. 106).
Giovanni Piana